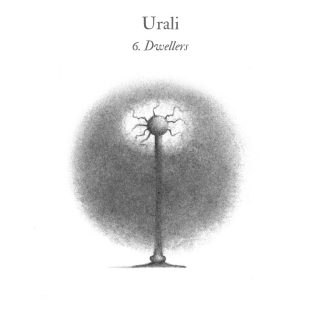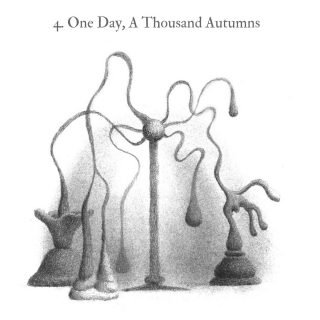E siamo arrivati alla fine di un altro anno, e quindi a un’altra classifica dei miei dischi preferiti di cui, francamente, nessuno sentiva il bisogno: pur tuttavia, le tradizioni vanno rispettate, e quindi eccoci qua con qualche titolo che ha saputo rendere più interessante quest’annata, e sul quale voglio spendere qualche parolina buona (specialmente a vantaggio di chi se lo fosse perso).
The Wonderful Eight + 1 of 2018
Visto che si parla di tradizione, va fatta la solita, doverosa e tradizionale premessa: tutto ciò che leggerete, i vari album e le loro piccole recensioni, tutto quanto sarà posto in rigoroso disordine d’importanza. Questa classifica non ha posizioni! Non è una gara, non c’è un campionato, non si assegnano punti. Astenersi soggetti troppo competitivi. Se proprio dovessi sentire il bisogno di comunicarvi qualche apprezzamento superiore alla media, lo farò nel corso delle prossime, chilometriche recensioncine.
Double Negative (Low)
I Low hanno ormai alle spalle un quarto di secolo di onorata carriera, e al posto loro tanti altri si sarebbero buttati anima e corpo a rifare sempre lo stesso disco, sicuri di poter mantenere uno zoccolo duro di fans che non chiede altro che “l’eterno ritorno dell’uguale”. Ecco, Alan Sparhawk e Mimi Parker non sono così: da 25 anni la loro musica, pur mantenendo un’impronta inconfondibile e totalmente propria, scivola piano piano verso direzioni sempre nuove, lambendo orizzonti di volta in volta diversi, sperimentando, contaminando. Evolvendosi. L’ultimo disco, Double Negative, non giunge come una sorpresa: compie un movimento, pur con un forte scarto, un movimento che era iniziato qualche anno fa con alcuni episodi di Drums and Guns (2007) e in direzione del quale ci si era mossi con decisione in occasione della penultima fatica della band di Duluth, lo splendido Ones and Sixes (2015). In mezzo ci sono state deviazioni, variazioni, ricostruzioni, ma alla fine Double Negative spinge all’estremo la decostruzione dell’intero immaginario sonoro del terzetto proveniente dal Minnesota: la produzione di B.J. Burton conduce l’opera attraverso scenari spogli, desolati, lasciando intatto il cuore sonoro dei brani ma come sezionandolo, sbriciolandolo. Le basi ritmiche diventano pulsazioni distorte, gli scenari armonici apocalittiche distese di droni, e solo le voci (quando non anch’esse decostruite fino ad essere quasi irriconoscibili) sembrano restituire la nostalgia di un tempo che fu. L’inizio del lavoro mozza letteralmente il fiato: Quorum è come un grumo di potenza sonora inclassificabile, un accumulo di tensione che non si risolve in una catarsi ma nell’andirivieni singhiozzante di Dancing and Blood, preludio a un outro corale che sfocia nella melodia limpida di Fly, brano che si spegne in una pulsazione ritmica dalla quale emerge un pianoforte, accompagnato da bagliori accecanti di armonie che tentano di farsi strada, la quieta prima di Tempest, apoteosi di voci sintetiche e rumorismo digitale, esplosiva nel suo finale talmente distorto da essere quasi fastidioso all’ascolto. Non è un caso che il rumore si sciolga in un organo delicato, appena sporcato dai suoni digitali, sul quale le due voci dei coniugi Sparhawk si riuniscono a dipingere l’affresco meraviglioso di Always Up: “I believe, I believe, I believe, I believe/ Can’t you see, can’t you see, can’t you see, can’t you see” canta Mimi Parker nel refrain, e in fondo non serve che questo, la capacità di vedere, quella di non arrendersi anche quando sembra inevitabile. Di fatto Always Up crea una piccola cesura in Double Negative: la successiva Always trying to work it out recupera la tipica costruzione del brano à la Low, gli intrecci di voci, l’incedere ritmico, ma lo fa sporcando la tavolozza, introducendo disturbi e squarciando la tela con distorsioni e rumori. Tutto cambia, sembrano dirci i Low: tutto si evolve. The Son, The Sun è un episodio quasi interamente strumentale, una specie di paesaggio ambient che prelude a Dancing and Fire, in un certo senso sorella di Dancing and Blood (almeno a livello tematico), che però si presenta in una veste decisamente più accessibile dal punto di vista dell’ascolto: una chitarra appena contaminata dall’effettistica su cui si avvolgono le voci, una litania che si spegne nel nuovo rumorismo di Poor Sucker, altro brano che si giova delle solite, splendide armonie vocali di Sparhawk e Parker. Poor Sucker rappresenta uno dei vertici emotivi dell’intera tracklist, per il modo con cui lascia accumulare la tensione nei dettagli del tessuto sonoro, sfogandola in un refrain ostico ma bellissimo: un brano incalzante, tutto costruito sulla potenza delle intuizioni vocali di Alan e Mimi, il vero punto di forza di 25 anni di carriera musicale della band di Duluth. Rome (Always in the dark) ritorna a decostruire apertamente la forma-canzone tipica della band, imbastendo voci erose e smangiucchiate dalle distorsioni sopra una sezione ritmica profonda e possente: un loop di chitarre introduce a Disarray, un up-tempo incalzante che diventa occasione per un intreccio melodioso di linee vocali. “Before it falls into total disarray/ You’ll have to learn to live a different way/ Too late to look back on apocryphal verse/ And to be something beyond kinder than words”, canta Mimi Parker. Di sicuro nessuno ha saputo imparare a vivere in modo diverso ogni volta come hanno saputo fare i Low, che nel corso della loro carriera di vite ne hanno vissute parecchie, transitando dallo slowcore di I Could live in hope al rock crepuscolare di Trust, dalle distorsioni dello splendido The great destroyer fino all’intimismo di C’mon e The invisible way, che hanno canonizzato un certo modo di esprimere il disagio esistenziale attraverso una partitura musicale, per giungere infine ai flirt con l’elettronica che hanno condotto a questo Double Negative, opera che completa una transizione, decostruzione ultima e affascinante di un intero immaginario sonoro. Ci vuole grande forza (e grande coraggio) per portare in fondo un’opera di questa pregnanza musicale e concettuale: ma da chi negli anni ha sempre dimostrato la capacità di ripartire (quasi) da zero ogni volta, non era lecito aspettarsi niente di meno. Ergo, mi rimangio subito quanto scritto in fase d’introduzione e vi dico che, se proprio dovessi scegliere, probabilmente eleggerei questo come disco dell’anno (e non solo per la musica e i testi, ma anche per l’artwork e i video ufficiali, che potete vedere cliccando i titoli dei brani lungo la recensione). Ora sono assai curioso di vederli dal vivo a Bologna, il prossimo 6 Aprile: ci becchiamo là, con chi ci dovesse essere!
A Deeper Sea EP (Everything Everything)
“Someone always has to be the man”, canta Jonathan Higgs in The Mariana, primo brano di questo EP che segue la pubblicazione, avvenuta nel 2017, dell’album più politico (e più sperimentale) della band di Manchester, A fever dream (che non a caso era entrato nel best of dello scorso anno). Ecco, The Mariana non è solo un brano splendido, dal punto di vista strettamente musicale, un brano insolitamente riflessivo e lento per lo stile del quartetto capitanato da Higgs: è un brano importante, in un’epoca come quella che stiamo vivendo. “After reading some shocking statistics on male suicide, we felt inspired to write a new song dealing with male identity and depression”: A deeper sea permette di cogliere l’occasione per affrontare un tema generale a dir poco assente dalla musica mainstream, e che ha a che fare con la debolezza, la fragilità, la solitudine, la violenza del più forte sul più debole, una conseguenza diretta di quella violenza politica (che altro non è che la versione su larga scala della violenza nei rapporti interpersonali) che i nostri hanno sempre denunciato nelle loro opere musicali, e in particolare nel già citato album del 2017. La sensazione di inadeguatezza, la sopraffazione violenta (non solo fisica) che sfocia, ad esempio, nel bullismo, l’odio che distorce i tratti del viso della nostra intera società, il suicidio, sono infatti temi assai poco frequentati in un panorama musicale che si trova particolarmente a disagio con il riconoscimento della debolezza e della fragilità umana in generale, e maschile in particolare. All’importanza del tema in sé va qui aggiunto che la sensibilità e la profondità della scrittura del brano, a livello di testo, rendono The Mariana un piccolo gioiello di sfolgorante valore, e in questo probabilmente la ragione più forte per la pubblicazione stessa dell’intero EP, sebbene non la sola: c’è anche Breadwinner, un brano che recupera le poliritmie elettroniche di A Fever Dream (essendo di fatto una b-side scritta proprio assieme al materiale poi confluito nell’album) e ci riporta in territori più propriamente à la Everything Everything. Come consuetudine per la band, infatti, entrando in Breadwinner si entra in un frullatore di contenuti e ispirazioni in cui si spazia dall’elettronica al post-punk attraverso il complottismo, il terrapiattismo, l’eredità imperialista e colonialista degli stati europei, l’ossessione dell’apparenza, gli abusi del potere, la difficoltà nel decifrare un mondo sempre più complesso in ogni sua manifestazione: un calderone che potrebbe facilmente risultare indigesto e che invece, in mano a Higgs e soci, diventa un post-pop scintillante (e miracoloso). A seguire, Tom Vek ci offre un remix rallentato e apocalittico della già potente Ivory Tower, uno degli episodi migliori di A fever dream, e l’EP si chiude con una riproposizione/rilettura originale (live per la BBC) di Don’t let it bring you down di Neil Young, nella quale Jonathan Higgs, Jeremy Pritchard, Michael Spearman e Alex Robertshaw danno ulteriore prova (se mai ce ne fosse stato bisogno) di aver maturato ormai un linguaggio proprio, autosufficiente, capace di rifrasare in maniera personale anche brani grammaticalmente lontani dal proprio ambito di afferenza. Insomma, ascoltando A deeper sea si ha la sensazione che questo EP non sia rivolto solo ai fan della band (che sono ancora inspiegabilmente pochissimi al di fuori della natia Inghilterra): gli Everything Everything, almeno per chi scrive, sono una realtà di grande forza e valore sin dal debutto, e hanno confermato disco dopo disco di essere portatori di una ricchezza sonora che ha la lungimiranza di mescolare ispirazioni distantissime tra loro (dall’indie-rock, qualunque cosa significhi, all’R’n’B, dall’elettronica all’art-rock, dal funky al soul fino al progressive), frullandole assieme a tematiche la cui profondità si potrebbe definire soltanto inusuale per il desolante panorama odierno. Ecco, consiglio di fare un tuffo in questo deeper sea, e non soltanto per visitare quella splendida fossa delle Marianne (anche se pure quello è già di per sé un motivo più che valido).
Async- Remodels (Ryuichi Sakamoto)
Questo disco, in realtà, è uscito alla fine del 2017, poco dopo Async, che era finito nel mio personale best of dello scorso anno. Come mai allora lo metto qua? Beh, intanto perché l’ho ascoltato in questo 2018… e poi perché il valore dell’operazione è assoluto, e quindi una menzione si rendeva necessaria. Se infatti da un lato Async era un album di musica meditativa, profondissima, che seguiva un lungo silenzio da parte del suo autore e andava a lambire i temi della malattia affrontata da Sakamoto, del dolore, della mortalità, dall’altro appariva evidente come la sua forma fosse di fatto “aperta”: una tavolozza intrisa di colori, un insieme di possibilità, di percorsi, la promessa di una serie infinita di variazioni, un’opera per la quale si rendeva necessaria in qualche modo una nuova grammatica sonora. Ogni volta che si crea una koiné, una lingua comune che permetta di esprimere qualcosa per cui, in precedenza, non si possedevano parole, diventa fondamentale che questa lingua possa essere parlata, fatta propria, da più persone, ciascuna con la propria sensibilità: Async- Remodels non si presenta quindi semplicemente come un disco di “remix”, una neutra riproposizione di uno schema volta semplicemente ad assecondare dinamiche di diversa fruibilità. Questi Remodels sono digressioni, autentiche emanazioni: ogni pezzo viene sezionato, riscritto, espanso, condotto a una dimensione nuova. L’accoppiata di riletture di andata posta ad apertura del disco la dice lunga sui principi ispirativi di questo lavoro: se Oneohtrix Point Never scompone lo splendido giro armonico dell’originale per impadronirsene e restituirlo in forma propria, il successivo Electric Youth Remix ibrida il neoclassicismo pianistico di Sakamoto con la densità ritmica di un synth-pop sfacciatamente anni ’80, luminoso e trascinante, forse una citazione nostalgica di atmosfere alla Yellow Magic Orchestra. Sta poi al compare di scorribande soniche di lungo corso Alva Noto disintegrare disintegration (mi si passi il gioco di parole) in uno stillicidio di piccoli suoni, pause e riverberi che intessono un affascinante tappeto di pulsazioni glitch sul quale le note di piano diventano sparuti grappoli di suono, gettati delicatamente a comporre l’accenno di una melodia. La successiva versione che Arca ci offre della titletrack chiarisce bene come si possa prendere il lavoro altrui, decomporlo totalmente e ricostruirci sopra una tessitura con quello che, di fatto, resta fuori rispetto alla versione apparsa su Async: l’originale di Sakamoto era un gioco percussivo, un caos di archi pizzicati che questa versione trasforma in un intreccio metafisico di voci accompagnato da scricchiolii elettronici. Anche fullmoon è presente in due versioni: l’originale notturno gelido composto da Sakamoto lascia il posto a un saliscendi sonoro fatto di fragorose alternanze pieno/vuoto (o suono/rumore) nel remix di Motion Graphics, mentre è quasi il ritmo di un respiro a tenere insieme la versione di S U R V I V E, anche se un respiro digitale, freddo, diafano, sul quale le parole di Paul Bowles, che accompagnavano la versione originale, recitate stavolta con voce stravolta dagli effetti, si fanno suono a loro volta, parte di un magma denso, pulsante e affascinante. Due versioni anche per la liturgia sintetica di solari: prima rimodellata da Fennesz in una distonia di synth che prelude al recupero del giro originale, una delle cose più belle (e romantiche, e profonde) del 2017, poi riletta da Jóhann Jóhannsson, compianto compositore islandese morto proprio in questo 2018, a nemmeno 50 anni. Proprio quest’ultimo ripropone una solari dilatata, lentissima e vagamente dissonante, trasformando la liturgia cosmica di Sakamoto in una carezza lieve, una sorta di drone music in bilico su panorami di profonda inquietudine. Anche i riverberi di ZURE incontrano due affascinanti riscritture, condotte rispettivamente da Yves Tumor Obsession e Cornelius: zoppicante e inquietante la prima, che sembra racchiudere in sé il respiro di un mare che si gonfia, di onde che si abbattono sulla spiaggia e si ritirano, accumulando una tensione quasi intollerabile; sovraccarica la seconda, piena di squilli sparpagliati, avvolta su se stessa e risucchiata da respiri profondi, che la spezzano introducendo improvvisi silenzi, un tessuto sonoro in bilico tra sfarfalli, barbagli di luce e il vuoto cosmico, pieno di strappi e cuciture. Per chiudere, Andy Stott si occupa di rimodellare la partitura di Life, Life, aprendo al suo interno tutta una serie di evoluzioni sonore che ne fanno un quadro multiforme e variegato, e sottraendo di fatto l’elemento che la rendeva speciale nella versione originale di Sakamoto, ovvero la presenza della voce di David Sylvian che interpretava una poesia di Tarkovskij. Async-Remodels è in questa “classifica” perché mostra prepotentemente come la musica possa vivere (e crescere, e svilupparsi) anche oltre se stessa: essere substrato per lo sviluppo di mille nuove ramificazioni, corpo vivo, caldo e pulsante, aperto alla contaminazione con il contesto, con tutto quanto la circonda. E credo che questa sia una gran bella lezione per tanti.
Scoprirsi stupidi (Mangiacassette)
Mangiacassette lo conosco da tempo (e Lorenzo, la persona che sta dietro il progetto, ho il piacere di conoscerlo anche personalmente), e ha scritto una delle mie canzoni preferite, Vado da Sandro, che parla di una conoscenza comune. In ogni caso, se siete almeno un po’ sensibili, quello che non si può non amare della scrittura di Lorenzo Maffucci, oltre al tessuto sonoro dei brani (che rimanda alla mente tante splendide esperienze musicali del passato e non, da certe cose lo-fi degli Sparklehorse o di Phil Elverum fino a molti cantautori italiani e non, con un pizzico di attitudine punk che male non fa), sono i versi: ora delicati, ora taglienti, stralunati o sospesi, per lo più imprevedibili, tutti i testi di Mangiacassette (e tutti quelli che ascolterete in Scoprirsi Stupidi) sono come piccole poesie, autosufficienti e (in)compiute in sé, capaci di suggerire e mostrare quel tanto che basta per incuriosire, accendere collegamenti, illuminare. Insomma, non dovunque si possono ascoltare versi come “Esistono tanti strumenti/ che l’uomo ha inventato per muoversi/ liberamente nello spazio/ ingannando se stesso e il creato/ ammazzando il tempo o un passante/ ma il discrimine sta nel decidere/ se fermarsi a prestargli soccorso/ o punirlo perché era invisibile”, versi che sono belli, bellissimi e che portano con sé una riflessione tutt’altro che banale sugli uomini che siamo o siamo diventati. Perché forse ci vuole una musica sghemba, fuori centro, ricca eppure povera, semplice ma elegante per svelare qualcosa del mistero del mondo in cui si vive, nel quale ogni rapporto, ogni relazione, ogni nostra posizione sembra essere viziata dalla necessità di corrispondere a un ideale che sappiamo essere irraggiungibile, o anche assurdo, e di fronte al quale magari sarebbe bello, per una volta, riscorprirsi stupidi, come chi non sa e sa stupirsi, restare a bocca aperta, vedere con uno sguardo nuovo. In fondo, mi sembra che in questo disco Lorenzo non faccia altro che disseminare tante piccole perle di stralunata e tenera poesia che cercano di riscoprirci esseri umani, capaci di stupore, amore, illuminazione, immaginazione: è forse quest’ultima, come mi piace ripetere spesso, quella capacità che dovremmo coltivare e di cui dovremmo prenderci sempre maggiore cura, anche come risposta allo spazio che invece sempre più si guadagnano la rabbia, l’incomprensione, l’indisponibilità verso il nuovo, verso l’altro. Certo, è più facile essere pesci che si chiedono “cos’è l’acqua?” (“Buon per chi non si sente solo/ e arriva a stento a chiedersi chi sono/ le persone e la struttura/ che lo sostengono nella biosfera”) che non individui consapevoli e lucidi, eppure forse quello che si può riguadagnare vale la fatica: e quello che rende semplice seguire questa riflessione è la profondissima leggerezza di questi dieci brani, tutti musicalmente splendidi, ricchi di idee (si considerino ad esempio certe digressioni strumentali di Cosa cerchi e Stessa barca) e suggestioni. Per riassumere il senso di ciò che vorrei riuscire a dire con qualche verso di Lorenzo, che sicuramente è più bravo di me ad esprimersi, potremmo dire che “È un buon indicatore/ se ti senti disperato/ vuol dire che non stai fregando/ te stesso e nessun altro/ La traversata ti devasta/ sei davvero sulla stessa barca/ non è più una metafora/ è un oceano di possibilità”. La risposta è probabilmente quella di ritrovare se stessi, ritrovare i propri simili, scoprirsi non più soli, non più sani per forza, riconoscersi, “parlare e definirsi/ fare dei versi/ scoprirsi stupidi”, toccarsi, tornare a guardarsi. Riscoprirsi umani.
Suspiria (Thom Yorke)
Parlare di un disco che è pensato come colonna sonora per un film che ancora non si è avuto occasione di vedere è difficile, oltreché alquanto rischioso; pur tuttavia, di questo album firmato da Thom Yorke voglio parlare, un po’ perché Thom lo conosciamo tutti ed è uno che anche con le proprie uscite soliste ha sempre dimostrato di avere ben più che qualcosina da dire, e un po’ perché, al netto di tutto ciò che può sfuggire o apparire irrisolto in un album di musica pensata per accompagnare delle immagini cinematografiche, questo Suspiria (music for the Luca Guadagnino film) attraversa alcuni momenti di valore assoluto. Innanzitutto, la ricchezza grammaticale, per così dire, dell’operazione: Yorke attinge a piene mani dal minimalismo e, allo stesso tempo, cede a tentazioni di multiforme polifonia, nel tentativo fascinoso di sposare synth dal vago sapore retrò (in particolare, anni ’80) con digressioni in territori di elettronica formalmente IDM o glitch, intessendo tappeti sonori variegati e tratteggiando un’infinità di atmosfere che, qua e là, cozzano anche piacevolmente tra loro. Si va dai synth “ciccioni” e tardo-romantici di Klemperer Walks al minimalismo inquietante di The Hooks, dai cori vocali di Sabbath Incantation al loro contrappunto sintetico nella dilatatissima A choir of one, carica di tensione; dal rumorismo mutazionista di Synthesizer speaks alla deriva retromaniaca di Volk, The Jumps (splendida) o The Room of Compartments, dalle ripetizioni minimaliste che cesellano Olga’s Destruction (Volk Tape) al pianismo irrequieto sostanziato da litanie vocali in odore di polifonia di The conjuring of Anke; dalla mistica vagamente orientaleggiante di The universe is different fino ai droni inquietanti di The inevitable pull (tanto per citarne una). Ma è inevitabile che a restare impresse nella mente siano soprattutto le tracce sulle quali echeggia la voce senza tempo di Yorke: dalla ballad pianistica Suspirium, ripresa con tanto di ricca orchestrazione di archi e dilatata nel tempo in Suspirium Finale, alle ritmiche trip-hop di Has Ended, che mescola Portishead e tentazioni orientali (una specie di lamento di sitar che attraversa l’intero minutaggio) in un melting pot sorprendente scandito nel finale da un basso seducente e azzeccatissimo; dall’arpeggio up-tempo di Open Again, aggrappato a un muro di sinistri suoni sintetici, alla ballatona pianistica che risponde al titolo di Unmade, abbacinante nel dipanarsi della sua struttura armonica. Insomma, è inutile dire che la qualità del lavoro di Yorke è altissima: ovviamente, sarà necessario accoppiare la sequenza dei suoni alle immagini di Guadagnino, per capirne il reale valore aggiunto rispetto alla pellicola. Quel che si può già dire, però, è che Suspiria (music for the Luca Guadagnino Film) è un esperimento affascinante, ricco di echi e suggestioni, un’esperienza sonora addirittura avvolgente e totalizzante se fatta con un paio di ottime cuffie, magari a occhi chiusi: certo, qua e là il lavoro mostra di soffrire un pochino il “formato disco”, con un numero molto alto di brani e un minutaggio vertiginoso, ma resta il senso di una sfida coraggiosa (il confronto con la soundtrack realizzata dai Goblin per l’originale di Dario Argento) affrontata senza timore, con spirito d’avventura e inventiva, caratteristiche che sappiamo essere non nuove per il leader dei Radiohead.
Now Only (Mount Eerie)
I sing to you./ I sing to you Geneviève./ I sing to you./ You don’t exist./ I sing to you though.
When I address you / who am I talking to?/ Standing in the front yard like an open wound/ repeating “I love you”/ to who?
Bastano i versi con sui si apre Tintin in Tibet a chiarire ancora una volta la forza e la profondità dell’immaginario che Phil Elverum cerca di comunicare con questo Now Only, un disco di meravigliose canzoni (su tutte, Earth, con quel formidabile strumming di chitarra ad accompagnare quello che potrebbe essere un ritornello) che segue lo splendido A Crow Looked at me (per me, disco numero uno del 2017): la forza e il coraggio che servono per tentare ancora di dire l’indicibile, di mantenere vivo ciò che ha lasciato questo mondo, un corpo ferito di fronte alla sofferenza più cruda, nudo e indifeso, in possesso unicamente della propria voce e della forza (sconvolgente, questa sì) del proprio sentimento, deciso a mantenere viva l’amata scomparsa con la forza del canto.
Right before you died thirteen years later in our house I remember/ through your gasping for oxygen you explained that you were thinking/ about that high cold air wrapping the globe./ Singing above the mountains of the gods./ And I do picture you there: molecules dancing.
But I’d rather you were in the house watching the unfolding/ everyday life of this good daughter we made/ instead of being scattered by the wind for no reason/ so I sing to you.
Se certe tragedie non hanno davvero una spiegazione, se non c’è un dio da maledire o un destino da incolpare, resta il vuoto del senso: una ferita aperta che non si può medicare, un taglio profondo che suppura, un dolore sordo. Avevo considerato a tratti intollerabile il dolore che traspariva dalle liriche di A Crow looked at me, anche se espresso attraverso le parole, splendide parole, parole necessarie a dare una forma accettabile ad un magma emotivo che, pur tuttavia, possono appena lambire (e che avevo potuto soltanto citare, come sto facendo ora, essendo ben consapevole di non possederne di migliori). Now Only tenta di curare quella ferita attraverso la monodia, costruendo un atlante dei ricordi che possa allo stesso tempo mantenere in vita chi si è amato e perduto, e accarezzare delicatamente il dolore insanabile del distacco:
As my grief becomes calcified, frozen in stories,/ and in these songs I keep singing, numbing it down,/ the unsingable real memory of you/ and the feral eruptions of sobbing,/ these waves hit less frequently./ They thin and then they are gone./ You are gone/ then your echo is gone/ then the crying is gone/ and what is left but this merchandise?
Non giunge a caso la citazione dalla celebre Song of myself di Walt Whitman, che campeggia sulla copertina dell’album (anche se lievemente modificata rispetto ai versi del Poeta, che usava soul al posto di mindstream): “Let yout mindstream stand cool and composed before a million universe!”. In fondo, Now Only mette in musica quella potente intuizione che già Whitman aveva raccontato con la forza della poesia nella celebre lirica O Me! O Life!, e in particolare nei suoi versi finali:
What good amid these, O me, O life
Answer.
That you are here—that life exists and identity,
That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.
Il potente spettacolo continua, e tu sei qui, e puoi contribuirvi con un verso. E anche se la verità è quella della Terra, di un pianeta che continua a ruotare attorno alla sua stella, spietatamente e inevitabilmente, anche se “Everybody/ who used to know us/ seems concerned/ but if they knew that when you enter my mind I am full of the love/ that illuminated our house for all those years/ and made this dancing child who tears through the days/ with a brilliance you would have deepened/ and sang along with/ but you’re sleeping/ out in the yard now”, anche se la verità dei giorni è quella del dolore, del vuoto, dell’assenza, niente può impedire alla parola di tentare di nominare ciò che non ha nome, ciò che non può essere detto, ciò che si trova al di là di tutto ciò che può essere parafrasato, dove solo la poesia può forse giungere, sciogliendo le briglie della grammatica e della sintassi:
If
you
still
hang
in the branches
like
burnt
wood
I will go out beneath
with
arms
reached
and run my fingers through the air
where
you
breathed,
touching your last breath,
reaching through to the world of the gone
with my hand empty.
Come lo stesso Elverum scrive nelle poche note di presentazione del lavoro su Bandcamp, Now Only è un disco di canzoni incentrate sul ricordo e che allo stesso tempo riflettono sull’idea stessa del ricordo: un disco nel quale le varie voci, i ricordi, le conversazioni, i racconti di tour, le riflessioni su un documentario riguardante la vita di Jack Kerouac, tutto concorre a ricostruire un senso della vita che continua dopo una tragedia, fatta di momenti sì e momenti no, di smarrimento, confusione, improvvisa chiarezza. “Time continues”, chiosa Elverum nelle note di presentazione, quasi facendo eco a quei versi di Whitman, “the powerful play goes on, and you may contribute a verse”. La vera forza immaginifica (e quindi, vitale) di queste canzoni non risiede in poche frasi iconiche, nell’uso delle parole o dei suoni, piuttosto nel modo in cui esse si intrecciano a tessere il quadro di una vita intera, che continua. Nonostante il dolore, la morte, la tragedia.
After (Mount Eerie)
Ebbene, c’è un secondo disco di Mount Eerie/Phil Elverum in questo best of. C’è soprattutto perché è un disco strano: un disco che mette a nudo la fragilità, il dolore, l’assurdo, un disco registrato dal vivo in una chiesa, la Jacobikerk di Utrecht, in Olanda, nella quale echeggiano solo una voce e una chitarra. Elverum mette in scaletta praticamente tutto A crow looked at me e parti di Now Only, e improvvisamente la dimensione del canto/catarsi, della poesia che cerca di appropriarsi del senso sfuggente dell’indicibile, della musica registrata in solitudine totale nella camera che era stata lo studio della moglie ormai morta, quella dimensione diventa la dimensione del cantore, una sorta di epica minimalista che si espande, si moltiplica, si diffonde nello spazio, nel tempo, nelle orecchie e nei cuori di chi ascolta. After realizza il miracolo di trasformarci tutti da passivi ascoltatori di un album in persone autenticamente presenti di fronte all’indicibile, trasportando in un rapimento quasi mistico. C’è qualcosa di totalmente stonato negli applausi iniziali, timidi, del pubblico, posto di fronte all’espressione vivente di una tragedia incomunicabile; c’è qualcosa di pungente e stridente in ogni applauso che segue ogni brano; eppure c’è una comunanza palpabile, emotivamente evidente, che cresce come mare che si ingrossa di traccia in traccia, di racconto in racconto, di parola in parola. Di solito non stravedo per gli album live, ma qui ho dovuto fare un’eccezione: l’ascolto delle 12 tracce che compongono After assomiglia a un rito, a una comunione collettiva nella quale il potere della parola di lambire il silenzio diventa evidenza, fatto. Diventa tangibile. Immagino che essere presenti durante questa esibizione debba essere stata un’esperienza totale (e totalizzante): come tale, un’esperienza violenta, estrema, debordante, probabilmente difficile da sostenere. Quello che After riesce miracolosamente a realizzare è proprio questo: far uscire dai solchi la tensione, tutta la forza dei versi intatta, un flusso di coscienza trascinante, una tempesta travestita da carezza. C’è più violenza espressiva in quest’ora di musica per sola chitarra e voce che in decine di dischi noise: c’è una vera esplosione di dolore, una conflagrazione silenziosa, raccolta, un’implosione cieca e profonda, che trasforma i contorni dello spazio e del tempo, distorce le sensazioni. Tutto è un’accumulazione costante e decisa di tensione: adoro soprattutto il silenzio totale del pubblico durante le esecuzioni, e il modo in cui l’intero orizzonte sonoro risuona come corpo cavo delle vibrazioni delle corde e delle litanie della voce, un risuonare profondissimo, enorme, apparentemente infinito. Sembra un miracolo che si possa realizzare un’esperienza sonora del genere solo con una chitarra e una voce che non è poi una voce speciale: una voce incrinata, fragile, gracile, spesso rotta, eppure coraggiosa, indomita, oserei quasi dire. Sembra un miracolo, eppure è vero: After lo dimostra pienamente, a partire dalla splendida immagine di copertina, perfetta espressione grafica del contenuto dell’album, e per ogni singolo secondo di musica che esso contiene. Un disco prezioso, potente e assolutamente irrinunciabile.
Glass (Alva Noto + Ryuichi Sakamoto)
La collaborazione tra Alva Noto (al secolo Carsten Nicolai), compositore tedesco guru della sperimentazione e dell’elettronica glitch, e Ryuichi Sakamoto (altro mattatore di queste mie classifiche di fine anno) è di vecchia data, e conta già i 5 album della serie VIRUS (dalle iniziali dei singoli dischi, Vrion, Insen, Revep, utp_ e Summvs, pubblicati tra 2002 e 2011) più un live (Insen Live, uscito nel 2006). Questo Glass è un prodotto abbastanza atipico, e fin qui niente di nuovo: pubblicato a inizio 2018, dopo una serie di piccole anticipazioni, consta di un’unica traccia per circa 36 minuti di musica sospesa, difficile da catalogare. Nell’arco di Glass trovano spazio tentazioni quasi mistiche, in territori di kosmische musik, condite da suoni dilatati e avvolgenti; ci sono le onde del mare, spazi deformati e una forte tensione che si accresce senza mai risolversi; c’è il glitch, ritmiche erose e piccole precipitazioni ficcanti di pulsazioni digitali; suoni che ricordano lo sbriciolarsi di tanti pezzettini di vetro; c’è il neoclassicismo, echi di archi e persino di strumenti a fiato. Già il titolo non è affatto casuale: la performance contenuta nel lavoro è stata registrata dal vivo all’interno della Philip Johnson Glass House in Connecticut nel corso del 2016, prendendo ispirazione dallo spazio della costruzione e da ciò che poteva essere visto attraverso le pareti di vetro dell’edificio (ed è una pianta dell’edificio che campeggia sulla copertina, minimalista e bellissima), e si tratta quindi di una sonorizzazione site-specific. Noto e Sakamoto danno vita a una successione di immagini, momenti minimalisti fatti di costrutti ripetuti, scene senz’altro lontane dal tipico piglio cinematico di molte delle produzioni del maestro nipponico e che vengono accostate in uno sviluppo ora paratattico, ora effettivamente diegetico; insomma, se David Byrne ci ha spiegato come sia possibile “far suonare un edificio”, Noto e Sakamoto danno voce a uno spazio, lo riempiono di suono e propongono un’esperienza che, per pienezza e completezza, è facile immaginare come debba essere affrontata sul sito per il quale è stata originariamente pensata. Pur tuttavia, la forza dell’operazione è tale che Glass si mantiene in piedi da solo: coinvolge nell’accumulazione di suoni, tentazioni, idee e registri, generando una tensione emotiva che si sostiene fino alla conclusione, passando attraverso una ragguardevole successione di climax in un’operazione che oscilla tra concrete music, musica cosmica e minimalismo glitch per riempire le orecchie di sana meraviglia.
Quest’anno c’è anche un +1, ovvero “Dwellers” e “One day, a thousand autumns” (Urali)
Chiudo con un +1, un’usanza che a volte ricompare in questi miei best of (a volte anche sotto forma di numeri frazionari). Il mio +1 quest’anno è Urali: il disco nuovo non è ancora uscito, uscirà nel 2019, ma Urali (al secolo Ivan Tonelli) lo seguo da molto, è entrato di prepotenza con Persona nel mio best of del 2016 e, soprattutto, ho avuto il piacere di portarlo a suonare alla Biblioteca Eden di Serravalle Pistoiese in occasione della (sin qui) ultima edizione del Biblioledì a Novembre del 2016; dicevo, il disco ancora non c’è ma sono usciti due brani ad anticiparlo, brani che testimoniano di una svolta anche sonora, e che fanno più che ben sperare per l’LP di prossima pubblicazione. Il primo dei due brani è Dwellers, che si apre con la cassa di una batteria, e nel quale le distorsioni e i droni che dominavano le precedenti prove del “cantaudrone” (autodefinizione che mi piace assai, e che quindi mi sento autorizzato a usare) lasciano spazio a chitarre pulite, ritmiche limpide e panorami musicali insoliti costruiti da una vera band, quindi con spazi e geometrie più ampie: l’impressione è immediatamente quella di un respiro diverso. One day, a thousand autumns conferma questa sensazione, riportando nel pezzo le distorsioni e le alternanze pieno/vuoto, ma calandole nel nuovo contesto sonoro: musicalmente, una ballad caratterizzata da un’alternanza di pieni strumentali e passaggi leggeri con pianoforte, o arpeggi di chitarra pulita in bella evidenza di sapore quasi kozelekiano, sui quali la voce possa appoggiarsi delicatamente. Dal punto di vista concettuale, entrambi i brani sembrano parlare di tematiche correlate alla memoria, al ricordo, alla propria posizione nel mondo, nelle relazioni interpersonali, rispetto agli altri. Insomma, due brani che fanno ben sperare in attesa del disco e che voluto condividere qui anche per dare spazio alla migliore musica emergente italiana, uno spazio che la produzione artistica di Urali merita senza ombra di dubbio.
… e per chiudere ci sono i dischi dell’autostrada, 2018 edition!
Sono uno che passa parecchio tempo in auto, come i miei 4 affezionati lettori sapranno già, soprattutto per andare a lavoro, e il mio più fidato compagno di viaggio è un vecchio iPod comprato negli States nel lontano 2008. Oltre ai dischi di cui ho già parlato, sopra questo iPod ci potete trovare di tutto e in particolare quelli che da qualche anno ribattezzo qua sopra “i dischi dell’autostrada”, cioè tutta quella musica (non necessariamente uscita quest’anno) che ascolto più o meno compulsivamente durante i tragitti casa-lavoro. Se ripenso dunque alle andate-ritorni sull’A11 di questo 2018, il primo disco che mi viene in mente è Remain in light dei Talking Heads: dalle ritmiche geniali di Born Under Punches fino a quel gran pezzo che è Once in a lifetime, questo album di Byrne e soci l’ho abbastanza consumato (ammesso che sia possibile consumare degli mp3…). In una fase di deriva mistica, e in particolare su un treno che mi stava portando ad Assisi per assistere ad una conferenza, ho appresso dell’esistenza di Spirit of Eden dei Talk Talk, che probabilmente è il primo album post-rock mai prodotto, curiosamente realizzato da una band proveniente dal synth-pop anni ’80. C’è stato poi (specie all’inizio dell’anno) Slowdive, l’omonimo album del ritorno della band di Neil Halstead, al quale dedicai un paio di righe già nella classifica dello scorso anno, quando gli ascolti erano appena iniziati: un album che aggiorna agli anni ’10 di questo secolo l’estetica shoegaze che aveva reso gli Slowdive una delle band di maggior successo dell’inizio degli anni ’90. Ma, certo, questo non basta: c’è un vortice di suoni spaziosi e melodie di grande presa, tutto intriso da un romanticismo irresistibile: penso a Slomo e mi vengono le lacrime agli occhi, e tutto il resto del lavoro è all’altezza dell’opening. Il rischio di certe operazioni che si potrebbero classificare come operazioni-nostalgia è che sotto le lacrime non ci sia nulla, ma Halstead e soci di sostanza ne hanno sempre avuta da vendere e questo disco lo conferma. Altri must degli ascolti autostradali sono stati Down Colorful Hill e Ocean Beach dei miei adorati Red House Painters, dischi dai quali si proviene e ai quali si continua a tornare come le onde che si spengono sulla spiaggia e tornano all’oceano, prima di tornare ancora e poi ancora: e ogni ritorno è sempre meravigliosamente perfetto. Intorno a Febbraio, ero rientrato in fissa con quel grandissimo disco che risponde al nome di You Forgot It In People dei Broken Social Scene: di ritorno da una delle mie numerose peregrinazioni francesi, sul TGV Chambéry- Milano P.ta Garibaldi, ho scoperto come questi suoni si sposino alla perfezione con il paesaggio innevato del confine franco-italiano, e poi ho continuato a gravitare attorno a pezzi come Looks just like the sun o Pacific Theme, o ancora Anthems for a Seventeen Year Old Girl e Lover’s spit per parecchio tempo, indovinando quanto potessero essere utili anche per immaginare nuovi suoni per la mia band. Non mi sono fatto mancare una buona dose di Boniver, in particolare Bon Iver, Bon Iver (forse il mio preferito dei suoi lavori) e 22, A million; ho continuato a frequentare con piacere Arthur Russell (adoro See through love) e flirtato coi dEUS (in particolare con The Ideal Crash) in preparazione ad un concerto meraviglioso che, purtroppo, mi sono perso (mi riferisco ai miei amati Einsturzende Neubauten dal vivo a Prato il 1 Settembre scorso, con l’accompagnamento di dEUS e Blonde Redhead); sono tornato a consumare i dischi di Franco Battiato, in particolare il trittico di L’Era del Cinghiale Bianco- Patriots- La voce del Padrone, (ri)scoprendo un amore totale e pervasivo per il secondo (Venezia-Istanbul e Prospettiva Nevskij) e, soprattutto, ho ricordato come, da giovane, i R.E.M. fossero sempre stati una delle mie band preferite: tornare ad ascoltare le opere della band di Athens, dalle primissime (che gran disco, Murmur! E pensare che la mia copia in CD la davano in regalo con TV Sorrisi e Canzoni, altri tempi!) fino ai grandi dischi di fine anni ’80- inizio anni ’90, è stato come salire su una macchina del tempo, e ricordare improvvisamente quanto di meraviglioso si potesse nascondere in pezzi notissimi (Imitation of life, Drive) e quante altre cose avessi invece colpevolmente trascurato (ma che album è New Adventures in Hi-Fi? E che pezzo è Nightswimming? E E-bow the letter? E quanto sono ignorante a non essermene accorto prima?). Insomma, Stipe e soci mi mancano. Forse sono semplicemente diventato nostalgico, d’altro canto l’età avanza, ma quando sento le prime note di Daysleeper mi si smuove sempre qualcosa. Era così nel lontano 1998, ed è ancora così. Per chiudere, mi piace ricordare come la mia smodata passione per i Modest Mouse si sia arricchita di un nuovo capitolo, ovvero l’EP No one’s first, and You’re Next (datato 2009) in cui Isaac Brock e soci inanellano almeno tre pezzi che adoro, ovvero l’opening track Satellite Skin, la superba progressione sonica di The Whale Song e soprattutto I’ve got it all (most), il cui secondo refrain, per chi scrive, con le sue semplici ma azzeccatissime armonizzazioni vocali, è qualcosa di quasi commovente. E con questo, credo proprio che siamo giunti ai saluti (dopo un milione di battute, probabilmente). Lasciate che auguri a tutti i voi di trascorrere un sereno ultimo dell’anno e che il 2019 sia un anno sfavillante. Io credo che ci sarà qualche sorpresina musicale da MelaVerde Records, che forse non vorrete perdervi. In ogni caso, mi auguro (per me e per voi che siete arrivati fin qui) che almeno quest’anno possa infine portarmi in dote il dono della sintesi. Buon 2019!