Abbiamo fatto di nuovo una pausa bella lunga, lo so, ma adesso riprendiamo il discorso con un piccolo florilegio del meglio dello scorso agosto, con uno sguardo al presente (e al futuro) e due al passato.
Concentrare in poco più di 2 minuti un’esplosione sonora di violenza incalcolabile, quasi una magmatica eruzione di dissonanze e distorsioni chitarristiche, appena ingentilite dalla vocalità etera di Mimi Parker, e associarla ad un video, diretto da Julie Casper Roth che, come recita qualche press release, esplora metaforicamente “the Sisyphean task of dismantling structural oppression, through gender biases”: non sorprende che ne esca qualcosa di meravigliosamente precario e magicamente coinvolgente, se sei i Low e se questo è l’ultimo singolo che anticipa il nuovo Hey What (al momento in cui scriviamo, pubblicato lo scorso venerdì 10 settembre).
Tutt’altro universo quello che si può ammirare dagli anelli di Saturno in compagnia del buon Cory Wong e dei Dirty Loops, ultima collaborazione illustre del chitarrista di Minneapolis (ultima in ordine di tempo): anche in questo caso c’è un disco, Turbo, uscito lo scorso 3 settembre. Ring of Saturn è un caldo latin jazz vagamente progressive che prende avvio su un pianoforte avvolgente prima dell’ingresso della chitarra di Wong e del basso cadenzato di Henrik Linder; è lo stesso Wong a esporre il tema del brano, contrappuntato dai fiati guidati, come ormai di consueto per Wong, da Michael Nelson. L’assolo del clarinetto di Kenni Holmen apre ulteriormente il brano, dilatandone le atmosfere. Per una volta si mette da parte la potenza travolgente del funk, vero motore di Turbo, e si assapora un’atmosfera jazz di gran classe: se leggete regolarmente questo blog, ormai saprete che Cory Wong difficilmente sbaglia un colpo.
“I’m going to Graceland, Memphis, Tennessee”
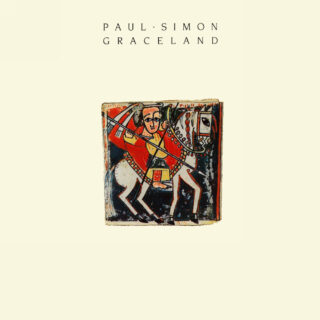
All’inizio degli anni ’80, la carriera di Paul Simon aveva imboccato il più classico dei vicoli ciechi: il rapporto ormai deteriorato con l’ex sodale Art Garfunkel, la fine del matrimonio con Carrie Fisher, e non ultimo l’insuccesso del suo quinto album solista, Hearts and Bones, pubblicato nel 1983 e che, nonostante le forti aspettative che l’artista vi aveva riversato, aveva finito per scontentare pubblico e critica, avevano messo fortemente in crisi il cantautore newyorkese. Non il migliore dei momenti possibili, che però sarebbe culminato, di lì a poco, nel suo disco di maggior successo (almeno fino a quel momento). La storia di Graceland comincia con un’audiocassetta, un bootleg che Heidi Berg (una giovane cantautrice americana, con la quale Simon aveva accettato di collaborare per produrne un album) presta al buon Paul per dargli un’idea di come vorrebbe suonasse il suo disco: la musica contenuta in quella musicassetta strega Simon, che la ascolta per giorni e giorni, comincia a suonarci sopra e a comporre partendo da quelle idee ritmiche. Il bootleg contiene musica africana, in particolare mbaqanga (musica tradizionale sudafricana proveniente dalla regione di Soweto). Simon cerca subito di scoprire, tramite i propri contatti alla Warner, chi siano i musicisti che suonano in quel bootleg: l’intervento di Hilton Rosenthal, producer sudafricano, permette di ricondurre quei brani a band quali i Ladysmith Black Mambazo (alfieri di generi di canto corale a cappella africani chiamati isicathamiya e mbube) o i Boyobo Boys, gruppi musicali provenienti dalle township di Johannesburg, agglomerati urbani abitati per lo più da non-bianchi (quale appunto Soweto, il cui nome altro non è che la contrazione dell’espressione SOuth WEst TOwnship). Simon vorrebbe comprare i diritti per Gumboots, la sua canzone preferita presente in quel bootleg, ma Rosenthal suggerisce al cantautore americano di avvalersi piuttosto dell’opera di questi musicisti africani per registrare, in Sudafrica, un nuovo album ispirato da queste sonorità: per convincerlo, gli invia decine di altre registrazioni di band locali. Negli anni ’80 avere a che fare (e magari guadagnare) con il Sudafrica aveva un po’ il sapore della compromissione col regime dell’Apartheid: tuttavia Simon decise di andare in Sudafrica, seguendo il suo primo istinto e forte del fatto di non stare andando nel paese per supportarne il governo o le politiche razziali. Un sostanziale incoraggiamento gli giunse anche da Quincy Jones e Harry Belafonte, produttori di We are the world, singolo a cui proprio in quel periodo Simon aveva contribuito, tra gli altri artisti. Ovviamente il rapporto con Heidi Berg, non appena la cantautrice realizzò come Simon le avesse non troppo elegantemente scippato l’idea (si narra che, dopo aver ricevuto il famoso bootleg, l’artista fosse sparito rendendosi irreperibile), andò deteriorandosi e la collaborazione tra i due non decollò mai. Decollò invece un modo completamente nuovo di concepire la musica: Graceland rappresenta, al pari di alcune realizzazioni di Brian Eno e dei Talking Heads, uno dei primi esempi compiuti di world music, di musica che incorpora (e in questo caso occidentalizza) stilemi e motivi tipici di culture sparse ai vari angoli del globo. Il tema è quantomeno controverso, si capisce, come d’altra parte controversa fu l’accoglienza del lavoro a seguito del suo colossale successo commerciale: il collettivo degli Artists United Against Apartheid, tra i quali spiccavano Billy Bragg e Paul Webber, definì l’atteggiamento di Simon nei confronti della questione sudafricana quantomeno naif, superficiale; lo stesso Belafonte, che aveva incoraggiato inizialmente Simon, ricorda di aver suggerito al cantautore di discutere di questa materia con l’African National Congress (ANC, il partito politico di Nelson Mandela), ricevendo una risposta diretta dal buon Paul al momento del release party dell’album: “I’m with the artists. I didn’t ask the permission of the ANC. I didn’t ask permission of Buthelezi, or Desmond Tutu, or the Pretoria government”; James Victor Ghebo, ex ambasciatore ghanese alle Nazioni Unite, disse della faccenda che “When he goes to South Africa, Paul Simon bows to apartheid. He lives in designated hotels for whites. He spends money the way whites have made it possible to spend money there. The money he spends goes to look after white society, not to the townships”, anch’egli ricevendo un sostanziale benservito da Simon, che gli fece notare come non avesse preso un soldo per suonare solo per bianchi e avesse diviso regolarmente tutte le royalties coi musicisti coinvolti nel progetto, trattati assolutamente da pari; molti denunciarono l’assenza di espliciti riferimenti politici e sociali nei testi delle canzoni, aspettandosi una denuncia veemente dell’apartheid pur sapendo bene come un certo tipo di cantautorato impegnato non fosse propriamente nelle corde del musicista newyorkese, e mentre il comitato anti-Apartheid delle Nazioni Uniti supportò Graceland per aver portato alla ribalta molti musicisti africani senza offrire alcun appoggio ad un governo giustamente considerato criminale, l’ANC votò per il bando di Simon dal Sudafrica (aggiungendolo ad una blacklist di persone indesiderate nella quale restò incluso almeno fino al 1987) e veementi proteste, guidate ancora soprattutto da Weller e Bragg, accompagnarono i concerti londinesi del tour di Graceland (e ancora, tanto per far capire quanto le polemiche siano ben lungi dall’acquietarsi, i concerti del venticinquennale dell’album tenuti nel 2012). La domanda è scomoda, ovviamente, però è lecito chiederselo: Graceland rispose/risponde a una visione sostanzialmente coloniale del mondo? Si trattò di una semplice appropriazione culturale? Questo album di Paul Simon, al pari di diversi lavori più o meno coevi di Peter Gabriel (So, ne abbiamo parlato qui), Talking Heads (Remain in Light) o anche Brian Eno (assoluto precursore di questo genere di contaminazioni), prende elementi provenienti da culture musicali africane, quindi decisamente altre, e li inserisce in un contesto pop, sostanzialmente occidentale (e sicuramente, e in maniera molto miope, eurocentrico): come ogni iniezione di diversità in un substrato stantio, anche questa creò una ricchezza inattesa e incalcolabile, e non bisogna dimenticare come l’esperienza di Graceland fornì a molti musicisti africani (dal formidabile Bakithi Khumalo, come lui stesso ricorda in questa intervista, a Miriam Makeba, che accompagnò Simon in tour) l’occasione di raggiungere una ribalta altrimenti difficilmente immaginabile per popoli costretti al margine della narrazione culturale. Come spesso accade, la realtà sta nel mezzo: e se può sembrare naif leggere certe dichiarazioni di Paul Simon (“What was unusual about Graceland is that it was on the surface apolitical, but what it represented was the essence of the anti-apartheid in that it was a collaboration between blacks and whites to make music that people everywhere enjoyed. It was completely the opposite from what the apartheid regime said, which is that one group of people were inferior. Here, there were no inferiors or superiors, just an acknowledgement of everybody’s work as a musician. It was a powerful statement”), è altrettanto vero, come fatto notare altrove, che “Apartheid was of course a monstrosity, but it would be absurd to suggest that Simon’s introduction of South Africa’s music to the world prolonged it and quite plausible to suggest that it did some small amount to hasten its undoing” (questa frase viene da una recensione pubblicata su Uncut, citata da Wikipedia: la maggior parte dei virgolettati provengono proprio da Wikipedia, perché i link originali sono spesso interrotti e di conseguenza le pagine irraggiungibili).
Ma cosa contiene questo album che, a 35 anni dalla sua pubblicazione, costituisce ancora una pietra miliare nella musica pop (nonché una collezione di musica veramente meravigliosa da ascoltare)? La collaborazione di Simon con questo manipolo di straordinari musicisti africani (oltre al già citato Bakithi Khumalo, mi preme ricordare lo straordinario chitarrista Ray Phiri e gli stessi Ladysmith Black Mambazo, ma la lista è enorme), corroborata da alcune comparsate illustri (su tutti: Steve Gadd), produce un album che è soprattutto un generoso mix di generi che spaziano dal pop al rock, dalla musica vocale (isicathamiya) alle ritmiche mbaqanga fino a una peculiare fusione di blues, rhythm’n’blues e musica tradizionale della Louisiana che prende il nome di zydeco, con qualche lieve venatura folk a impreziosire circa tre quarti d’ora di autentica gioia per le orecchie.
In apertura si trova The Boy In The Bubble, un formidabile duetto tra l’accordion suonato da Forere Motloheloa e lo strepitoso basso fretless accarezzato da Khumalo, quasi un fiato aggiunto, trascinante e irresistibile, un episodio baciato da liriche di estrema bellezza (cito solo il ritornello, These are the days of miracle and wonder/ This is the long distance call/ The way the camera follows us in slo-mo/ The way we look to us all/ The way we look to a distant constellation/ That’s dying in a corner of the sky/ These are the days of miracle and wonder/ And don’t cry baby, don’t cry, don’t cry, in cui c’è tutto, l’amore, lo straniamento, il senso del miracoloso, la differenza profonda tra quello che vediamo e quello che davvero c’è); c’è la galoppante title-track, dove il basso magico di Khumalo si intreccia con le note sparpagliate dalla chitarra di Ray Phiri e Paul Simon non deve far altro che cantare un testo intimista che parla di un viaggio a Graceland, la tenuta di Elvis Priesley, nel bel mezzo della sua recente crisi matrimoniale (Carrie Fisher, che come accennato all’inizio da Simon si separò proprio poco prima dell’uscita dell’album, disse che questa canzone parlava senza dubbio del loro rapporto): un country intarsiato da una pedal slide guitar (suonata da Demola Adepoju) dispersa a distanze siderali, col basso che letteralmente fa il pezzo (specialmente nei ritornelli); I Know What I Know, incalzante con una linea di basso che è anche un incredibile finger-twister (per quanto apparentemente semplice), prende ispirazione dalla musica di band come General M.D. Shirinda & Gaza Sisters, esperienza musicale che combinava vocalità femminili, tradizione africana e ritmiche quasi disco; e c’è Gumboots, l’origine di tutto questo lavoro, quasi un ibrido ska-afromusic, con i sassofoni di Barney Rachabane, Mike Makhalemele e Teaspoon Ndlela a disegnare innocenti evasioni in bilico tra rispetto filologico e reinvenzione giocosa. La splendida Diamonds on the Soles of Her Shoes taglia in due il lavoro, introdotta da un formidabile coro Zulu isicathamiya gestito dai Ladysmith Black Mambazo: in bilico tra groove (c’è anche Youssou N’Dour alle percussioni) e fiati fusion, con il valore aggiunto del fretless di Bakithi Khumalo, ancora in versione fiato solista, e gli intrecci chitarristici schizofrenici di Ray Phiri, Diamons on the Soles of Her Shoes è il racconto di una strana storia d’amore, ancora un tema piuttosto umile e consueto, come quello di quasi tutti i brani. Se, da una parte, Graceland insegue e magnifica la differenza del suono, dall’altra tenta di istituire una koiné del sentimento: i suoi testi parlano, come detto, di amori, tormenti, solitudini, difficoltà comunicative, uno zibaldone intimo di sentimenti personali che, però, sono anche e soprattutto pienamente universali. A Diamonds on the Soles of Her Shoes fa seguito il primo singolo estratto dall’album, l’irresistibile You Can Call Me Al, la chitarra di Ray Phiri che si arrampica sul groove implacabile di Khumalo e della sezione ritmica, i fiati che punteggiano i ritornelli, per un brano che (oltre che per il celebre video con Chevy Chase) passa alla storia anche per quello che è forse il bass-break più famoso mai inciso: secondo la viva voce dello stesso Khumalo, “There’s a story! The day we recoded it was my birthday, May 10, 1986. In the studio, we played the groove and then there was that break and Paul said, “Let’s take a break. Let’s break for lunch.” And I said, Paul, it’s my birthday today. Can I just play a little bit more on the part where there’s a break?” And Paul said, “Go ahead. If it’s good, we’ll keep it.” I wasn’t slapping the whole thing, but when it came to that break, I just used my slapping because in the studio, the fretless sounded unbelievable! When I started to slap the bass, the engineer recognized that idea and came up with the backwards tape effect. Then he took the two bars and looped it. After we came back from lunch he said, “Listen to this!” He was going crazy! That engineer was a big part of my bass lines. It turned out to be a great piece.” Phiri e Simon scrivono insieme gli arrangiamenti di Under African Skies, che Paul Simon canta a due voci con Linda Ronstadt (altra generosa fonte di critiche per questo lavoro, ai tempi: la Ronstadt aveva suonato, solo tre anni prima, in Sudafrica presso il resort di lusso Sun City per un evento chiaramente indirizzato ad un pubblico di soli bianchi, percependo un ricco cachet; la sua presenza nel disco fu letta da molti come uno schiaffo al movimento anti-Apartheid, sebbene Simon l’abbia sempre difesa sostenendo che avesse commesso una leggerezza): il brano scorre tra passaggi soul e deviazioni trasognate, con un testo che parla del potere della musica. Homeless è invece un brano interamente vocale in cui la scena se la prende Joseph Shabalala, leader dei Ladysmith Black Mambazo, e Paul Simon ritaglia per sé un ruolo di seconda voce: la potenza evocativa degli intrecci vocali costituisce allo stesso tempo forse il passaggio più apertamente politico dell’intero lavoro, laddove i versi cantati dai Ladysmith e da Shabalala, un po’ in lingua zulu e un po’ in inglese, sembrano richiamare proprio la sensazione di sradicamento dalla propria terra (homeless, d’altronde, è il titolo) e la lotta dei popoli per emanciparsi dall’oppressione e dalla violenza del potere (in questo caso, con un chiaro riferimento all’apartheid). Crazy Love, Vol. II è sostenuta da uno splendido ostinato del basso, che però credo di aver capito non sia stato suonato da Khumalo ma da Lloyd Lelose, mentre sono di Phiri gli intrecci chitarristici a tratti quasi caraibici che fanno da tappeto per l’ennesimo racconto di amori incrinati che innerva il testo di Simon, impreziosito da melodie vocali affascinanti e decisamente toccanti. That was your mother pesca da quella insolita miscela di rhythm’n’blues, musica cajun e blues che in Louisiana prende il nome di zydeco: suonata da un manipolo di musicisti tutti americani, sembra rispondere alla musica tradizionale africana con una sua declinazione nata su suolo americano, che però in realtà è più un fragoroso ibrido tra lo zydeco e un foxtrot ad altissima velocità. Chiude il lavoro All Around the World or the Myth of Fingerprints, con Steve Gadd alla batteria, l’ultimo giocoso giro di giostra che frulla insieme rock’n’roll, country e atmosfere da America profonda, rurale.
Forse la chiave per comprendere l’intera operazione di Graceland è racchiusa nel suo titolo, come giustamente in diversi hanno notato: Graceland, un nome evocativo per quella che è semplicemente una tenuta, appartenuta al Re del Rock’N’Roll; ma anche il cifrario che permette di ammantare di leggenda e rendere immortale qualcosa che, semplicemente, è quotidiano, che si tratti di una villa abitata da una leggenda della musica americana o di mille piccole storie di amori, scorni e dolori quotidiani che sono poi le parole e i temi di cui i testi di Simon sono composti. Si tratta, a ben vedere, di una poetica che cerca di estrarre l’universale dal particolare, con una profonda attenzione alle radici: la ricerca musicale che spinge Simon verso la musica africana ha di certo a che fare con la passione per questi ritmi, per questi suoni inusitati verso i quali, spesso, il palato anestetizzato dei consumatori di musica occidentali non ha particolare inclinazione, ma anche, e soprattutto, si lega a una ricerca di radici, di fondamenta, di origini. Quasi ogni parte della musica pop che oggi ascoltiamo è derivata, a ben vedere, dalla musica degli schiavi africani: in un certo senso è bello ascoltare nell’Olimpo del mainstream pop occidentale quegli stessi musicisti che, suonando quello che sanno suonare, e cioè la musica che essi stessi hanno creato come mezzo privilegiato d’espressione, si riappropriano un po’ di quello che gli spetta. Il livello della scrittura, della composizione e dell’esecuzione nelle 11 tracce di Graceland è siderale, e supportato anche da una qualità di registrazione veramente alta e che permette ancora oggi, a 35 anni di distanza dalla sua pubblicazione, di godere di ogni sfumatura del sound imbastito dai formidabili musicisti di cui Paul Simon si è circondato: avrete capito che il disco è pieno di ragioni per essere ascoltato ma (e ve lo dico da bassista) se neanche una di queste dovesse avervi convinto, penso che dovreste ascoltarlo comunque perché è probabilmente, dal punto di vista del basso elettrico, uno degli album pop più straordinari che possiate incrociare, raffigurazione plastica del talento infinito di un bassista incredibile. Foss’anche soltanto per ascoltare Bakithi Khumalo che fa cantare il suo fretless, ne varrebbe assolutamente la pena.
“Searching for my brother, Yes I am”

Colgo infine l’occasione per ricordare, sommessamente ma non troppo, che agosto ha segnato anche il primo mezzo secolo di vita di un disco straordinario sotto un numero di punti di vista difficilmente calcolabile, ovvero Tago Mago, primo risultato di studio vero e proprio dei Can nella formazione storica composta da Damo Suzuki alla voce, Irmin Schmidt alle tastiere, Holger Czukay al basso, Jaki Liebezeit alla batteria e Michael Karoli alla chitarra. Tago Mago è un capolavoro di psichedelia acida che degrada lentamente dentro un concentrato sonoro magicamente capace di pescare a piene mani da avanguardia, Stockhausen e urgenza rock. Se l’opening di Paperhouse prepara il terreno, e ci mostra una band quasi composta, impegnata a rispettare un rigoroso minimalismo in cui non si aggiunge niente più del necessario e il solo Karoli compare in bella mostra quando i cambiamenti di mood del brano impongono incontrollate esplosioni hard-blues, contenute soltanto dal drumming matematico, glaciale ed esatto del formidabile Liebezeit, è con lo strano funk-dub compresso e al tempo stesso esploso di Mushroom che i Can iniziano a debordare: Damo Suzuki comincia a salmodiare quasi colto in una trance mistica, trascendente, alternando mormorii a vere e propria urla, e la macchina ritmica imbastita da Schmidt/Czukay/Karoli e soprattutto da sua maestà Liebezeit scandisce implacabile lo scorrere di un tempo pienamente lisergico. Un tuono e un rumore di pioggia introducono Oh Yeah, con il synth di Schmidt a rincorrere Liebezeit che, con qualche anno d’anticipo, inventa quel motorik che diventerà il 4/4 marchio di fabbrica di tutto il krautrock a venire: Czukay percuote le fondamenta del brano con un basso devastante, e i synth di Schmidt si avvolgono attorno alla ritmica inesausta e incessante di Liebezeit, mentre la voce di Suzuki si decompone in un magma elettronicamente filtrato, sinistro e angosciante. Oh Yeah è una successione di vuoti, rincorse, pieni luminosi: presto Karoli si aggiunge con una chitarra acidissima, dalle venature blues, che va a intarsiare di caleidoscopiche dissonanze i contorni di una macchina ritmica in moto perpetuo. Sarebbe già abbastanza, ma fin qui si stava solo spianando la strada verso il capolavoro, i quasi 19 minuti di Halleluhwah, probabilmente uno dei pezzi più assurdi (e incredibili) prodotti negli anni ’70: una band che “da creativa e coraggiosa […] si fa pure spaventosa. E mastodontica” e mette sul piatto del giradischi un delirio reiterato di funk suonato in stato di trance, un groove portato con grazia devastante, di potenza pachidermica eppure serrato, che ti si appiccica addosso; un magma oscuro e lisergico sconquassato dal metronomo umano Liebezeit che, oltre a disegnare col fil di piombo (o il puntatore laser, se preferite) la spina dorsale ritmica del pezzo, sempre, incessantemente e inesaustamente uguale a se stessa, a un certo punto lascia andare le mani verso una tempesta concentrica di divagazioni percussive che sono quasi altrettanto stranianti e psichedeliche del salmodiare estatico e alterato di un Suzuki che deambula in evidente stato di ipnosi. Le porte della percezione sembrano spalancarsi sopra un abisso fatto di ritmi enormi, esposti con una magniloquenza groovy che ha pari forse soltanto in certi esiti dei Funkadelic, chitarre acide che producono suoni dell’altro mondo, violini strapazzati, panorami sintetici visionari, bassi profondissimi, un’onda di marea sonora che torna e torna e torna, finché Suzuki non comincia a urlare “Searching for my brother/ Halleluhwah” e Karoli a blueseggiare come una nave alla deriva sulla tempesta ritmica. Insomma, immaginate di prendere i Funkadelic e mettergli nelle mani un unico groove, granitico, da ripetere per 19 minuti filati dentro una specie di tunnel sonoro in cui intervengono gli elementi più disparati, dissonanti, deviati, psichedelici, e forse avrete un’idea di cosa sia il trip allucinogeno di Halleluhwah: ma quello che soprattutto travolge è la potenza ritmica di Liebezeit, inarrestabile, un’autentica drum machine umana (come lessi da qualche parte qualche anno addietro), e il modo in cui il suo groove si spenge lentamente nel silenzio, rallentando impercettibilmente poco prima con una naturalezza dell’altro mondo mentre torna a udirsi la voce di Suzuki, è ancora qualcosa di impressionante.
Ecco, se inanelli quattro brani di questo tenore di solito un disco si può considerare finito: e però se hai per la mani un gigantesco trip sonoro in bilico tra luce e oscurità e ti trovi proprio nel bel mezzo del guado, non puoi fermarti così. Allora Tago Mago divenne un doppio disco e l’oscurità prese la forma dei suoni sinistri e spettrali di Aumgn, una sequenza di rumorismi prodotti da tastiere, violini violentati e chitarre irriconoscibili. Schmidt ci mette la voce, un lamento che attraversa, monocorde e opaco, gli spazi disegnati dai clangori e gli stridii quasi da concrete music prodotti dagli strumenti musicali: Aumgn diventa un’odissea esoterica alla Faust o un flusso di libera improvvisazione musicale come quello che, qualche anno dopo, gli Area perseguiranno (memori degli insegnamenti di Fluxus e John Cage) in tracce come Caos (Parte II) dal live Event ’76, un potentissimo delirio psicotropo strettamente confinante con un sordo baccanale percussivo, che esplode in tutto il suo fragore negli ultimi 5 minuti del brano. Il sabba di Aumgn lascia spazio a Peking O, aperta da un organo e da uno scintillio di suoni sintetici e riverberati, con Suzuki intento a cantare melodie che non trovano appoggio in nessun luogo, divagando su un tappeto ora celestiale ora infernale di echi e saturazioni: a un certo punto la batteria sembra percuotere il cantante, che urla come in preda a una possessione demoniaca, e un acido tappeto di synth si srotola sotto una bossa nova ad altissima velocità, gestita da una batteria sintetica anch’essa, impossessandosi del campo sonoro. Gli spasmi accelerati di piano jazzy e batteria creano un ritmo alieno, straniante, continuamente mutevole: proprio la natura cangiante del brano ne fa un oggetto misterioso, un ibrido in evoluzione, un’astronave governata da un pilota che sembra aver perso l’orientamento e aver deciso di attraversare in pochi femtosecondi un intero universo di possibilità. I suoni smettono addirittura di essere suoni, a un certo punto: la batteria diventa un caricatore esploso con violenza contro il pianoforte jazz che cerca di rincorrere i vocalizzi insensati di Suzuki, scariche di mitra che rompono la possibilità stessa dell’idea di una quiete dentro una polveriera extra-dimensionale. Non c’è spazio per una distensione, Peking O sembra voler essere una canzone senza però davvero volerci riuscire, auto-sabotandosi allegramente dentro il suo stesso continuo mutare. A chiudere il trip, giunge Bring Me Coffee or Tea: chitarra e synth tratteggiano un panorama delicato, sul quale Czukay domina con una linea di basso imponente, e Liebezeit torna a dipingere ritmiche quasi umane. Siamo di fronte a un manufatto di origini e connotazione ignote: non è rock, non è pop, non è più funk e non è nemmeno world music, ma un po’ un curioso frullato di tutto questo, un ibrido totale che la band di Colonia ci lascia in eredità come l’ennesimo mistero. Czukay fa parte ritmica e parte melodica insieme, Liebezeit imperversa mentre Schmidt e Karoli si ritagliano un ruolo da raffinati cesellatori, il tutto ad accompagnare l’ennesimo delirio di un Damo Suzuki ormai ufficialmente posseduto.
Tago Mago è un disco completamente folle, un labirinto nel quale perdersi è ancora oggi meraviglioso: una musica da camera, forse, ma per camere molto ampie; una musica da orizzonti espansi eppure allo stesso tempo minimale fin quasi a sconfinare nella meccanizzazione (quell’effetto che più tardi cercheranno di riprodurre, con l’ausilio dell’elettronica, gruppi come i Kraftwerk). Alla bellezza di 50 anni dai primi vagiti di questo album, quello che davvero ne racchiude in pieno la potenza è la consapevolezza che Tago Mago, ancora oggi, sembra un disco uscito domani, un viaggio verso una direzione completamente ignota, un oggetto misterioso precipitato da un futuro forse spaventoso ma, allo stesso tempo, irresistibilmente affascinante. Di sicuro, uno dei miei dischi preferiti di sempre.
