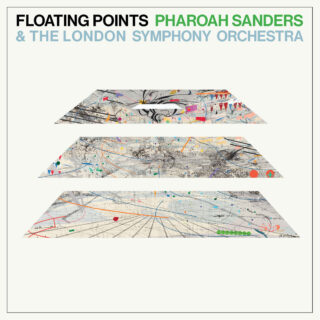Pharoah Sanders è un musicista che non ha bisogno di presentazioni: per lui parlano meglio di ogni riassunto le collaborazioni e i rapporti artistici intrattenuti in 60 anni di carriera, che vanno dagli esordi con Sun Ra alla partecipazione ad alcuni degli album più estremi dell’ultimo John Coltrane (Ascension e Meditations), dai lavori con Alice Coltrane a quelli con Ornette Coleman, Don Cherry o Carla Bley (per il celebre album Communications della Jazz Composer’s Orchestra, nel 1968), per non parlare dei numerosi album pubblicati a proprio nome. Pharoah Sanders appartiene alla storia del jazz e della musica colta contemporanea, ed è una delle grandi voci dell’improvvisazione free. Sam Shepherd (in arte Floating Points) è uno dei più interessanti musicisti elettronici in circolazione: proveniente da Manchester, con un background fatto di studi di pianoforte e una laurea in neuroscienze e epigenetica, fulminato sulla via di Damasco dai pianisti impressionisti francesi come Debussy, da Bill Evans e Kenny Wheeler e infine dalle sperimentazioni di Karl-Heinz Stockhausen, ha dato alle stampe due lavori di grande interesse fatti di ambient e minimalismo, Elaenia (nel 2015) e Crush (nel 2016). Come da tradizione, quasi nessun punto di contatto tra i due, non fosse che proprio da un casuale ascolto di Elaenia da parte di Sanders nasce un incontro, fortemente voluto dal sassofonista americano: Promises è il frutto di questo incontro, che sposa le composizioni di Shepherd col sassofono tenore di Sanders e, a completare un ideale triangolo, con gli archi della London Symphony Orchestra.
Promises è innanzitutto dialogo, un dialogo svolto tra un sassofono inquieto e una distesa placida di note snocciolate dal piano e dai synth: lungo i 9 movimenti che compongono questa suite si incontrano più spesso il silenzio e grandi spazi vuoti che altro, come se l’assenza, la pausa, la sospensione, fossero in tutto e per tutto le reali portatrici di quelle promesse citate nel titolo del lavoro. Movement 1 è un oceano ambient fatto di onde di synth increspate dal sassofono di Sanders, nel quale incontriamo il vero protagonista del lavoro, un breve cluster di note di piano che costituisce il leitmotiv di tutta la suite. Movement 2 si sviluppa naturalmente dal primo movimento, così come Movement 3, episodio lungo il quale il sax di Sanders lascia maggiore spazio agli interventi dell’orchestra filarmonica e a quelli sintetici di Shepherd. Su Movement 4 arriva il mormorio di una voce, che poi altro non è che uno scat dello stesso Sanders: come scritto altrove, è la voce di un vecchio ma sembra il primo vagito di un bambino, ed è proprio da questa profonda trasfigurazione che Promises trae la sua maggior forza (e il suo fascino), la capacità di rompere la separazione tra il vecchio e il nuovo, tra lo stilema del passato e la ricerca timbrica che prelude al futuro. Anche quest’uso di “puro suono” che della voce fa Sanders conferma la struttura di base del lavoro, nel quale è sempre come se ogni strumento inseguisse la stessa ispirazione, magica, nebulosa e sospesa, tratteggiando melodie elusive che portano alla mente addirittura qualcosa dei Popol Vuh, qualcosa di mistico e religioso, tanto quanto gli ovvi riferimenti dell’ambient e del free-jazz. Tra Movement 4 e Movement 5 torna il sassofono a prendere per mano la composizione, divagando delicatamente, raggiungendo una sorta di apice emotivo a metà del quinto movimento, un vertice rarefatto eppure improvvisamente luminoso. Movement 6 riemerge sulfurea da un piccolo fade, come provenisse da una distanza, sempre adagiata sul minimalista arpeggio di piano che scandisce tutto il percorso: al sassofono si affiancano gli archi della London Symphony Orchestra, e in questo panorama gelido, nel quale tutto appare distante, comincia una specie di crescendo pulsante, che si deve soprattutto ai bordoni degli archi, come se tutto quanto è stato compresso premesse per riversarsi fuori tutto insieme a un certo punto; qui per un attimo la composizione abbandona il free-form ambient che flirta col jazz per aprirsi verso un’autentica magia, un magistrale (ed emozionante) pieno d’orchestra. Quando la tensione diviene infine insostenibile, la tempesta sonora si spegne quasi nel silenzio e con Movement 7 riemerge il minimalismo del riff principale, arricchito però da piccole risonanze che flirtano col glitch, su cui Sanders può tornare a improvvisare un melodicissimo solo che va lentamente a sfaldarsi mentre cresce un tessuto di droni, pallidi rintocchi e pieni sintetici. In Movement 8 la composizione si stacca infine dal suo leitmotiv, e il cluster si spegne su una tempesta organistica, fatta di piccole dissonanze e di un crescendo sonoro che in realtà (lo si riconosce quasi subito) altro non fa che modulare la tensione imposta dal cluster stesso portandola su un ulteriore livello, quello che sta sulla soglia del silenzio; Movement 8 precipita letteralmente nel vuoto, più ancora che in una semplice assenza di suono. Il movimento conclusivo, Movement 9, sembra alimentarsi di questo silenzio profondissimo e irreale per disegnare un pieno d’archi che chiude il lavoro come un’ultima, inattesa tempesta.
È giusto riconoscere come Promises sia, a dispetto dell’apparente gelida freddezza, della sua struttura minima, ridotta all’osso, un album intenso fin quasi ad essere commovente: la musica oscilla tra l’ambient puro (alla Brian Eno, per intendersi), il rigido minimalismo della sua pulsazione portante (il cluster di cui parlavo), che sembra venir fuori da certe composizioni di Steve Reich, e la tempesta free che emerge dal sassofondo di Sanders, improvvisazione che riporta tutto entro la linea di sviluppo più prettamente jazzistica, ma ci sono anche elementi della sinfonia, per quanto spoglia, quasi disadorna (volutamente), e un elemento puro di religiosità e misticismo che rimanda alla mente lavori di band come i già citati Popol Vuh (lo splendido Hosianna Mantra, per esempio, di cui a volte Promises sembra quasi una versione scarnificata, ancora più eterea). Promises è un disco in cui ci sono tantissimi strumenti e che pure risulta lieve, quasi impalpabile a tratti, in cui il suono emerge lottando contro il silenzio, e ogni pausa è così intenzionale da essere pregna di significato, di portato emotivo: ed è nell’intensità di ogni intervento e di ogni nota suonata che nasce quel senso di quasi commozione che questi 9 movimenti lasciano nell’ascoltatore. Lungo tutto l’album c’è uno sviluppo sospeso di tre voci: una prima, informata di minimalismo elettronico, portata dalle note sparute e sintetiche di Floating Points; una seconda, che parla free-jazz, e che discende ovviamente da Sanders; e un’ultima, che ha una componente sinfonica, orchestrale. Magicamente, il totale si conferma essere ben più della banale somma delle parti: Promises propone un jazz minimalista, rarefatto, ambientale, che sa però essere anche sinfonico, ricco di un trasporto che è soprattutto intellettuale, di un’espressività “al calor bianco”. Le tre voci principali si relazionano tra loro come in un problema a molti corpi (tre, in particolare), applicato però alla composizione musicale. Il riff insistito su cui poggiano tutte le composizioni funziona di fatto da accumulatore di tensione (in questo senso, la lezione del minimalismo è espressa in maniera potentissima e totalmente consequenziale), e sopperisce alla mancanza di supporti percussivi operando una glaciale e precisa dissezione dello spazio e del tempo, isolando vuoti e grappoli di suoni, lasciando respirare questo piccolo cluster di note e facendo di questo respiro il ritmo interno, incessante e inequivocabile, di questi 9 movimenti, un respiro che è centro d’attrazione attorno al quale gravitano tutti gli altri suoni sprigionati nella partitura (proprio il ricorso a questa struttura di cluster, l’uso stesso dell’idea del cluster esprime un’intenzione artistica rivolta primariamente verso la manipolazione di un linguaggio che è prettamente jazzistico, il tutto restando entro l’orizzonte sfuggente di una profonda contaminazione e sperimentazione tra linguaggi). Sicuramente le promesse che danno il titolo a questo peculiare lavoro sono le molte, inattese e gravide divagazioni che i musicisti scelgono di percorrere lungo i 46 minuti di questo racconto sonoro: un paesaggio irreale, tratteggiato con mano sapiente, senza svelare niente del suo intimo segreto. È difficile parlare in maniera netta di una musica che è quasi impalpabile, tanto è eterea: Promises è infatti molto di più di queste parole, è anche una partitura complessa, atonale, in cui un cluster di note fa da scansione ritmica, imponendo una sorta di pulsazione di contrappunto su cui si adagiano il tempo e i saliscendi delle improvvisazioni, gli interventi di Sanders e degli altri strumenti. Non solo il livello della scrittura e della composizione, ma anche quello dell’esecuzione sono altissimi, quasi stellari: il linguaggio che informa Promises è un linguaggio complicato, anche criptico a tratti, difficile da maneggiare e da manipolare, che pesca da mondi spesso molto distanti tra loro tentando una sintesi ambiziosa che riesce felicemente e ne fa soprattutto un disco affascinante, sul punto di esplodere eppure magicamente trattenuto, in cui tutto si gioca sul labile equilibrio tra suono e silenzio, nel quale l’apporto di tutti i musicisti è studiato sempre senza strafare e a nessun elemento si permette di prevalere sull’altro, ma ogni parte è funzionale a creare un tutto, un flusso unico. Come potrete immaginare, quindi, Promises è un disco che richiede attenzione, come tutta l’ambient ben fatta, che domanda un impegno emotivo e intellettuale all’ascoltatore: un’esperienza totalizzante che sfida chi ascolta a concedere senza riserbo tutto il proprio tempo, la propria mente, il proprio cuore.
musica, cinema, arte, poesia