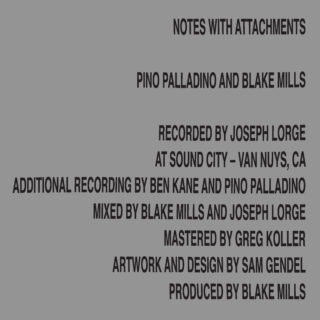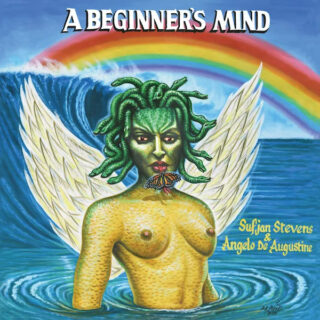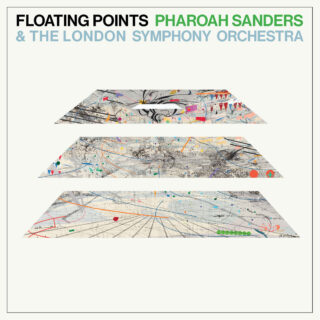Anche il 2021, al pari del 2020, è stato un anno difficile da dimenticare (figurarsi questi ultimi giorni, trascorsi per me in quarantena): un po’ come accaduto nel 2020, però, anche quest’anno il blog è stato una possente valvola di sfogo dalle tensioni del lavoro e della vita ai tempi delle restrizioni dovute alla pandemia, e non posso che essere grato di aver avuto questo spazio per parlare liberamente di ciò che davvero mi piace. Anche quest’anno ho scritto molto: per quantificare, nel 2021 Arcipelaghi ha ospitato, con questo, 40 post, appena due in meno rispetto allo scorso anno, e quindi il quarto numero più alto dopo i 60 del 2008 e i 49 del 2009, rispettivamente secondo e terzo anno di vita di questo blog (che è nato nel Novembre del 2007 e che ai tempi era ospitato dalla benemerita piattaforma Splinder). Allo stesso tempo, la nostra piccola ma agguerrita community Facebook (che contava lo scorso anno circa una sessantina di persone), si è arricchita di una decina di unità e anzi, se volete dare un’occhiata e magari anche unirvi, basta schiacciare l’iconcina di Facebook in alto a destra sulla pagina, oppure nella colonna sinistra del blog: non mordiamo nessuno e vi aspettiamo a braccia aperte! Ma ora bando alle ciance di circostanza, e tuffiamoci di testa dentro una tradizione che accompagna queste pagine ormai dal lontano 2014, il best of dei dischi dell’anno!
Ed ecco a voi l’11 titolare di Arcipelaghi per il 2021!!
Consueta premessa per i Cristiano Ronaldo della musica: qui non si fa a gara, non ci sono competizioni, non ce ne sbatte una beata minchia di chi sia il chitarrista (ovviamente metallaro) che sa fare gli assoli più tecnici e con la cascata di sessantaquattresimi più veloci e nitidi a 240 bpm, né tanto meno ci interessa distribuire pagelle. Astenersi narcisisti e drogati di competizione. L’elenco procede come di consueto per lo più a braccio, tipicamente a caso quando non regolarmente a cazzo. Anche quest’anno è stato abbastanza difficile compilare questa lista, perché di dischi ormai tendo ad ascoltarne diversi (e scorrendo indietro i post ve ne renderete conto da soli): alcune rinunce sono state dolorose. Cercherò di essere breve (più del solito) specie considerando che ogni disco che citerò ha sul blog un suo post dedicato (al quale troverete rimando). In ogni caso, nell’eventualità che ci fosse qualcosa che mi abbia sconquassato i precordi più della media, non mancherò di farvelo notare: di solito non sono avaro con le parole.
Kontinent (Janne Mark with Arve Henriksen)
Recensione completa qui: The sound of the world in the form of a hymn
Formalmente questo disco è uscito nel 2020, quindi non dovrebbe stare in questo “Best Of”: tuttavia, io ci sono arrivato tardi, e allora eccolo qua; se proprio volete, potete considerarlo come il mio +1 di questo 2021. Secondo episodio della collaborazione tra la cantante e compositrice danese Janne Mark e il trombettista jazz norvegese Arve Henriksen, Kontinent è, per me, uno dei migliori dischi ascoltati negli ultimi 12 mesi: un ideale punto d’incontro tra la musica sacra, il jazz sperimentale nordeuropeo, la musica tradizionale e il pop sinfonico, con una qualità esecutiva di un altro pianeta (oltre a Mark e Henriksen, si segnalano Henrik Gunde al piano, Esben Eyermann al contrabbasso, Nils Økland all’herdingfele, strumento tradizionale norvegese, e Bjørn Heebøll alla batteria). Episodi come l’opening Altid allerede elsket, Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, la coppia di brevi Psalm for a tree (Pt.I e Pt.2) o il romanticismo conclusivo di Længselsvise sono occasioni nelle quali il suono della lentezza e del silenzio produce mondo, una ricchezza che vale la pena contemplare, cui, religiosamente, è un piacere abbandonarsi. “I am fascinated by the borderlessness that melody represents. Melodies, when shared among people in communal singing especially, disregard borders and fringes, and have a way of finding a path of their own” , dice la Mark: Kontinent raggiunge la terraferma solo vagheggiata in Pilgrim, il precedente album collaborativo di Mark e Henriksen, ma è un terreno misterioso e affascinante, un continente inesplorato di suoni e timbri e reminiscenze di musiche dai quattro angoli del globo. Un terreno misterioso, e quindi fecondo, che viene abbracciato in tutta la sua ricchezza: che si tratti del solo quasi jarrettiano di Henrik Gunde, che si rincorre con il contrabbasso di Eyermann in Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, o della profondità oceanica dei rintocchi percussivi di Bjørn Heebøll che accompagnano il brillante minimalismo di Both In The World And Yet Outside It; del fraseggio etereo e sentimentale di Henriksen, onnipresente e veramente indimenticabile, o delle insolite risonanze prodotte dall’hardingfele, che tanto spazio creano all’interno di queste composizioni; dell’esplosività delle linee ritmiche suonate dal contrabbasso di Eyermann o della potenza della voce di Janne Mark, capace di esplosioni luminose quanto di dolorose contorsioni, sono in ogni innumerevoli le diramazioni che Kontinent riesce a prendere, percorrere e suggerire scivolando magicamente nel mondo attraverso il potere della pura melodia.
Dawn (Yebba)
Recensione completa qui: Con amore e dolore
Il primo album solista di Yebba (al secolo, Abigail Elizabeth Smith), pubblicato lo scorso settembre per la produzione di Mark Ronson è uno dei debutti più fulminanti cui mi sia capitato di prestare orecchio negli anni. Le qualità dell’autrice erano già indiscusse, la lista delle sue collaborazioni lunghissima e basterebbe citare solo il Grammy vinto nel 2019 insieme a PJ Morton nella categoria Best Traditional R&B Performance per dare l’idea del valore dell’artista: ma Dawn, che prende il titolo dal nome della madre della Smith, morta suicida pochi anni fa, spinge un passo più in là la dimensione artistica della sua autrice. Le dodici tracce dell’album sono un lungo discorso attorno alla morte, la separazione, l’elaborazione del lutto: in larga parte composto insieme all’amico e pianista jazz James Francies, Dawn accompagna l’ascoltatore in un doloroso percorso di elaborazione (It’s two years, mom/ I still can’t figure it out, canta la Smith in Paranoia Purple) che possa condurre, attraverso l’amore, verso un futuro più luminoso. Il disco abbonda di momenti musicali abbacinanti, favorito anche dal coinvolgimento di musicisti di primissimo piano (cito solo Questlove e Pino Palladino), oscillando tra r’n’b futurista (How Many Years), dolcezza soul (Stand) e piccole deviazioni verso il folk (October Sky), senza farsi mancare qualche passaggio nel rap (Louie Bag, cantata con Smino, e la meravigliosa Far Away, con A$AP Rocky): tutto conduce al dittico finale composto dalla splendida Distance (Questlove e Palladino sugli scudi) e soprattutto da Paranoia Purple, forse il brano più personale del lotto (ay now, when my life is over/ Will you find somebody good enough to hold ya?/ Someone like my Abigail/ To tell you all is good and well like me now/ Say now, I feel my color show how/ I think it’s almost time for me to go now/ Go now, go now). Se è vero, come scriveva David Foster Wallace, che “la realtà è che morire non è brutto, ma dura per sempre. E per sempre non rientra nel tempo.”, ci vuole coraggio per tentare di esprimere qualcosa di completamente altro, inesprimibile quasi al limite del silenzio.
Notes with Attachments (Pino Palladino + Blake Mills)
Recensione completa qui: Ritorno al Mondo Nuovo
Il nome di Pino Palladino aleggia nella storia della musica dagli anni ’80 inoltrati, e il suono del suo Music Man Stingray fretless ha marchiato a fuoco (rendendoli indimenticabili) decine di capolavori del pop (per i pochi che non abbiano idea di cosa stia parlando mi limito a citare la celeberrima Wherever I Lay My Hat di Paul Young, manifesto del Palladino-sound). Come sessionist, Palladino ha contribuito a un numero quasi incalcolabile di album, dal celebre Voodoo di D’Angelo alla partecipazione al trio di John Mayer con cui ha dato alle stampe, tra gli altri, lo splendido Continuum; dalla collaborazione con Eric Clapton al suo ingresso in pianta stabile nella formazione degli Who: ci vorrebbe un post a parte solo per elencare tutte le sue collaborazioni. Arrivato alla prima prova “solista”, però, il bassista gallese di origini molisane ha scelto di cogliere l’occasione per fare di questo lavoro la conferma dello schema che sembra esser stato sotteso a tutte le scelte artistiche compiute in carriera: circondandosi di collaboratori di livello altissimo, con in prima linea il produttore e polistrumentista americano Blake Mills, versato soprattutto nel jazz e nella sperimentazione sonora, il nostro ha dato alle stampe questo splendido e peculiare Notes with Attachments, un lavoro autenticamente collaborativo che coinvolge un insieme di 13 musicisti, caratterizzato da una chiassosa eterogeneità di ispirazioni, suoni e digressioni, un’opera la cui modernità assoluta risiede principalmente proprio nella leggerezza e sapienza con la quale riesce a fondere generi diversi, mondi musicali “altri”, in una lunga suite ibrida di otto movimenti che sono un manifesto di contemporaneità, un suono dell’oggi e del domani nel quale si mescolano jazz, percussioni afro-cubane, funk e lirismo mediterraneo in un mosaico al tempo stesso immaginifico ed elusivo. Tra suggestioni fusion (Just Wrong), notturni jazz-funk (Soundwalk), ibridi di world music tribalista e free-jazz (la meravigliosa Ekuté), intermezzi melodiosi lungo i quali il fretless di Palladino può, letteralmente, cantare (la titletrack), il funky dal sapore balcanico e mediorientale (Djurkel) e persino un bizzarro, affascinante progressive alt-rock/jazz (Chris Dave), Notes with Attachments è più il lavoro collettivo di una big band di 13 elementi che il disco solista di un musicista eccezionale, un lavoro in cui la sensibilità dei musicisti, la fluidità dell’interplay e un discorso fondamentalmente centrato sul groove (è pur sempre l’opera prima di un formidabile bassista) riescono a fermare in musica l’inafferrabilità del legame tra mondi distanti, creando ponti e connessioni che conducono verso una koiné minimalista per un mondo nuovo, che è già qui.
Kinfolk 2: See the Birds (Nate Smith)
Recensione completa qui: Il jazz come ritorno
Se si parla dei più importanti batteristi della nostra contemporaneità, il nome di Nate Smith non dovrebbe mai mancare dalla lista: il buon Nate, che suona e ha suonato con tutti i migliori in circolazione (Vulfpeck, Fearless Flyers, Cory Wong, Jon Batiste, Dave Holland, Randy Brecker, Chris Potter ecc. ecc.), è però anche un raffinato compositore, dedito soprattutto ad aggiornare e rileggere il linguaggio per eccellenza della nostra contemporaneità, quel jazz dal quale egli per primo proviene, ibridandolo con tutta quella musica che ha fatto parte del suo background culturale e musicale (l’hard rock dei Living Colour, il pop di Michael Jackson e Prince, il soul, il funk e l’R’n’B fino a Sting). Le undici tracce di Kinfolk 2: See the Birds (seguito di quel Kinfolk: Postcards from Everywhere pubblicato nel 2017) perseguono quindi lo scopo di creare un racconto musicale che componga una sorta di biografia, lungo la quale il passato si ponga come porta principale da attraversare per poter immaginare un futuro; o, se si vuole, un viaggio a ritroso verso il domani. Dal vocalese be-bop di Michael Mayo che accompagna Altitude al rap aggressivo della bellissima Square Wheel, dal solo di chitarra à la Metheny di Brad Allen Williams su Street Lamp al romanticismo notturno di Collision (guidato dal violino di Regina Carter e dal sax del fantastico Jaleel Shaw), dal devastante ibrido funk/hard-rock di Rambo: The Vigilante, con Smith intento in un serrato dialogo coi riff asimmetrici della chitarra di Vernor Reid, alla meravigliosa rilettura di I Burn For You di Sting con la voce di una straordinaria Amma Whatt fino al jazz di Fly (For Mike), Kinfolk 2, fedele alla suggestione che porta a immaginare nel termine stesso una fusione tra le parole kinetic e folk, tiene in qualche modo insieme l’incisività “fisica” di questa musica, la sua pregnanza che si dispiega nello spazio e nel tempo (kinetic), e il suo essere allo stesso tempo ancorata alla tradizione (folk), quasi come fosse un nóstos, una sua celebrazione e contemporanea, esuberante reinvenzione. Suggestioni che spingono la tradizione dentro il futuro: Kinfolk 2: See the Birds è musica che supera le categorie, integralmente cinematica nel suo cogliere il ricordo nell’atto costruirsi, la memoria nell’atto del suo farsi, e poi c’è da contare la qualità degli strumentisti della band di Smith e degli ospiti che fa il resto, conferendo al lavoro un ulteriore valore aggiunto e facendone un autentico instant classic.
Dog Years (The Night Game)
Recensione completa qui: Del tempo trascorso e del tempo perduto
Dopo un omonimo album di debutto del 2018, e l’uscita dalla band del chitarrista Kirin J. Callinan, The Night Game è diventato il moniker dietro al quale si cela e opera il polistrumentista, autore (per gente tipo Taylor Swift e Jason Derulo) e produttore Martin Johnson: Dog Years è il secondo lavoro licenziato sotto questa etichetta, ed è uno splendido, assurdo concentrato di pop music d’autore, che strizza l’occhio alle sonorità elettroniche degli anni ’90. Nella sua inesausta ricerca della canzone pop perfetta, Johnson attraversa queste 11 tracce con la sua aria da buffo guascone, un improbabile, irriducibile e indimenticabile ribelle senza una causa, autoironico quanto basta da inscenare balletti nel video di I Feel Like Dancing ma sempre senza rinunciare a un piglio da chansonnier e da narratore di storie. Ecco, ci sono soprattutto le storie in questo bizzarro album di elettro-disco-pop: Johnson racconta la grande periferia americana, la vita di ogni underdog, uno dei tanti sconfitti con la loro umanità, in un disco che parla di rimorso, dolore, perdita e di quanto possa far paura crescere, un buffo zibaldone intimista pieno di escursioni deliziosamente “tamarre” in un elettro-pop di chiara ascendenza nineties. Dal ritmo irresistibile della già citata I Feel Like Dancing alla ballad romantica Magic Trick, dal duetto di Companion (con Elle King) all’ironica critica sociale sui rapporti interpersonali drogati nell’era dei social network contenuta in Our Generation (benedetta da una linea di basso memorabile del grande Sean Hurley, che suona su tutte la 11 tracce e regala diverse perle, soprattutto al fretless); da One Phone Call alla dolorosa Dancing In Heaven, fino alla strepitosa UFO, confessione sotto forma di ballad pop-rock sporca e malinconica rivolta a tutti gli underdog del mondo (se volete sentire come si fa cantare un fretless, ascoltate cosa fa Hurley qua sopra) e alla conclusiva, splendida A Postcard From The City Of Angels, ottimistica espressione del desiderio di cambiare, migliorare, crescere (nonostante la paura) e vivere una vita più vera e reale (il lavorone sugli arrangiamenti dei fiati, qui come in altri passaggi dell’album, si deve a Brandon Paddock). Prodotto da un’artista che si propone con una sincerità disarmante, buffo e malinconico al tempo stesso, un po’ anti-eroe vagamente tamarro che veste come Kavinsky e accenna passi di danza alla Michael Jackson (si vedano i video di I Feel Like Dancing o A Postcard from the City of Angels: a un certo punto, durante quest’ultimo, scorre anche l’insegna del Million Dollar Hotel, e se non è una dichiarazione d’intenti questa…) e un po’ uomo tormentato che compone liriche piene di immagini di straordinaria forza ed esattezza, Dog Years è un capolavoro di pop che tiene insieme il racconto esistenziale e il citazionismo quasi feticista per gli anni ’90 col suo songwriting ora malinconico ora esuberante, che mette in musica una disarmante, umanissima voglia di autenticità. A qualcuno parrà solo tamarro, ma io lo amo dal primissimo ascolto.
Turbo (Cory Wong & Dirty Loops)
Recensione completa qui: High-Speed Funk
Un disco del buon Cory Wong nella mia top dell’anno ci finisce sempre, puntuale come un orologio… svedese: lo so, l’orologio sarebbe svizzero, ma si dà il caso che Turbo sia il disco collaborativo tra il buon Wong e la band svedese dei Dirty Loops (la voce strepitosa e le tastiere di Jonah Nilsson, il formidabile basso di Henrik Linder e il drumming tagliente di Aron Mellergård), coadiuvati dai fiati degli Hornheads (Steve Strand, John Lampley, Kenni Holmen, Grace Kelly e Michael Nelson). L’effetto che fa è quello di uno Striped Album accellerato, sospeso tra urban funk e omaggi al pop “michaeljacksoniano“, ora palesi (la fantastica rilettura di Thriller), ora sapientemente celati nelle pieghe del racconto (come in Follow The Light). C’è energia da vendere nelle sette tracce di questo album, 30 minuti scarsi di funk ad altissima velocità: lo splendido pop-funk di Follow The Light, benedetto da un lavoro di Linder al basso che fa letteralmente spavento (folle assolo compreso), il sound classicamente Wong-oriented di Turbo, la bossa nova lieve e malinconica di Ring Of Saturn, il miglior manifesto della modernità e della contemporaneità del concetto di fusion, ma anche il contrappunto matematico messo in scena in Hardtop e Hästråtta, il blitz sonoro di ZAP, manifesto di libertà compositiva ed esecutiva, e soprattutto la micidiale riscrittura del grande classico di Michael Jackson, Thriller. La Thriller di Wong e soci non è però una banale cover, ma musica nuova, pulsante, ri-plasmata per impadronirsene ed espanderla: Linder reinventa il noto basso continuo che faceva da sfondo al classicone del Re del Pop, Nilsson ci mette le Jackson-vibes necessarie e gli Hornheads contrappuntano delle sezioni strumentali espanse e nuove di zecca, che danno ancora più “spazio” al testo originale. Questa Thriller è al tempo stesso atto d’amore per un brano che si considera classico inarrivabile e manifestazione del desiderio di scomporlo, ricomporlo, arricchirlo, metterci del proprio, (s)travolgerlo e reinventarlo, plastica applicazione del concetto di musica che sottende questo progetto e che, personalmente, trovo grandemente affine alla mia visione personale: una ricerca musicale che consista nel cercare costantemente nuove strade per raggiungere anche a luoghi più noti. Wong è come sempre formidabile nel creare l’occasione, circondandosi di collaboratori di altissimo livello, i Dirty Loops ci mettono la loro irriverente e maestosa qualità strumentale (Linder fa letteralmente paura, ma questo ve l’ho già detto) e gli Hornheads di Nelson fanno il resto, fornendo un inesausto background per sostenere le infinite trovate ritmico-armoniche di Wong, Linder, Nilsson e Mellergård: il tutto in una dimensione autenticamente collettiva, nella quale ciascuno sia libero di esprimersi e dare il proprio contributo. Turbo conferma Wong come un’artista con una visione, attributo dei soli grandissimi, e trovo che questa sua visione della musica del futuro sia estremamente seducente.
A Beginner’s Mind (Sufjan Stevens & Angelo De Augustine)
Recensione completa qui: Home is where you’ve called my name
L’incontro tra Sufjan Stevens e Angelo De Augustine, propiziato da un mese di isolamento nella tenuta in montagna di Bryce Dessner dei National, ha prodotto questo piccolo gioiello di folk lo-fi nel quale le 14 tracce sono ispirate da altrettanti film (ognuno visto la sera prima di stendere l’ossatura del brano corrispondente) e grondano ispirazioni che, oltre al cinema, vanno dalla filosofia zen all’i-ching, fino al buddismo. Già il titolo, A Beginner’s Mind, si rifà a un concetto caro alla filosofia buddista: “Nella mente del principiante vi sono molte possibilità, nella mente dell’esperto soltanto alcune” , e soprattutto il “principiante” deve ricordare di mantenere sempre la mente aperta al nuovo, senza idee preconcette e senza atteggiamento giudicante. Solo in quest’ottica una serie del tutto casuale di film (molti dei quali horror, o film che parlano di serial killer) può spingere alle riflessioni esistenziali che Stevens e De Augustine mettono in musica e in (splendide) parole in questi quattordici brani: dal lieve alt-folk di Reach Out a Lady Macbeath in Chains, che profuma di Elliott Smith, dal groove alt-pop di Back to Oz alla litania di The Pillar Of Souls, dall’ironica ballad You Give Death a Bad Name alla splendida quasi-titletrack Beginner’s Mind, sonata per piano e voce che mette in musica e poesia il narrato di Point Break con momenti di abbacinante splendore (tanto musicale quanto letterario); dal surf-rok di Olympus alla smithiana Murder And Crime, dal sound Stevens-oriented di (This is) The Thing alla ballata dream-folk It’s Your Own Body And Mind; dallo psych-folk di Lost in the World al pop divertito (e nostalgico) di Fictional California, fino al piccolo gioiello folk di Cimmerian Shade, immaginaria epistola che il serial killer Buffalo Bill invia a Jonathan Demme, regista che lo ha messo in scena ne Il Silenzio degli Innocenti tradendone la vera natura e identificando nel suo essere transgender il solo movente della sua violenza criminale (Fix it all, Jonathan Demme/ Beauty resides where your spirit dwells: il rapporto tra l’artista e l’opera d’arte come mai era stato raccontato) e all’eterea e inquieta Lacrimae. A Beginner’s Mind è una strana bestia, del tutto simile alla curiosa creatura raffigurata nella sua cover, opera dell’artista ghanese Daniel Anum Jasper: sospeso tra elettronica lieve, alt-folk, dream-pop, denuncia della decadenza culturale di un paese, gli Stati Uniti, che Stevens racconta da anni, e lirismo cantautorale, frutto di una sensibilità (anzi, due) profondissime che consentono di fruirne a molteplici livelli, atto d’amore verso il film come mezzo d’espressione e allo stesso tempo spunto per la riflessione e la digressione anche mistico/religiosa/filosofica (in fondo Stevens un po’ millenarista lo è), A Beginner’s Mind racchiude un condivisibilissimo auspicio a riscoprire e a ricongiungerci con la nostra perduta umanità, in tempi che si fanno ogni giorno più bui.
Mirrors (Mirrors)
Recensione completa qui: “I am silver and exact”
Mettere insieme un supergruppo prendendo cinque artisti di livello mondiale e chiudendoli tutti insieme sotto lo stesso tetto in Alentejo (Portogallo) nell’agosto del 2020, mentre infuria la pandemia globale: nasce così il progetto di Mirrors, nome della band composta da Becca Stevens, Gisela João, Justin Stanton, Michael League e Louis Cato e anche nome di questo primo full-length, composto di dieci brani scritti a quattro mani dai musicisti, a due a due, come accadeva nel vecchio LP The Telluride Sessions, realizzato da un supergruppo di musicisti bluegrass nel 1989 e che Stanton, motore primo del processo insieme alla João, cita come riferimento per questa scelta compositiva: Mirrors è la miglior risposta a un mondo in cui le distanze crescono, a volte inevitabilmente (penso alle restrizioni dovute alla pandemia) altre volte invece colpevolmente (i muri con i quali tanti sciroccati pericolosi pensano di proteggere il proprio privilegio dalle ondate dei tanti senza niente che chiedono solo dignità: una metafora che va dai migranti alle minoranze schiacciate di tutto il pianeta), una risposta fatta di interplay, di ricerca di un linguaggio comune, e la musica che contiene è musica autenticamente world, ricca di suggestioni, ascendenze, riferimenti. C’è il pop tribalista e percussivo di Can’t Stop Moving, la malinconica ballad un po’ in portoghese e un po’ in inglese di The Call, sulla quale duettano la João e Cato; il pop-fusion di Say It, scritta da League e Stanton e piena di sonorità in odore di Snarky Puppy, e il rock-pop quasi beatlesiano di Sleep; le tinte sudamericane di Una Rosa e il pop luminoso di Over The Line, con una superba performance vocale della Stevens; il pop elettronico quasi minimalista di Weary e la magniloquenza sinfonica e in cinemascope di I Don’t Blame the Wind, scritta a quattro mani da Stevens e João; il romantico duetto piano-voce di Tempestade, con la João che strappa ancora applausi, e la conclusione affidata a Life is Fine, tra minimalismi elettronici marcati Stanton e un’altra performance da brividi della Stevens. Nello spazio di dieci tracce, Mirrors propone un percorso e tratteggia una mappa del mondo nuovo, il mondo nel quale abitiamo: è quasi una cartografia dei tempi assurdi che viviamo, una mappa disegnata per ricordarci cosa ci unisce, cosa ci tiene insieme, per cosa valga davvero la pena combattere. Pescando a piene mani dal jazz, dalla fusion, dalla musica del mondo, con l’ombra malinconica del fado che si proietta su molti di questi brani, e flirtando con il linguaggio del pop, perché è a un mercato pop che questo lavoro si propone, Stanton e soci mettono insieme uno dei lavori più ispirati dell’anno, nel quale la qualità strumentale (iperuranica) dei musicisti si sposa a una maestria compositiva non comune, producendo quello che forse si potrebbe definire addirittura l’album pop perfetto, quello che parla tutte le lingue del mondo, e la lingua dell’umanità che ci accomuna tutti.
HEY WHAT (Low)
Recensione completa qui: La ferita e la sutura
Giunti al terzo capitolo della loro fruttuosa collaborazione col producer BJ Burton, Alan Sparhawk e Mimi Parker, rimasti soli dopo l’uscita dalla band del bassista Steve Garrington, non avevano che una strada davanti a sé: concludere l’opera di decostruzione musicale avviata con Ones And Sixes e condotta all’apice nello splendido Double Negative. HEY WHAT giunge allora per portare alle estreme conseguenze la già profondissima astrazione sonora sperimentata dalla band di Duluth in Double Negative, e che sfocia adesso in un’affascinante alternanza di dissonanze, aperture liriche e improvvise mareggiate di violenza sonica: il discorso sul dolore che trovava compiuta espressione in una sorta di accecante terrorismo sonoro nell’album precedente, in questo HEY WHAT crea piuttosto un enorme maelstrom, una zona di buio quasi impenetrabile rannicchiata un passo indietro rispetto agli intrecci vocali di Sparhawk e Parker, vero centro emozionale del lavoro e nuovamente protagonisti. Piccola avvertenza: non dovete aspettarvi dai Low un ritorno al passato. Lo slowcore sognante e malinconico che la band ha contribuito a codificare è ormai un ricordo lontano, anche un po’ sbiadito: HEY WHAT ne contiene un simulacro, la radiografia, spogliata di orpelli, lo scheletro ritmico (prossimo al silenzio) sul quale le voci combattono per emergere, umane. Il beat percussivo e rumorista sul quale si snocciola White Horses prelude al drone di chitarra che fa da sfondo alla splendida I Can’t Wait, un’onda anomala di feedback che distorce tutto attorno a sé ma resta, magicamente, sospesa al di sotto, come il ruglio del mare custodito dentro le valve di una conchiglia; All Night è un loop lanciato in reverse devastato dai feedback temporaleschi della chitarra, e Disappearing è insieme suite minimalista e compiuto manifesto di desertificazione sonora intesa come grammatica espressiva: poco più di 3 minuti che racchiudono in sé l’intero senso di cosa è la musica dei Low oggi, un intero universo in un guscio di noce. Hey è un free-form vicino a certe intuizioni dei Radiohead elettronici (ad esempio Treefingers), mentre Days Like These ha la forza e la pregnanza emotiva di un inno (intonato rigorosamente a due voci) e dopo un inizio insolitamente pulito nei suoni, distorsioni, elettricità statica e scariche di feedback incorniciano la seconda metà del cantato, per sfociare nella parte finale del brano, largamente strumentale, in una sorta di riflessiva elegia ambient per bassi profondissimi e tastiere sognanti, baluginii di eternità che vagheggiano un’ideale quiete dopo la tempesta. Il suono rotante di There’s A Comma After Still ne fa l’ideale Like Spinning Plates di questi strani anni ’20, ed è il magma dal quale germoglia l’elegia di Don’t Walk Away, spazzata via dalla violenza terroristica di More, appena ingentilità dalla vocalità eterea della Parker. Chiude l’album la monolitica suite The Price You Pay (It Must Be Wearing Off) , quasi un abissale, fantasmatico gospel che accompagna HEY WHAT nel silenzio. L’album è il culmine di una dissoluzione, eppure non riesco ad ascoltarlo pensando che sia un album rassegnato, distaccato, o semplicemente l’espressione in musica di una paura che pure è tangibile (perché partorito in un mondo in larga parte spaventoso): piuttosto HEY WHAT è una ground zero, uno spazio aperto sul quale coltivare la speranza di veder fiorire una nuova umanità. Dalla decostruzione e dall’astrazione i Low sono tornati al nocciolo umano: HEY WHAT sutura le ferite aperte e brutalmente esposte nel precedente capitolo musicale della storia di Alan Sparhawk e Mimi Parker ma non è meno estremo nella sua volontà di non accettare compromessi al ribasso, e di non cedere di fronte alla necessità di affrontare a viso scoperto il dolore, la debolezza, la paura.
Friends That Break Your Heart (James Blake)
Recensione completa qui: I’ll Never Let You Forget Me
Sono molto contento di poter inserire un album di James Blake nella mia top dell’anno che va a chiudersi, perché significa che finalmente il ragazzo ha ritrovato la propria strada, tornando sugli standard di eccellenza che ne avevano caratterizzato gli esordi, e soprattutto superando quella prolificità che, unita all’evidente difficoltà nell’operare scelte sul materiale, lo aveva spinto a pubblicare album gonfi di canzoni che apparivano come pallide ombre poco ispirate dei fasti che furono (penso soprattutto a The Colour in Anything). Friends That Break Your Heart, che ha visto la luce lo scorso ottobre, segue un periodo di grande attività per Blake, iniziato col lockdown del 2020, durante il quale ha dato in pasto ai suoi fan due EP e una marea di singoli, oltre a settimanali sessions live dall’isolamento della sua casa londinese. Paradossalmente (ma non troppo) uno dei brani più belli dati alle stampe da Blake in questi ultimi due anni (e durante la sua intera carriera) non ha trovato spazio nell’album: sto parlando della meravigliosa Are You Even Real? . Poco male, però, perché i 12 brani di cui si compone la tracklist non ne fanno rimpiangere troppo l’assenza: la non-love song Famous Last Words come il delicato dubstep di Life is not the same; lo strepitoso duetto con SZA, Coming Back, e l’intimismo piano-voce di Funeral, classico episodio à la Blake; il ritornello colossale di Frozen, schiacciato tra i rap di JID e SwaVay e le scintillanti I’m so blessed You’re mine e Foot Forward, che preludono al duetto con la sempre splendida Monica Martin (già socia dei Vulfpeck e di Theo Katzman per Love is a beautiful thing) su Show me; il gospel di Say What You Will, classica (per Blake) riflessione sulle fragilità umane e sulla difficoltà di gestire aspettative e successo, prelude a uno dei vertici del lavoro, Lost Angel Nights (attenzione: può dare dipendenza), primo brano del trittico conclusivo che comprende anche il classico intimismo nostalgico blakeano della titletrack e il soffice ibrido dubstep-soul di If I’m Insecure. Friends That Break Your Heart è quel lavoro coeso e completamente a fuoco che a Blake mancava, oserei dire, almeno dai tempi di Overgrown: non avrà forse la leggerezza e la freschezza del debutto ma la sua coesione e la sua logica interna ne fanno un prodotto concluso, equilibrato, nel quale Blake può sfogare a un tempo la propria verve autoriale e il proprio amore per soul, R’n’B, dubstep e quelle loro sghembe mescolanze che da sempre ne caratterizzano la scrittura. I’ll Never Let You Forget Me canta Blake in Coming Back: e di sicuro questo disco è di quelli che non si dimenticano.
Promises (Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra)
Recensione completa qui: Il problema dei tre corpi
Se Promises fosse il problema dei tre corpi, i tre corpi sarebbero Pharoah Sanders, Floating Points e la London Symphony Orchestra, e il problema descrivere in maniera efficace la loro interazione lungo i 9 movimenti che compongono questa austera e magnifica suite di jazz minimalista. Su Pharoah Sanders c’è poco che possa esser detto: per chi ha suonato con John Coltrane e Ornette Coleman, Carla Bley e Alice Coltrane il curriculum parla da solo, e Pharoah Sanders appartiene di diritto alla storia del jazz e della musica colta contemporanea. Sam Shepherd, in arte Floating Points, è uno dei più interessanti musicisti elettronici emersi recentemente sulla scena inglese, con un background di studi pianistici, una laurea in neuroscienze e una passione viscerale per Debussy, Bill Evans e Karl-Heinz Stockhausen. Promises è un dialogo, svolto tra il sassofono di Sanders e le note snocciolate dalle tastiere e dai synth di Shepherd, con la London Symphony Orchestra a cucire insieme le varie parti della storia: un cluster di note fa da centro per un grappolo di composizioni molto atonali, distese eppure inquiete, una partitura complessa sulla quale i protagonisti operano una profonda contaminazione linguistica. Difficile descrivere pezzo per pezzo un flusso sonoro che si nutre del silenzio e dal silenzio emerge a intervalli (ir)regolari, seguendo l’ispirazione torrenziale e libera del sassofono di Sanders che risponde ai cluster di Shepard: c’è molto minimalismo nella ripetizione degli elementi ritmici, e Promises sembra proporre un ideale e coraggioso terreno d’incontro tra la musica più rarefatta, quasi ambientale, e quella più libera, totalizzante (il jazz che Pharoah continua a suonare per tutti questi 46 minuti), seguendo una pulsazione tutta sua e andando a cozzare contro i synth e gli incalzanti interventi sinfonici dell’Orchestra. Non manca un elemento puro di misticismo e religiosità, per quanto spoglio e disadorno, come avveniva in alcuni esiti dei Popol Vuh di Florian Fricke (penso allo splendido Hosianna Mantra, per esempio, di cui a volte Promises sembra quasi una versione scarnificata, ancora più eterea). Dai tre corpi, uno che ha voce di sperimentazione elettronica, l’altro che parla il linguaggio del free jazz e il terzo che attinge alla dimensione sinfonica, emerge una composizione musicale nella quale il riff insistito su cui poggiano tutti i movimenti funziona di fatto da accumulatore di tensione (in questo senso, la lezione del minimalismo è espressa in maniera potentissima e totalmente consequenziale), e sopperisce alla mancanza di supporti percussivi operando una glaciale e precisa dissezione dello spazio e del tempo, isolando vuoti e grappoli di suoni, lasciando respirare questo piccolo cluster di note e facendo di questo respiro il ritmo interno, incessante e inequivocabile, di questi 9 movimenti, un respiro che è centro d’attrazione attorno al quale gravitano tutti gli altri suoni sprigionati nella partitura (proprio il ricorso a questa struttura di cluster, l’uso stesso dell’idea del cluster esprime un’intenzione artistica rivolta primariamente verso la manipolazione di un linguaggio che è prettamente jazzistico, il tutto restando entro l’orizzonte sfuggente di una profonda contaminazione e sperimentazione tra linguaggi). Sicuramente le promesse che danno il titolo a questo peculiare lavoro sono le molte, inattese e gravide divagazioni che i musicisti scelgono di percorrere lungo i 46 minuti di questo racconto sonoro: un paesaggio irreale, tratteggiato con mano sapiente ed esposto in maniera languidamente trattenuta, senza svelare niente del suo intimo segreto.
Con questo si chiude il best of di questo 2021, e a me non resta altro da fare che augurarvi un buon anno e darvi appuntamento a domani per l’ultimo post riepilogativo di quest’annata, dedicato interamente a sua maestà il basso elettrico!