Nel 2022 la vita è un po’ tornata alla normalità: certo, io l’ho cominciato in quarantena e mi sono ciucciato anche un secondo Covid durante l’estate, ma in generale la sensazione è che si cominci a vedere la luce (grazie soprattutto agli sforzi della campagna vaccinale). Pur avendo in generale meno tempo a disposizione, tuttavia, mi sono riscoperto a scrivere molto (moltissimo!) anche durante quest’annata: per quantificare, nel 2022 Arcipelaghi ha ospitato, compreso questo, 47 post, ovvero il terzo numero più alto dopo i 60 del 2008 e i 49 del 2009, rispettivamente secondo e terzo anno di vita di questo blog (che è nato nel Novembre del 2007 e che ai tempi era ospitato dalla benemerita piattaforma Splinder), superando anche gli ottimi numeri del 2020 (42 post) e del 2021 (40 post). Ah, a tal proposito mi permetto un’autocelebrazione: nel corso di quest’anno, appunto a Novembre, il blog ha compiuto 15 anni, e casualmente quello che state leggendo è il post numero 350 di Arcipelaghi, e mi piace l’idea di chiudere l’anno con un bel numero tondo. Il 2022 ha portato con sé una piccola novità, della quale sono molto felice (anche se mi è costata parecchia fatica): col decisivo supporto del mio editor di fiducia, Serena Chiofalo, ho iniziato a scrivere alcuni post integralmente in inglese, per ampliare la platea degli utenti del blog. La rubrica, denominata con grande fantasia English Versions (prometto che mi lambiccherò per trovare un titolo migliore) ha contato quest’anno 7 post. L’altra rubrica principale del blog, dedicata alla musica jazz (Play what’s not there: Jazz on Arcipelaghi), ha fatto segnare anch’essa 7 post: numeri che potevano (e dovevano) essere maggiori, ma il tempo, ahimè, è quello che è.
Nel frattempo, la nostra piccola ma agguerrita community Facebook è rimasta circa stabile, con l’aggiunta di qualche unità (siamo in 76 mentre scrivo). Se volete dare un’occhiata e magari anche unirvi, basta schiacciare l’iconcina di Facebook in alto a destra sulla pagina, oppure nella colonna sinistra del blog: non mordiamo nessuno e vi aspettiamo a braccia aperte! Ma ora bando alle ciance di circostanza, e tuffiamoci di testa dentro una tradizione che accompagna queste pagine ormai dal lontano 2014 (siamo pertanto alla nona edizione), ovvero il best of dei dischi dell’anno!
Ed ecco a voi l’11 titolare di Arcipelaghi per il 2022!!
Consueta premessa per i Cristiano Ronaldo della musica (ciao CR7!): qui non si fa a gara, non ci sono competizioni, non ce ne sbatte una beata minchia di chi sia il chitarrista (ovviamente metallaro) che sa fare gli assoli più tecnici e con la cascata di sessantaquattresimi più veloci e nitidi a 240 bpm, né tanto meno ci interessa distribuire pagelle. Astenersi narcisisti e drogati di competizione. L’elenco procede come di consueto per lo più a braccio, tipicamente a caso quando non regolarmente a cazzo. Anche quest’anno è stato abbastanza difficile compilare questa lista, perché di dischi ormai tendo ad ascoltarne diversi (e scorrendo indietro i post ve ne renderete conto da soli): alcune rinunce sono state dolorose. Cercherò di essere breve (più del solito) specie considerando che ogni disco che citerò ha sul blog un suo post dedicato (al quale troverete rimando). In ogni caso, nell’eventualità che ci fosse qualcosa che mi abbia sconquassato i precordi più della media, non mancherò di farvelo notare: di solito non sono avaro con le parole.
 Echoes to the Sky (Archipelago)
Echoes to the Sky (Archipelago)
Recensione completa qui: The Shape of Jazz to Come, disponibile anche in inglese.
Forse il primo colpo al cuore del 2022 è stato questo album, il secondo degli Archipelago, trio londinese composto da Faye MacCalman (clarinetto, sax tenore, sintetizzatori e voce), John Pope (basso e contrabbasso) e Christian Alderson (batteria e percussioni), e dedito a una profonda decostruzione e contaminazione del jazz con la psichedelia, il post-rock e alcune derive verso un’elettronica minimale e rumorista. Echoes to the Sky è stato pubblicato per New Jazz & Improvised Music Recordings nel 2021, ma io ci sono arrivato tardi e quindi lo piazzo ben volentieri qui dove gli compete: sospeso tra il songwriting della leader e l’attitudine da power-trio dedito a un jazz audace, contaminato, sperimentale e con chiare tinte psichedeliche, l’album produce un piccolo miracolo musicale la cui vera forza risiede, oltre che nell’incredibile qualità strumentale e compositiva, soprattutto nelle coraggiose performance vocali della MacCalman. Quello della band è stato definito “shape shifting sound”, un suono che rimodella le forme, gli stili e lo spettro sonoro, sempre diseguale, mutevole: ci si trova di fronte a otto brani dalla resa scintillante, altrettante visioni di mondi possibili, nelle quali si incontrano (e si scontrano) la levità del cantautorato folk, le asprezze e le digressioni psichedeliche, la scomposizione ritmica del prog, la misteriosa ricchezza delle divagazioni elettroniche e tanto, tantissimo jazz, racchiuso nell’amore per l’improvvisazione di tutti i musicisti e soprattutto nel suono ora rotondo e morbido, quasi liquido, e ora secco e diseguale del tenore e del clarinetto della MacCalman. Prendete Waiting o Wine Dark Sea e lasciatevi semplicemente trasportare.
 Raw Data Feel (Everything Everything)
Raw Data Feel (Everything Everything)
Recensione completa qui: Random Access Melodies
Raw Data Feel è un disco-mondo, un ideale contenitore di tutte le ossessioni di Jonathan Higgs e della sua band, gli Everything Everything (Michael Spearman, Jeremy Pritchard e Alex Robertshaw), una band che chi segue queste pagine conosce fin dal debutto nel 2011 (mi vanto sempre di esserci arrivato prima di un sacco di altra gente). Un disco-mondo, dicevamo, che è un disco politico (come tutte le cose scritte da Higgs) e insieme intimo, esistenziale, una riflessione feroce e mai scontata sulla complessità del tempo che viviamo e sulle sue sfide, e ovviamente anche l’ennesimo tassello dell’evoluzione sonora di un collettivo di musicisti di una qualità alla quale non siamo (purtroppo) più abituati. All’origine di Raw Data Feel c’è una riflessione di Higgs che mi ha molto colpito, relativa al trauma vissuto negli anni della pandemia: “I don’t want to be defined as a political singer. This record isn’t really looking at the world. Instead, it’s very personal. It’s about getting over trauma, but using characters to play that experience out, so I don’t have to deal with it head-on. A lot of people probably do have trauma from this period we’ve all gone through, whether they directly relate to what I’m saying or not. I’m trying not to make [the theme of trauma] super obvious, but a lot of the songs converge towards the same thing, which is unusual for us. I speak about using technology to deal with something rather than me dealing with it myself. I used an AI’s brain to write my songs because I don’t want to talk about those things right now; that’s kind of the idea – relying on technology like a crutch, and this modern loneliness where your only friend is your phone.” La stampella cui Higgs si è appoggiato nello sviluppo di Raw Data Feel è stata Kevin, un’Intelligenza Artificiale che ha steso una parte dei brani (valendogli il riconoscimento come coautore). Realizzata col contributo di Mark Hanslip, musicista e ricercatore all’Università di York, a questa A.I. sono stati dati in pasto una serie di dati grezzi (i Raw Data del titolo, chiaramente), un insieme composito di suggestioni che Kevin ha potuto usare come base per i testi dei brani di Raw Data Feel, nel tentativo di unire il dato grezzo al calore umano (il Feel, l’aspetto emotivo e sentimentale); la precisione della macchina e la profondità del sentimento. Non solo, all’intelligenza artificiale si deve anche l’artwork del disco (un’immagine dello stesso Kevin, direi, e mi piace pensare che sia il modo in cui Kevin vede se stesso, che poi se ci pensate è una forma di autocoscienza, il che dimostra come il discorso sviluppato lungo Raw Data Feel sia anche strettamente interconnesso con le tematiche di RE-ANIMATOR). Musicalmente Raw Data Feel è un ibrido tra il sound schiettamente elettronico di album come A Fever Dream e un ritorno verso una composizione più canonica, organica alla forma-canzone, e disegna un panorama sonoro che svaria tra il rock elettronico (Teletype), un’indie-rock al sapore di new wave con qualche eco degli anni ’80 (Jennifer), guizzi di un R’n’B groovy e futurista (Shark Week) e veri e propri soundscapes (Leviathan, Software Greatman), con ispirazioni che vanno dagli amati Radiohead al krautrock fino al progressive. Nel suo tentativo di esprimere la solitudine in musica, Raw Data Feel è una sorta di array lineare di sentimenti e a me piace da sempre pensare a questo album come a una storia d’amore ai tempi dell’intelligenza artificiale, che si nutre di dolore, morte, violenza e che pure strappa brandelli di umanità all’inevitabile cancellazione della memoria: cosa c’è, in fondo, di più intimo e insieme di più collettivo, di più politico? Sicuramente uno de momenti più alti dell’anno che giunge a conclusione.
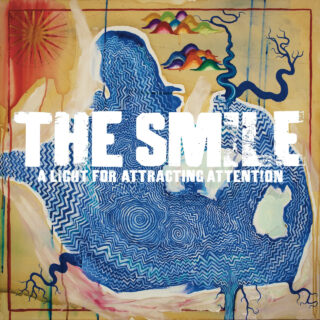 A Light For Attracting Attention (The Smile)
A Light For Attracting Attention (The Smile)
Recensione completa qui: Un suono del mondo fluttuante
Ascoltando la prima fatica sulla lunga distanza degli Smile di Thom Yorke e Jonny Greenwood (che per l’occasione hanno reclutato un batterista come Tom Skinner quanto la colonna sonora di Suspiria, che Yorke compose qualche anno fa per il remake del classico di Dario Argento realizzato da Luca Guadagnino: A Light for Attracting Attention è difatti un flusso sonoro più che un semplice album di canzoni, l’esempio di una musica nuova, coerentemente e radicalmente sperimentale e insieme una suite variegata e articolata, lontana anni luce dalle logiche radiofoniche (o di streaming) che guidano la maggior parte della produzione musicale odierna. Sarebbe profondamente ingiusto pensare a questo progetto come a uno spin-off della main band di Yorke e Greenwood, e come se Skinner vi fosse cascato dentro per caso: A Light for Attracting Attention è un album che ha una sua personalità, una vita propria e potenziali amplissimi orizzonti davanti a sé, se si esce per un attimo dall’idea che si tratti banalmente un disco di musica pop/rock (per quanto originale ed eclettica, e per quanto comunque di fatto lo sia). Yorke, Greenwood e Skinner frullano dentro quest’esperienza tutto il loro portato artistico, svariando tra indie-rock, elettronica a pacchi, tentazioni jazz, ambient music e ritmi tribali africani (dei quali è portatore soprattutto il batterista, basti pensare al suo lavoro coi Sons of Kemet). Con il già citato Suspiria, A Light for Attracting Attention convivide il modo affascinante di ondeggiare tra generi diversi (lì erano il trip hop e la musica da camera, l’elettronica retrò e il minimalismo, la polifonia e il misticismo; qui il progressive rock e il jazz tout-court, soprattutto nell’uso dei fiati, le orchestrazioni classiche e cinematiche e gli scampoli d’elettronica, l’indie-folk e i tribalismi ritmici) e un suono sospeso, sognante ed enigmatico, che contribuisce in maniera determinante a creare atmosfere sfuggenti, fluide, oniriche. La complicatissima musica suonata dal trio attraversa una zona d’ombra, una twilight zone, la striscia di terra che separa il sonno dalla veglia, come in un costante e periglioso affondare sotto il e riemergere dal pelo dell’acqua, avvolti da un maelstrom oscuro che tenta di risucchiarci. Ho definito quello degli Smile come il suono di un mondo fluttuante: in un contesto socio-economico e storico che vede il mondo ogni giorno spingersi un passo più in là sull’orlo del precipizio, la musica suonata da Yorke, Skinner e Greenwood è una delle più ricche e gravide rappresentazioni della complessità degli orizzonti che si aprono davanti a noi, e in questo un’espressione assolutamente, drammaticamente contemporanea. Ecco, secondo me questo disco è un disco di jazz, proprio nel suo approccio: nell’uso dei fiati (penso a brani come The Smoke o Speech Bubbles), nell’uso dello spazio e del ritmo, nelle sue spigolosità e nelle sue aperture. Non che ci si potesse aspettare di meno da musicisti di un’altra categoria, da sempre capaci di plasmare la musica in maniera originale e meravigliosamente imprevedibile.
Recensione completa qui: Back to the Future
Empire Central, ultimo lavoro in ordine di tempo degli Snarky Puppy, large ensemble- big band- supergruppo capitanato dal buon Michael League, bassista e principale compositore, è il racconto appassionato di un ritorno a casa, un vero e proprio poema del ritorno o, in altre parole, il modo scelto dalla band per confrontarsi, ad anni di distanza dagli inizi della propria carriera, con l’eredità musicale dalla quale tutto ha avuto inizio. Ovviamente ne è passata di acqua sotto i ponti: la band jazz formatasi all’università di Dallas è entrata in un’orbita eccentrica fatta di soul, funk (sotto l’egida di un mostro sacro come Bernard Wright, che ha inciso proprio in questo disco coi suoi “protetti”, poco prima di morire in un tragico incidente stradale, l’ultimissima performance di una travolgente carriera) e fusion/world music, senza farsi mancare alcuni flirt con le atmosfere del pop più raffinato (sia come ensemble che nelle traiettorie dei singoli musicisti, e penso al progetto Mirrors che coinvolgeva sia League che Justin Stanton) e punte di un sound di chitarra sempre più denso e potente, con accenni che vanno diretti alle sonorità prog (rock, ma qua e là anche metal) e blues. Parlare di Empire Central è ovviamente complesso (e riduttivo), come cercare di incasellarlo: per usare un giro di parole, si può chiosare definendolo disco-fiume (o anche disco-mondo) che affronta il tema dell’Eredità musicale e delle origini con un misto di nostalgia e romantica reinvenzione, uno zibaldone intimo ma insieme spavaldo, complesso e delicato, che tenta di tenere insieme quasi vent’anni di carriera in oltre un’ora e mezzo di musica straordinaria. Empire Central non è concentrato e teso come Immigrance, né coeso come Culcha Vulcha, non è quel tipo di lavoro, si rifà piuttosto ad album precedenti come la serie dei Family Dinner, registrati in presa diretta in un contesto live, con tanto di pubblico plaudente (e chiaramente ammaliato): nonostante possegga un orizzonte tematico chiaro, palese e ben definito (Dallas, il cui skyline è impresso anche nella splendida, giocosa cover art; la Città e la memoria), i sedici movimenti che lo compongono sono profondamente diversi tra loro e danno fondo a un universo enorme di ispirazioni, riferimenti e intenzioni, percorrendo un numero quasi incalcolabile di direzioni, ma con lo sguardo sempre rivolto avanti, in direzione del futuro. Empire Central concentra ricchezza, calore, bellezza e pathos dentro un’ora e mezzo di meraviglie musicali, e ripropone con forza gli Snarky Puppy come la più pura e affascinante avanguardia della miglior musica contemporanea. C’è tanta tecnica, è vero, tanta classe, e ce n’è a iosa: ma c’è soprattutto l’afflato umano, il calore della memoria, la forza del ricordo e la tenacia di chi guarda coraggiosamente al domani, poggiando i piedi ben saldi nell’oggi e senza dimenticare il proprio passato. Musica realmente progressiva, se volete, ma forse meglio ancora progressista, in mezzo a un panorama di sempre più desolanti “immondizie musicali”: musica da custodire con cura.
Recensione completa qui: La Gaia Scienza
La serie dei Vulf Vault, ideata da Jack Stratton per omaggiare i componenti principali dei Vulfpeck, è andata in drammatico crescendo in questi due anni di sviluppo, e col sesto episodio (su sette previsti) ha raggiunto un apice difficile da eguagliare: come era già accaduto per lo splendido Wong’s Cafe, quinto volume della serie dedicato a Sua Maestà Cory Wong, anche questo sesto episodio contiene solo materiale inedito, ed è centrato su Vulfmon, ovvero sulla reincarnazione dello stesso Stratton, autentico deus ex machina della band americana, nella persona del messaggero, lo spiritello alato, dispettoso e stralunato che porta il verbo del low-volume funk all’ampia platea dei seguaci. La Gaia Scienza della quale Stratton/Vulfmon si fa portatore non richiede che questo: non prendere niente sul serio, a parte la Musica, e qui infatti la Musica è roba serissima. Le dieci tracce che compongono Here We Go Jack (questo il titolo del primo album solista del nostro) sono infatti un autentico concentrato di creatività e ispirazione e il manifesto di un’artista capace di reinventare e reinventarsi (arrivando persino a cantare e metterci la voce, come accade nella title track): una scelta di brani equilibratissima, sebbene di un equilibrio assolutamente stralunato, che paga il giusto tributo all’adorato funk (Boogie Man, Rutgers), anche ibridandolo con tentazioni psichedeliche e acide (Take Me To A Higher Place) o addirittura AOR (Let’s Go! Let’s Go! ), ma pure al soul, all’R’n’B (How Much Do You Love Me? , Alone Again, Naturally) e persino al blues rock (Never Can Say Goodbye), senza dimenticare l’amore per le tessiture bachiane in odore di classicismo (gli episodi di Bach Pedal e Contrapunctus I). Here We Go Jack è un disco teso, concentrato e diretto, al quale non manca assolutamente niente di niente: in pratica è un po’ il disco perfetto, e non crediate che per realizzarlo sia bastato poco o che il fatto di prendersi poco o per nulla sul serio sia indice di trascuratezza, tutt’altro; frequentare la perfezione costa fatica e impegno, ma come ci ricorda la parola del profeta, “better a sore ass than a tattered soul”. Va a finire che aveva ragione (come sovente accade) quel tizio che, sui commenti di YouTube, ha proclamato che si farà incidere questo motto sulla tomba…
 Five Seconds Flat (Lizzy McAlpine)
Five Seconds Flat (Lizzy McAlpine)
Recensione completa qui: It’s the End of the World as We Know it
Come ho raccontato più e più volte, Lizzy McAlpine l’ho scoperta per caso circa un anno fa, a Gennaio, ascoltando all my ghosts, primo singolo estratto dall’allora incipiente secondo album dell’artista americana, Five Seconds Flat: manco a (ri)dirlo, è stato amore a primo ascolto. L’album sposa un cantautorato molto semplice e diretto con atmosfere indie-folk e con il miglior pop in circolazione (le collaborazioni con gente del calibro di FINNEAS e soprattutto Jacob Collier non vengono certo per caso), arricchendo la tavolozza con arrangiamenti ricercati e un gusto discreto per l’elettronica più minimale. Ma a travolgere davvero è soprattutto la voce di McAlpine: bellissima, potente e insieme incrinata, fragile e gonfia d’emozione, uno strumento aggiunto che porta su un’altra dimensione l’atmosfera intima e malinconica di questi brani, che sono centrati, da un punto di vista tematico, su quelli che Fleur Jaeggy ribattezzò come i beati anni del castigo, ovvero l’adolescenza e quel periodo di passaggio dalla giovinezza all’età adulta. Così ci sono gli amori finiti (Doomsday, erase me), la vita che continua (all my ghosts), la paura di lasciarsi andare e soffrire (reckless driving e firearm); e soprattutto c’è la forza del sentimento (hate to be lame), quello che spinge a continuare, ad andare avanti. Gli eventi che seguono una rottura, sembra dirci Lizzy McAlpine, sono una giostra di emozioni stordenti e stancanti al tempo stesso: lasciano cicatrici nell’anima, nell’identità e sulla pelle. Ma la fine di una storia è un po’ come la fine del mondo: spaventosa, dolorosa eppure piena di possibilità. Per citare una raccolta di poesie di un poeta che apprezzo, “when I grow up I want to be a list of further possibilities”: se poi hai una voce come quella della McAlpine, tutto è ancora più facile (e bello). Ah, piccolo addendum: Five Seconds Flat è anche un film, realizzato da McAlpine insieme al videomaker Gus Black, regista di tutti i video dei singoli estratti dall’album: tutto questo fa del racconto del disco una storia per parole, musica e immagini.
Recensione completa qui: The shape of funk to come
Non può esistere best of senza almeno un disco del buon Cory Wong dentro, perché ormai è tradizione che sia così e noi ci teniamo alle tradizioni! Quest’anno è stata dura, perché c’era diversa scelta (come al solito, e cito solo il bellissimo Wong’s Cafe), ma alla fine a spuntarla è stato il ciclopico Power Station, odissea in quattro facciate nel multiverso musicale del compositore e chitarrista di Minneapolis: legato a doppio filo al fantastico Cory and the Wongnotes, uscito lo scorso anno, Power Station richiama a raccolta la stessa band di straordinari musicisti (i Wongnotes, appunto) e viene accompagnato ancora da una pioggia di video a tema, episodi “estesi” di un’immaginaria serie TV, quello che non si può esitare a definire come “The Greatest Variety Show Ever”, incentrata sul format di una “musica rappresentata nel momento del suo farsi”, con tanto di interviste ai suoi protagonisti (il parterre de rois di ospiti che si susseguono nelle varie tracce, nomi che vanno da Chromeo a Joey Dosik, da Mark Lettieri a Béla Fleck, da Victor Wooten a Nate Smith, solo per citarne alcuni), finti commercials surreali, spezzoni di parti recitate e tanta, tantissima musica. Restando sulla musica, il disco vero e proprio è composto di 15 tracce, in una storia perfettamente divisa in tre parti: una prima parte di funk cantato, cinque brani con diversi ospiti ad avvicendarsi alla voce; una seconda parte costituita da cinque episodi all’insegna del più classico funk d’avanguardia suonato da Wong e dai suoi Wongnotes, con un ventaglio di collaborazioni atte a creare mutevoli ibridi musicali; e infine una terza parte con cinque brani che si riconnettono alle tentazioni country/folk/roots e alle levità acustiche già ammirate negli album gemelli Trail Songs (Dusk e Dawn) pubblicati da Wong nel corso del 2020. La quarta facciata di cui parlavo all’inizio la offre l’edizione deluxe dell’album, quattro brani aggiuntivi riarrangiati per l’occasione dai Wongnotes in una sorta di “Cory and the Wongnotes che rileggono Cory Wong (e se stessi)”: se adesso vi gira un po’ la testa sappiate che è normale, e in parte è anche un po’ l’effetto che devono fare queste canzoni. Se considerate che non capita spesso di trovarsi tra le mani un disco che contenga al suo interno almeno tre dischi (ma pure quattro), capirete come Power Station sia qualcosa di speciale: di sicuro, un passaggio ineludibile per chi voglia restare al passo con la creatività di quello che io personalmente considero come uno dei compositori più brillanti e importanti di questi nostri anni. Cory Wong è molto più che un guitar hero, un mostro di tecnica e bravura e una delle chitarre ritmiche più riconoscibili e irresistibili in circolazione; è soprattutto un musicista, un artista e un compositore dotato di una Visione, capace di tenere insieme un universo musicale che altrove ho definito “in espansione”, un contenitore ricchissimo, coloratissimo, pieno di idee e ambizione, un paesaggio sonoro multicolore dal quale è meraviglioso lasciarsi rapire. Penso spesso a Wong come a un creatore di storie, un pifferaio magico, una di quelle figure un po’ mistiche e un po’ scanzonate che ti piace restare ad ascoltare anche se non capisci subito la portata di quello che vogliono dirti: ci vogliono un’ambizione smisurata e una classe infinita per tenere insieme quindici brani come questi, e lasciar esplodere gioiosamente tutto l’universo di idee, bizzarrie, riflessioni e multimedialità che trasuda dagli episodi della seconda stagione di Cory and the Wongnotes, a quest’album strettamente interconnessa, tutte doti che a Cory Wong (e alla sua ciurma di straordinari musicisti) di certo non fanno difetto.
Recensione completa qui: Light as a Feather
Hohnen Ford è una scoperta di cui vado estremamente fiero, fatta come sempre per caso quest’estate su Instagram, se non ricordo male. Dal primissimo istante in cui ho sentito la voce della giovanissima cantante e pianista londinese Ella Hohnen-Ford (questo il suo nome completo) ho capito di trovarmi davanti a qualcosa di enorme: una voce di una ricchezza, di una profondità emotiva e piena di così tanti colori come non se ne sentono ogni giorno, qualcosa di speciale che sembra provenire da una profonda distanza, eterea eppure caldissima, accompagnata unicamente dalle note sparpagliate di un pianoforte dai toni inconfondibilmente jazz. Tra l’agosto e l’ottobre di quest’anno, Hohnen Ford ha dato alle stampe i quattro singoli che sono confluiti nel suo EP di debutto solista, intitolato Infinity EP (e distribuito dall’etichetta londinese Young Poets): dalla raffinata malinconia della titletrack, una ballad delicatamente jazzy, all’ibrido di Send Me A Sign, che strizza l’occhio al miglior pop da camera; dalla splendida e semplice progressione di accordi che accompagna la plausibile intimità di Close To Your Heart alle affascinanti sfumature jazz di Don’t Fall Asleep; non c’è un solo passaggio in questi brevi ma intensissimi 12 minuti di musica che non faccia gridare al miracolo. Ogni volta che riascolto questa musica, mi sorprendo a commuovermi; vi sto parlando di quattro canzoni bellissime, di quelle che danno i brividi lungo la schiena. Io non conosco il futuro, e anche se auguro a Hohnen Ford il successo che merita, non so se e come andranno le cose, però a voi un consiglio mi sento di darlo: schiacciate play e godetevi questa musica, perché certe emozioni non hanno prezzo.
(english version) I’m very proud of my discovery of Hohnen Ford’s music, made by chance (as always) this summer on Instagram, if I remember correctly. From the very first moment I heard the voice of the young London singer and pianist Ella Hohnen-Ford (this is her full name) I knew I was in front of something huge: a voice whose richness, emotional depth and color palette is something you don’t hear every day. Ella has something special that seems to come from a deep distance, ethereal yet very warm, and on her tracks she is accompanied only by the scattered notes of a piano with unmistakably jazzy tones. Between August and October of this year, Hohnen Ford released the four singles that merged into her solo debut EP, entitled Infinity EP (and distributed by the London-based label Young Poets): from the sophisticated melancholy of the title track, a delicately jazzy ballad, to the hybrid of Send Me A Sign, which winks at the best chamber pop; from the beautiful and simple chord progression that accompanies the plausible intimacy of Close To Your Heart to the charming jazzy nuances of Don’t Fall Asleep; there is not a single passage in these short but very intense 12 minutes of music that does not make you cry out for a miracle. Every time I listen to this music again, I find myself moved: I’m telling about four beautiful songs, the kind that send shivers down your spine. I don’t know the future, and even if I wish Hohnen Ford the huge success she deserves, I don’t know how things will go, but in any case I would like to give you this advice: press play and enjoy this music, because certain emotions are priceless.
 Paseo del Bajo Vol. 2 (Sebastián Tozzola)
Paseo del Bajo Vol. 2 (Sebastián Tozzola)
Recensione completa qui: “Le strade di Buenos Aires sono le viscere dell’anima mia”
Altra scoperta che ho fatto un paio d’anni fa girovagando su Instagram, Sebastián Tozzola è un bassista argentino, compositore, clarinetto basso per l’orchestra filarmonica del Teatro Colón di Buenos Aires ed endorser di Ernie Ball Music Man, ma soprattutto ho il piacere di definirlo amico ed è per me figura di continua e forte ispirazione musicale. Paseo del Bajo Vol. 2 è il seguito di Paseo del Bajo, pubblicato nel 2020, e prosegue la ricerca musicale di Sebastián, che sposa la tradizione musicale argentina (e più in generale sudamericana) con il songwriting del pop moderno, arricchendo la propria tavolozza con colori che vengono dal jazz e anche dalla musica classica. Addentrarsi dentro l’opera di Sebastián è un viaggio di scoperta, come entrare dentro un mondo pieno di sorprese: si perde il conto delle cose che si possono imparare e di quelle che non si immaginavano nemmeno, tra generi musicali lontani dalle nostre orecchie e scansioni ritmiche inusuali, clavi e funambolici passaggi solisti. Paseo del Bajo Vol. 2 raccoglie questo senso di scoperta e racchiude una sequenza di interpretazioni musicali memorabili, opera di un’artista dalla sensibilità e dal tocco fuori dal comune: musica splendida, che fa bene al cuore e alla curiosità di chi ascolta.
(english version) Another discovery I made a couple of years ago while wandering around on Instagram, Sebastián Tozzola is an Argentinian bassist, composer, bass clarinet for the Philharmonic Orchestra of the Teatro Colón in Buenos Aires and Ernie Ball Music Man artist; but, above all, I have the pleasure to call him a friend and he is for me a figure of continuous and strong musical inspiration. Paseo del Bajo Vol. 2 follow the homonymous Paseo del Bajo, released in 2020, and continues Sebastián‘s musical research, which blends the Argentinian (and more generally South American) musical tradition with modern pop songwriting, enriching his palette with colors that come from jazz and classical music. Delving into Sebastián‘s work is a journey of discovery, like entering a world full of surprises: you lose count of the things you can learn and those you never even imagined, between musical genres far from our ears and unusual rhythms, claves and acrobatic solo passages. Paseo del Bajo Vol. 2 collects this sense of discovery and contains a sequence of memorable musical interpretations, standing out like the work of an artist with an uncommon sensitivity and touch: splendid music, which is good both for the hearts and the imaginations of the listeners.
 The Line Is A Curve (Kae Tempest)
The Line Is A Curve (Kae Tempest)
Recensione completa qui: And when I stopped looking for me I was able to find you
Kae Tempest è unə poetə che adoro fin dal primo incontro con i suoi versi, e soprattutto unə straordinariə performer (come ho avuto la fortuna e il piacere di toccare con mano nel corso di https://eosblog.altervista.org/la-nuda-parola-kae-tempest-al-castello-di-civitella-ranieri-26-10-2022/ un evento molto intimo ospitato lo scorso ottobre presso la Civitella Ranieri a Umbertide). The Line Is A Curve è un album col quale Kae Tempest ha intrapreso definitivamente un percorso musicale nuovo, differente rispetto a quanto realizzato con i lavori precedenti (o per meglio dire, posto in una continuità basata sulla progressiva evoluzione del mezzo espressivo): si assiste a un delicato distaccamento dal puro spoken word con la volontà feroce di muovere le istanze poetiche dellə autorə anche in direzione di un pubblico molto più vasto, quello che approccia la musica come esperienza sonora prima ancora che come veicolo letterario; non solo la cura del significato, quindi, ma una nuova attenzione concessa anche al significante. Non che questo aspetto fosse mancante nei lavori precedenti, ma The Line Is A Curve è un disco di 12 canzoni, che portano la poesia dentro il mondo con il trasporto che solo la musica sa garantire; è un disco allusivo fin dal suo titolo apparentemente contraddittorio, e che proprio di contrasti si nutre per dipingere la storia di uno spirito che torna a se stesso; è il racconto di un viaggio, di un percorso che ha portato lə suə autorə a riappropriarsi della propria identità, imparando a riconoscersi, a nominarsi e infine ad amarsi. Un percorso individuale che è al tempo stesso collettivo, sociale, perché solo nel confronto con il resto del mondo si può riuscire a trovare un senso anche alla propria esistenza: e a me piace sempre pensa che la poesia possa nascere solo da un incontro con l’Altro da sé. Il lavoro svolto da Tempest e dal suo collaboratore Dan Carey sulla natura (e sulla forma) di questi brani è magistrale, perché mantiene intatto il loro intrinseco minimalismo, il loro essere uno strato (o una sequenza di strati) che fa da fondamenta per l’edificazione di un edificio che è prima di tutto parola, prima di tutto poesia, al tempo stesso conferendo a questo approccio minimale un ruolo che è progressivamente più paritario rispetto alla stessa parola: la più forte sensazione che si prova ascoltando The Line Is A Curve è quella di un dialogo, di un confronto continuo tra la musica e i versi, nel quale sono a volte le parole a spingere i crescendo, i momenti di pieno e quelli di vuoto, e altre volte le note a rallentare e accelerare il ritmo, a conferire uno spessore nuovo al respiro, la costanza ineluttabile di un battito cardiaco ai versi. Ecco, il respiro: la poesia di Kae Tempest è da sempre soprattutto urgenza comunicativa, una forza espressiva feroce e tagliente, intarsiata e incasellata dentro ritmiche serratissime; un’esperienza autenticamente poetica, nella quale il ritmo e il colore sono sempre presenti anche in assenza della musica. Provate anche solo a leggere uno di questi testi, o una qualunque poesia del loro autorə, e capirete di cosa sto parlando. In qualche maniera, la musica completa questi versi, li rende tridimensionali, vivi, si inserisce dentro il loro respiro e gli dà spessore, forza, ricchezza; le parole scandite da Tempest, le loro pause, i momenti in cui lə loro autorə prende il fiato sono tutti quanti sottolineati, arricchiti, impreziositi dagli accompagnamenti musicali, che li trasportano in una dimensione completamente nuova, diversa. Alla fine The Line is a Curve è un lavoro che parla del respiro, perché è il respiro che ci rende vivi, e l’umanità che trasuda da queste dodici poesie in musica è un’umanità viva, vibrante, reale; è vita scegliere, è vita sbagliare, è vita perdersi e non sapersi ritrovare, è vita riappropriarsi di sé, tornare a sé, scoprire chi siamo, prendersi per mano. Non è un caso che questo sia forse il lavoro più scopertamente, dolorosamente personale, più intimo e insieme più onesto, aperto, tra tutti gli LP realizzati da Tempest: un lavoro nel quale la ricerca dell’identità è completata, dichiarata ed espressa, e che pure tuttavia rappresenta magnificamente un inizio (l’inizio di una vita, in particolare) e non la fine di un percorso; un disco nel quale la linea della vita è una curva, qualcosa di inusitato, molte curve dietro le quali si possono nascondere cose tanto diverse tra loro, che non avremmo saputo immaginare; un disco nel quale si può tornare a fare i conti con il proprio sé, dopo aver accettato e lasciato andare ciò che è stato, al punto che Kae Tempest arriva a metterci addirittura la faccia, per la prima volta, attraverso le splendide foto che accompagnano il disco, opera del grande Wolfgang Tillmans. Come scriveva Tempest in una splendida poesia da una vecchia raccolta, Don’t matter that we’ll lose today./ It’s not tomorrow yet.
 Home, Before and After (Regina Spektor)
Home, Before and After (Regina Spektor)
Recensione completa qui: A cosmic homecoming
Ci sono alcuni album che sono strettamente legati al loro contesto, e non parlo necessariamente di contesto artistico, ma anche semplicemente di luoghi: Home, Before and After, di Regina Spektor, è uno di questi, strettamente connesso alla città nel quale è nato, New York. La sua stessa autrice si spinge a definirlo [my] most “quintessentially New York” album yet, e non a caso: i brani che lo compongono sono in larga parte nati durante l’infuriare della pandemia da covid-19, una fase di scrittura personale e solitaria condotta dalla Spektor col suo solo pianoforte all’interno di una chiesa sconsacrata nei dintorni della Grande Mela; solo in un secondo momento il producer John Congleton ha lavorato sull’arrangiamento e il mix dei brani nei suoi studi californiani. L’incontro di questi due mondi apparentemente molto distante è riuscito a rivestire l’immaginazione febbrile della Spektor di sonorità e colori variegati, altrettanto fantastici e fantasiosi, conferendo ai brani uno spessore e una ricchezza che generano sincero stupore in chi ascolta. Date le circostanze del loro concepimento, i brani sono tutti per lo più incentrati sui temi della solitudine, a volte della depressione, sicuramente di una qualche forma acuta di Weltschmerz, ma anche sull’amore, i rapporti umani e le loro difficoltà: dentro Home, Before and After casa è sempre New York, che è insieme luogo fisico, reale, e sua trasfigurazione; città brulicante di persone e spazio assolutamente intimo, megalopoli e perfetta epitome della solitudine. Dentro tutto il realismo magico che riempie queste canzoni l’unica cosa davvero reale siamo noi e gli altri: Home, Before and After divento così prima di tutto un formidabile canto alla vicinanza umana, dedicato cioè a tutto ciò che ancora ci rende esseri umani. Nell’insieme di queste dieci tracce c’è una Storia, e in questa Storia c’è un profondo, affascinante senso di completezza: essa emerge naturalmente dall’immagine della Città, New York, l’immagine d’apertura, e finisce per avvolgere le orecchie e il cuore dell’ascoltatore in un crescendo di delicate meraviglie, di piccoli e gioiosi misteri buffi, di versi delicati e assurdi, teneri e sopra le righe. Regina Spektor ha una fantasia febbrile, per molti versi davvero bambinesca (in tutte le accezioni positive che riesco a dare a questo termine); ovvero potente, profonda, piena di invenzioni, immaginifica. I suoi versi creano mondi il cui splendore è compito della musica restituire in una forma che sia più che semplice parola, autentica manifestazione fisica, tattile; tutto il disco non è che un inno pop alla potenza della parola e dell’immaginazione, un ritorno a casa condotto nell’intima convinzione che la meta del viaggio non sia altro che un nuovo punto di partenza, una nuova tela bianca sulla quale continuare a dipingere mondi.
C’è giusto il tempo per due rapide menzioni extra
Proseguendo con la metafora calcistica con la quale ho avviato questo best of, ho deciso di portarmi due titoli extra in panchina, così, per avere dei cambi. Li metto in panchina soltanto perché si tratta a tutti gli effetti di album pubblicati nel 2021, e che avevo già cominciato ad ascoltare lo scorso anno senza però trovare il tempo di scriverne. Il tempo l’ho trovato solo quest’anno, e allora li metto qua dentro (perché di sicuro avrebbero trovato spazio anche nel best of del 2021).
Recensione completa qui: Music for the masses
Alcuni album sono in grado di raccogliere dentro di sé una complessità e una ricchezza e tutte quelle contraddizioni e meraviglie che danno al nostro mondo la forma che esso ha, trascendendo con ciò l’aspetto puramente musicale ed erigendosi a opere d’arte “totali”, una categoria alla quale appartengono poche opere che sono davvero, tangibilmente in grado di plasmare la realtà col loro proprio linguaggio, indicando nuove direzioni. È il caso di WE ARE, l’album di Jon Batiste (artista che davvero non necessita di presentazioni) che ha sbancato l’ultima edizione dei Grammy, con cinque premi su 11 nomination totali: l’idea totale che tiene insieme l’album è quella di una musica sociale, in grado legare una tradizione artistica che abbraccia tutto l’arco che da Duke Ellington conduce a Stevie Wonder, all’RnB contemporaneo, al rap e finanche alla grande storia della musica classica, senza mai perdere di vista la gioia dell’interazione tra gli essere umani (non a caso la band di Batiste si chiamava Stay Human) e il concetto di musica come forma di espressione, linguaggio di convivialità, veicolo per creare comunità e incidere realmente sulla realtà. WE ARE assolve ad almeno tre compiti: è un album autobiografico, nel quale la dimensione del ricordo (e del racconto) è sempre presente e fondamentale, e non a caso Batiste ricorre alla propria viva voce per tutte le tracce dell’album, sia che si tratti di canto che di rap; ma è anche un album che si lascia alle spalle la nostalgia fine a se stessa e che vive nel proprio tempo, e di questo tempo parla, senza mai staccarsi dalla realtà dell’oggi in tutti i suoi aspetti (anche e soprattutto quelli più contraddittori) e senza assolutamente mai rinunciare alla potenziale immaginazione di un domani diverso; infine, è soprattutto un album che celebra e eleva un inno alla tradizione musicale dalla quale nasce, e che reinventa progressivamente e incessantemente, attestandone l’assoluta vitalità. WE ARE è un disco che, più di molti altri, rappresenta e interpreta il mondo in cui viviamo: perché è nato nella tempesta delle proteste del Black Lives Matter, nelle piazze e nei cortei guidati dallo stesso Batiste nel maggio e giugno del 2020, insieme inno e protesta, canzone di lotta e d’amore, affermazione orgogliosa delle proprie radici, della propria tradizione, e inesausta, appassionata apertura verso il futuro. È un meccanismo che si autosostiene, un moto perpetuo teso verso l’emancipazione e la libertà e la dignità che a tanti è stata ed è tuttora negata. È ovviamente anche un bellissimo album sulla ricchezza di una larga fetta di umanità e che combatte con la forza della musica e della gioia la meschinità di uno società chiusa a riccio su se stessa, apparentemente dedita con tutte le proprie forze a negare ogni dignità a qualunque istanza diversa nel tentativo, egoistico e destinato al fallimento, di preservarsi e autoassolversi: tra sprazzi autobiografici (lo straordinario trittico BOYHOOD/ MOVEMENT 11’/ADULTHOOD), inni alla gioia sovrumana, impetuosa, abbagliante e sfrenata (FREEDOM), canti di protesta che si fanno canti d’umanità (WE ARE), dolorose riflessioni sull’innocenza perduta (CRY, mamma mia che pezzo!) e funk irresistibile (e politico, come in SHOW ME THE WAY), WE ARE è uno dei dischi più belli, profondi e commoventi che abbia avuto la fortuna di ascoltare in tutta la mia vita. Roba da far tremare le vene e i polsi, ma di gioia.
 Songwrights Apothecary Lab (Esperanza Spalding, 2021)
Songwrights Apothecary Lab (Esperanza Spalding, 2021)
Recensione completa qui: Healing through music
Altro disco vincitore di un Grammy nell’ultima edizione dei prestigiosi premi musicali statunitensi (nella categoria Best Jazz Vocal Album), Songwrights Apothecary Lab è l’ottavo album di studio licenziato da Esperanza Spalding, bassista e contrabbassista jazz, cantante, cantautrice e compositrice originaria di Portland (OR). Si tratta del prodotto di un autentico “laboratorio musicale”, ideato dalla Spalding sulla base dell’esperienza vissuta come insegnante presso la cattedra di Practice of Music di Harvard. Songwrights Apothecary Lab è un laboratorio che si situa a metà strada tra la didattica e la sperimentazione sonora, incentrato sull’improvvisazione (il più classico dei tòpoi jazzistici) e sulla ricerca, nell’ottica dello studio dell’interazione tra i musicisti e del superamento dei generi, operando attraverso una mescolanza tra la grammatica del jazz, quella delle musiche contemporanee provenienti da ogni parte del globo e la scrittura vera e propria, che in Italia potremmo definire semplicemente cantautorato ma che è molto più evocativa se presa nell’accezione inglese di songwriting, la scrittura di canzoni come forma espressiva, forma conferita al flusso dell’improvvisazione, creta lavorata dalle mani dell’artista (o degli artisti, in questo caso) per raggiungere efficacemente uno scopo. Songwrights Apothecary Lab assume allora i contorni di un’esplorazione, del diario di bordo di un viaggio intrapreso nel tentativo di condensare e distillare in dodici formulazioni (le “formwela” che, numerate, costituiscono il titolo di ciascuno dei brani) il potere della musica e della parola come elementi di cura dello spirito e di studio e comprensione della natura umana. Per usare le parole della stessa Spalding, “[S.A.L.] seeks to respectfully dip into the healing seas of music/musicianship/song, and distill a few grains of piquancy which carry the life-renewing flavor of the unfathomable ocean of human resiliency, then work those grains into new musical formwelas, to enhance the healing flavors and intentions innate in all works of devoted creatorship”. Musica come luogo di cura dell’anima, quindi, per rispondere all’auspicio di John Coltrane secondo il quale If one of my friends is ill, I’d like to play a certain song and he will be cured: un’opera di amore e fiducia sconfinate nel potere della canzone come balsamo per alleviare il dolore e aiutare a superare le difficoltà. Dal punto di vista compositivo, il discorso di Songwright Apothecary Lab è sostanzialmente tripartito, e altrettanti sono i momenti quali l’album è stato pensato e registrato: una prima sezione che ha visto la luce durante una residenza a Wasco County (OR), una seconda sezione nata a Portland (OR) e un’ultima parte realizzata in studio a Lower Manhattan (NYC), coinvolgendo di volta in volta diversi artisti come membri di questo grandioso “progetto di ricerca sonora”. Il risultato sono 12 brani eccezionali (con un tredicesimo episodio pubblicato a posteriori nel corso di quest’anno), che mescolano il jazz intimista, le ritmiche diseguali, l’invocazione (quasi)religiosa e un senso di laicissima meraviglia di fronte all’umano e al suo posto nel mondo in una successione di meraviglie benedetta dalla voce senza tempo della Spalding, che sembra provenire proprio da un altro pianeta. Songwrights Apothecary Lab regala un’ora tonda di pura beatitudine musicale (e non solo): suoni e atmosfere che fanno bene allo spirito, un flusso inesausto di invenzioni, idee ed emozioni. Musica allo stato puro, di un romanticismo quasi primigenio, per quanto assolutamente e irriducibilmente contemporanea, piena di una vitalità contagiosa che pesca tanto dalla tradizione del jazz quanto dalla musica nera più moderna, tenendo insieme un mondo che affonda le radici in un tempo lontano ma resta ancora tutt’oggi il vero cuore pulsante dell’innovazione musicale: stiamo parlando di un’esperienza, prima ancora che di un semplice ascolto, qualcosa che spinge i limiti un po’ più in là, qualcosa di davvero, profondamente innovativo: queste dodici tracce rappresentano lo sforzo di mettere in musica e plasmare l’esperienza, totalmente e irriducibilmente personale, attraverso la quale ascoltiamo e sentiamo (con le orecchie e con lo spirito) il potere curativo della musica.
Con questo si chiude il best of di questo 2022, e a me non resta altro da fare che augurarvi un buon anno e darvi appuntamento a domani per l’ultimo post riepilogativo di quest’annata, dedicato interamente a sua maestà il basso elettrico!





