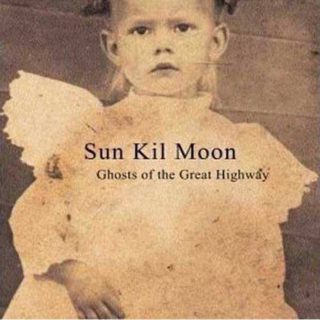E niente, James Blake ci ha preso gusto: dopo una manciata di pezzi nuovi e un intero EP di inediti (Before, ne parlavamo nello scorso Round-Up), arriva la notizia di un EP di cover di prossima pubblicazione: si intitolerà, semplicemente, Covers EP e vedrà la luce il prossimo 11 dicembre. In giro si trovano varie anticipazioni sui brani che potrebbero far parte di questa breve raccolta, dalla cover di Godspeed di Frank Ocean (ne avevamo già parlato) fino a When the party’s over di Billie Eilish, per non parlare dell’ormai arcinota A Case Of You, spettacolare rilettura del classico di Joni Mitchell che verrebbe ripescata per l’occasione, a quasi 10 anni dalla sua prima pubblicazione (anche quella volta in un EP, Enough Thunder, pubblicato pochi mesi dopo l’uscita del folgorante album di debutto del nostro). Di sicuro ci sarà questa versione intimista per solo piano e voce (e che voce!) del grande classico The First Time ever I saw your Face, scritto dal cantautore inglese Ewan MacColl nel 1957 per la cantante americana Peggy Seeger ma portato al successo nel 1972 da Roberta Flack in una seducente versione di ballad soul: un brano che si sposa alla perfezione col romanticismo minimalista e dolente di Blake, che quando lo metti davanti a un pianoforte e a un microfono, magari spogliandolo degli orpelli di cui spesso (non a torto) ama rivestire la propria musica, fa sempre cose decisamente sopra la media. Per tutto il resto, basta la prima strofa di questo canto privo di autentici ritornelli (ve la lascia qua sotto nella versione suonata da Blake dal vivo al Tonight Show di Jimmy Fallon):
The first time
Ever I saw your face
I thought the sun
Rose in your eyes
And the moon and the stars
Were the gifts you gave
To the dark
And the endless skies
Ora parliamo di un doppio singolo che precede un album in uscita, e che in particolare esce proprio oggi venerdì 4 dicembre: si tratta del disco orchestrale Odin’s Raven Magic, che segna il ritorno dei Sigur Rós a sette anni dalla pubblicazione di Kveikur, datato 2013. Io personalmente sono da sempre un gran fan della band islandese anche se, devo ammetterlo, negli ultimi tempi, diciamo dall’uscita di Með suð í eyrum við spilum endalaust, datato 2008 (momento commozione: lo recensivo anche qui, mentre qui parlavo del loro splendido concerto a Firenze), i (per la verità, pochi) passi compiuti dalla band non mi hanno lasciato grandi sensazioni. Oggi pare che i Sigur Rós siano rimasti sostanzialmente in due, il cantante e chitarrista Jónsi (al secolo, Jón Þór Birgisson) e il bassista Georg “Goggi” Hólm: i tempi dei capolavori Ágætis byrjun, ( ) e Takk… sono lontani, ma questo nuovo album in realtà è un po’ un ritorno al passato, il recupero di una vecchia performance orchestrale imbastita dalla band quando era ancora un collettivo di quattro musicisti (c’erano anche Orri Páll Dýrason dietro le pelli e i piatti e soprattutto il talentuoso Kjartan “Kjarri” Sveinsson alle tastiere e a dirigere le orchestrazioni e gli arrangiamenti), realizzata col contributo delle fedelissime Amiina e portata in scena col leggendario musicista e capo religioso Hilmar Örn Hilmarsson e con la voce profonda e recitativa di Steindór Andersen, musicista e declamatore di Rímur, tipico metro del poema epico tradizionale islandese, non nuovo alle collaborazioni con la band di Jónsi (si pensi proprio all’EP Rímur, del 2001). Proprio di epica si parla qua: il racconto per musica e versi ispirato al poema Hrafnagaldr Óðins, opera scritta nello stile dell’Edda Poetica e che coinvolge numerose figure della mitologia norrena. Questa riproposizione musicale fu presentata dalla band per la prima volta il 24 maggio del 2002 al Reykjavík Arts Festival, coi contributi succitati: per parlare un po’ anche di musica, ad anticiparne la versione su disco arrivano quindi Stendur æva e Dvergmál. Nel primo brano la voce salmodiante di Andersen si arrampica dapprima su un accompagnamento di vibrafoni per poi alternarsi all’orchestrazione prepotente degli archi e ai piccoli glitch che fanno da sfondo per l’inquietante oscurità edificata da cori sacrali; c’è spazio anche per tornare ad ascoltare la voce senza tempo, magica e multiforme di Jónsi, quel Vonlenska che abbiamo imparato ad amare senza remore fin dai tempi del debutto di Von (pubblicato nel 1997, quando andavo ancora alle medie: ebbene sì). Soprattutto, questo brano come il seguente rappresentano la grande occasione di tornare a godere della potenza evocativa degli arrangiamenti scritti da Kjartan Sveinsson e dalla moglie Maria Huld Markan Sigfúsdóttir (già parte delle miina): particolarmente affascinante l’orchestrazione dello strumentale Dvergmál, a metà strada tra la potenza rock del classico repertorio dei Sigur Rós (mi vengono i brividi a risentire lo shuffle di Orri: ed è subito Gong) e le orchestrazioni di archi dal tipico sapore Amiina. Quella di Odin’s Raven Magic si presenta come una musica cinematica, evocativa: i Sigur Rós al loro meglio, quelli che dipingono landscape, che danno forma a montagne, vallate, ghiacciai e vulcani, una musica che è al tempo stesso mitopoiesi e geopoiesi (se mi si passa il termine, che non so bene se esista), musica che viene da un altro mondo e crea e dà forma a una realtà, la definisce. Qualcosa, banalmente, di magico ed evocativo, proprio come ai bei tempi. Per chiudere con le parole di Hilmar Örn Hilmarsson, un po’ predicatore pagano e un po’ artista:
Hrafnagaldur Óðins [Odin’s Raven Magic] has lots of interpretation and implications that fire up the imagination… It’s a very visual poem, with images all about falling down, and a world freezing from north to south. It was an apocalyptic warning. Perhaps the people of the time felt it in their skins. Today, of course, Iceland is involved in environmental issues surrounding hydro-electric power and the destruction of the highlands. We are being warned again.
Quando venne pubblicato Ghosts of the Great Highway, primo lavoro discografico licenziato a nome Sun Kil Moon, questo moniker non identificava ancora l’alter-ego solista di Mark Kozelek, del quale tanto si è parlato su queste pagine negli ultimi anni (non serve che vi ricordi quanto io sia innamorato del lavoro del buon Markolino), ma una vera e propria band, guidata ovviamente da Kozelek e che comprendeva l’altro transfugo dai Red House Painters, Anthony Koutsos, alla batteria, Geoff Stanfield e Tim Mooney. Era il 4 novembre del 2003, l’esperienza dei Red House Painters si era conclusa appena un paio d’anni prima: Ghosts of the Great Highway sembra tuttavia ripartire proprio dallo spleen esistenziale e dagli intarsi elettro-acustici che tanto definivano il sound e la discografia della prima band di Kozelek (nonché sua prima incarnazione come songwriter, cui molte altre ne sarebbero seguite), come a negare una cesura veramente netta con quanto era stato, forse un chiudere i conti. Anche questo cambierà, nello sviluppo del progetto Sun Kil Moon, soprattutto non appena la dimensione della band verrà soppiantata da quella solista, virando decisamente sul cantautorato in versione acustica: ma in quel 2003 erano ancora chitarre elettriche ruvide e vagamente ipnotiche, una psichedelia in bianco e nero, elenchi di nomi di pugili eletti a protagonisti di storie ora paradossali, ora dolorose, il fantasma grigio della Grande Autostrada che attraversa l’America, avvolta nella nebbia. Pensate soltanto che il disco comincia con un paragone tra il dualismo Cassius Clay/Sonny Liston e quello tra i due chitarristi dei Judas Priest K.K. Downing e Glenn Tipton, un incipit paradossale per un brano, intitolato appunto Glenn Tipton, che parla fondamentalmente di solitudine e della difficoltà di amare (I buried my first victim/ When I was nineteen, canta Kozelek, usando una delle sue consuete metafore concilianti, stavolta quella del serial killer, per descrivere come ci si senta alla fine di una relazione), e lo fa su un sottofondo pienamente folk. È sempre l’amore, quello provato (ma non piegato) dalla morte per cancro dell’amata Katy (proprio lei, quella di Katy Song, di San Geronimo, di Summer Dress…) a costituire il centro del primo instant classic del disco, Carry me Ohio (Sorry that/ I could never love you back/ I could never care enough/ In these last day), una digressione di rock doloroso, di un dolore che non ha soluzione catartica:
There are songs that have nothing to do with this, but a lot of the record is my attempt at—not so much putting what happened with Katy to bed, but what happened with Katy actually happened right at the very end of making Ghosts Of The Great Highway. It was just the last couple of months that I was working on that record, this crazy thing happened. And I think after she passed, for me to have written about it at that time, or for me to have dealt with it in a creative way at that time, it would have been very cathartic. I don’t think it would have been beautiful. I think I needed some years to pass, and some time to pass, before I could handle it all, to write about it and sing about it in a gentle way, where I was actually sort of paying tribute to someone, rather than just moaning about someone being gone.
And that’s really the main theme in the album for me, just getting to a place where I—I don’t know. I’m more at peace with it than I was years ago. When someone important to you, someone that’s played a big role in your life, when they’re gone… When you write about them or pay tribute to them, you want to do it in a way that’s thoughtful. I think I just felt that way with this record. Songs that I wrote about her in the past—”Katy Song,” “Summer Dress,” “San Geronimo”—some really beautiful things… And I think I wanted to continue that, where I want beautiful songs to be written about this person. I think that if I had tried to write this record three or four years ago, it would have just been a horrible mess. But I think that I got to a place where I was able to put it together the way I did. So maybe that’s why it has sort of a peaceful, kind of serene feeling.
(L’intervista intera, dalla quale proviene questo estratto, la trovate cliccando qui)
C’è poi la splendida cavalcata di quasi sette minuti che prende il nome di Salvador Sanchez, celebre pugile morto giovanissimo in un incidente d’auto (Salvador Sanchez arrived and vanished/ Only twenty-three with so much speed/ Ownin’ the highway) ma che in realtà sfrutta una lista di nomi di pugili morti per proporre una potentissima riflessione sulla fragilità e sulla mortalità, squassata dalle distorsioni granulose delle chitarre e tagliata a metà da un assolo acidissimo: se la vita, come altre volte Kozelek ha suggerito, non è altro che un incontro di boxe, dove vanno a finire tutti questi giovani pugili sconfitti? How have they gone/ Felled by leather/ So alone but/ Bound together? Solo brividi. Last Tide si ricollega tematicamente a Carry me Ohio, e musicalmente in qualche modo a Summer Dress, col suo ritornello accarezzato dagli archi (Will you be here with me, my love/ When the warm sun turns to ash), così come ancora alla figura di Katy e a quell’amore spezzato sembra far riferimento la preghiera acustica di Floating (Come to me/ My love/ One more night/ Come on/ Cause I just wanna hold you close/ Again). La deliziosa ballad Gentle Moon echeggia panorami alla Nick Drake, e travolge con le emozioni esplose dal confronto tra la voce dolente di Kozelek e gli archi del San Francisco Conservatory; le fa da contrappunto l’up-tempo vagamente rumorista di Lily and Parrots, in un’alternanza di episodi diversissimi che convivono magicamente, cui segue la lunghissima e destrutturata Duk Koo Kim, che prende il nome da un altro pugile e sembra ritornare alle atmosfere di certi “free form” che abbondavano nella discografia dei Red House Painters (penso a brani come Moments, o ancora San Geronimo e la già citata Katy’s Song). Dentro Duk Koo Kim si stende una prateria sonora sconfinata, e l’asfalto della Grande Autostrada diventa la grana sulla quale la penna di Kozelek può incidere una riflessione torrenziale su Vita, Amore e Morte: il torrenziale stream of consciousness che dominerà molti dei dischi dei Sun Kil Moon a venire (gli ultimi in particolare) è ancora lontano, eppure i temi sono gli stessi, e il piglio del cantautore che parte dalle facezie della vita quotidiana per costruire un’epica è assolutamente invariato. Oltre tutto, Duk Koo Kim gode di un flusso sonico distorto, un calor bianco affascinante e abrasivo, solo in apparenza aggressivo ma in realtà quasi catartico (stavolta sì), cullato ora da arpeggi della chitarra ora dalla voce suadente e dolente di Kozelek: la digressione si spinge a lambire territori quasi ambientali, arrivando a mescolare punteggiature di xilofoni a chitarrine spagnoleggianti (altro vezzo caratteristico del Kozelek compositore), per poi spegnersi su un malinconico riff di chitarra distorta appoggiato sopra ipnotici arpeggi dell’acustica. Sono quasi 15 minuti di catarsi autentica, una musica che abrade il corpo e lenisce lo spirito. C’è tempo ancora per lo strumentale mariachi Sì, Paloma, altra digressione, altro episodio contrastante inserito dentro un flusso inesausto che conduce a Pancho Villa, reprise in versione completamente acustica di Salvador Sanchez, che pure diventa un altro brano, sospeso e incantato come le storie di morte e di vita che racconta, racchiuse nei nomi dei suoi protagonisti. E si torna ad un nome, Sun Kil Moon: che sarebbe un omaggio al pugile coreano Sung-kil Moon, che contemporaneamente suona come un bizzarro e semplicistico haiku (una forma di poesia non aliena all’ispirazione secca e vibrante del primo Kozelek: basti pensare al ritornello della meravigliosa Dragonfly, basato appunto su un haiku di Chiyo-ni, o più in generale alla passione del nostro per la cultura e la lingua giapponese, che traspariva ad esempio già in Japanese to English), e che è assonante con l’inglese Sun Kill Moon (anzi, è praticamente la stessa cosa), la luce che uccide le tenebre, la notte che prevale sul giorno. Ghosts of the Great Highway attraversa la notte della Grande Autostrada (un’altra metafora, molto scoperta), affrontandone i fantasmi (quelli della morte, dell’abbandono, della mancanza d’amore) per tornare a cantare la speranza di un amore che ci tenga per mano fino all’ultimo respiro, che opponga la sua forza al potere annichilente e invalicabile della morte: si attraversano le dieci tracce di questo canzoniere ribattezzato intitolato ai Ghosts of the Great Highway, i fantasmi che popolano il tempo che ci è concesso, come si attraversa la vita, cercando di superare la paura, sconfiggere il dolore e la solitudine, o almeno cercare di imparare a conviverci, nel disperato tentativo di conoscere, custodire e sapere essere all’altezza del vero amore. Come tutti gli esseri umani prima e dopo di noi, All alone/ And bound together.