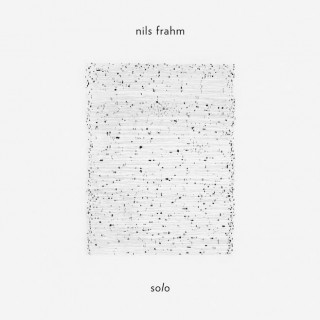E anche questo 2015 giunge al termine: un’annata niente male, a dire il vero, con un sacco di bella musica e grandi concerti. Dal momento che tendo a diventare sempre più pigro e ad avere sempre meno tempo per questo blog, dopo essermi ripromesso per mesi di scrivere post sulla musica che mi ha accompagnato durante questo anno, e sui concerti cui ho avuto la fortuna di assistere, e dopo aver anche iniziato a scrivere alcune cose ed averle sempre mollate lì senza mai chiuderle (a proposito: c’è nell’hard disk una recensione di un film che ho visto un mesetto fa e che pubblicherò a breve, è una promessa), ho deciso di tornare a sfruttare l’escamotage già sperimentato alla fine dello scorso anno e farvi una breve panoramica di tutto ciò che, musicalmente, è valso la pensa di ascoltare durante questo 2015. Per tener conto di tutto, ho elaborato una breve lista di 5 + 1 + ½ dischi usciti quest’anno che hanno catalizzato la mia attenzione, rinforzandola con una breve raccolta di titoli che ho (ri)scoperto negli ultimi dodici mesi, soprattutto grazie alle persone che ho avuto accanto, e non necessariamente pubblicati nell’ultimo anno, per chiudere con un brevissimo resoconto nostalgico di tre serate di musica dal vivo che porterò nel cuore piuttosto a lungo. Visto che comincio a farmi verboso, forse è il caso di partire. Ah, questo è il momento in cui dovrei rivelarvi come il buon proposito di essere “breve” sia andato rapidamente a farsi benedire durante la stesura del post: ed ecco che ho deciso di dividere questo intervento in tre parti, da pubblicarsi in questi ultimi 3 giorni dell’anno. Gente, che vi devo dire? Con i verbosi ci vuol pazienza. Andiamo con la prima parte, quindi.
My 5 + 1 + ½ favourite records of 2015
Intanto, dato che è risaputo che 2 persone su 4 non sanno semplificare le frazioni, soprassediamo sul titolo di questa sezione: tanto tutto sarà chiaro a breve. Si rammenta che la lista è da intendersi in rigoroso disordine di importanza.
L’11 settembre del 2015 ero rientrato a lavoro da 5 giorni dopo aver partecipato ad una conferenza internazionale sulla Fisica e la Chimica delle Alte Pressioni a Madrid, ed ero ovviamente affaccendato in tutta una serie di faccende relative per lo più a esperimenti impossibili e tesi di laurea in bilico. Ma quel giorno lì usciva anche questo disco. Sui Low penso si siano spese tutte le parole possibili lungo la loro ultraventennale carriera, quindi è chiaro che non riuscirò ad aggiungere assolutamente nulla: non ci provo neppure. Dico soltanto che Ones and Sixes è, per me, il miglior disco della band di Duluth dai tempi di Drums and Guns, e parla uno che adora anche quelli che stanno nel mezzo. Il fatto è che Ones and Sixes riunisce in sé un po’ il meglio di The Great Destroyer e, appunto, Drums and Guns: la sperimentazione (anche elettronica, si pensi alla drum machine dell’iniziale Gentle) e le chitarre rock (No Comprende), il gusto innato per la Melodia (la maiuscola non è casuale, leggasi Spanish Translation e Into You, tanto per citarne due soltanto) e le progressioni emotivamente squassanti nei crescendo di tipico marchio-Low (Landslide, un’autentica slavina sonora che travolge tutto e tutti e dal vivo rappresenta l’equivalente demistificato di una catarsi estetica… ma di questo parleremo nel terzo post). Sono 12 brani e non se ne trova uno che sia meno che perfetto, meno che vero: perché i Low fanno musica semplice che tocca le (poche) corde giuste, le uniche che valga la pena stuzzicare.
 Get to heaven (Everything Everything)
Get to heaven (Everything Everything)
Chi scrive ha preso in simpatia questi cinque ragazzotti di Manchester fin dagli esordi di Man Alive, anzi: fin da quel lontano pomeriggio in cui, su MTV (quando MTV trasmetteva ancora video musicali), si imbatté nel video di un pezzo abbastanza delirante da attrarre la sua attenzione. Il pezzo in questione si intitolava MY KZ, UR BF, e nella sua mescolanza di tempi dispari, ritmiche serrate e indecifrabili e falsetti al limite della castrazione chimica, rapì la mia attenzione all’istante. Gli anni sono trascorsi non invano, perché nel 2015 i nostri se ne sono usciti con questo doppio disco (per un totale di 17 tracce nell’edizione deluxe) che segna proprio quella che i parrucconi impomatati delle riviste definirebbero la “maturità artistica” della band. Già perché in Get to heaven c’è proprio tutto, e tutto al posto giusto: dal grandioso stacco strumentale che introduce al ritornello dell’iniziale To The Blade (un brano di una potenza rara) agli incredibili interplay di voce e batteria nelle strofe di Distant Past; dalle ritmiche serrate e vagamente (vagamente?) anni ’80 della title track, Get To Heaven, alle altalene sonore di Regret al ritornello trascinante di Spring/Sun/Winter/Dread; dai barocchismi atmosferici di The Wheel (is turning now) alla tiratissima Fortune 500, dalla velocissima Blast Doors agli ulteriori barocchismi di Zero Pharaoh fino al liberatorio crescendo elettronico di No Reptiles che introduce alle ritmiche de-va-stan-ti di Warm Healer (e qui per un bassista fissato con l’interplay strumentale la sillabazione è praticamente d’obbligo). E nel secondo disco (che troppo spesso raccoglierebbe gli scarti) si incontrano altre perle: tanto per fare due titoli soltanto, Brainchild e la (quasi completamente) strumentale Yuppie Supper. Che dire? Sconfinate capacità tecniche e compositive unite ad un gusto surreale e paradossale nei testi. Qualche brillante pensatore/musicista/capopopolo moderno su Facebook (beh, più che altro un rosicone) ha ribattezzato questa band, pensando di essere simpatico, “Niente Niente”. Sarà: il giorno che in tuo lavoro frullerai tante suggestioni e ispirazioni quante dimostrano di essere in grado di metabolizzarne e rielaborarne questi cinque ragazzi, ne riparliamo.
 Universal Themes (Sun Kil Moon)
Universal Themes (Sun Kil Moon)
Dio benedica la prolificità di Mark Kozelek, e che quello che personalmente considero uno dei maggiori cantautori americani viventi (se non direttamente il maggiore) possa palesarsi in questa classifica ogni anno con lavori di livello sempre più alto. Universal Themes giunge a circa un anno dall’exploit di Benji (di cui si parlava nel Best of del 2014), una delle cose migliori che io abbia mai ascoltato in vita mia (a tutti i livelli, per musica e testo), e si pone contemporaneamente in un’ottica di miglioramento e rielaborazione e autentico superamento: si tratta di otto tracce molto lunghe, assai meno basate sull’interplay chitarra-voce che rendeva meravigliose le malinconiche gemme cosparse lungo il suo predecessore e costruite invece sul suono di un’autentica band, con passaggi che oscillano dalla classica ballad (Birds of Flims) a un suono sporco e quasi garage (With A sort of Grace I Walked to the bathroom to cry) fino al blues sbilenco con un assolo/parte strumentale memorabile (che io personalmente adoro, e si trova dentro Cry me a river Williamsburg Sleeve Tattoo Blues), con la voce che percorre i brani sempre meno cantando e sempre più con un incedere a metà tra il sussurrato e il parlato/recitato. La cifra stilistica che caratterizza questo album è la rottura: i brani sono spezzettati al loro interno, costruiti per giustapposizione di pieno (i passaggi strumentali e vocali principali) e vuoto (gli stacchi strumentali basati solitamente sulla sola chitarra acustica e che rimandano, per le scelte armoniche, ad album come Admiral Fell Promises). Su tutto, spiccano i testi di Kozelek, che sono riflessioni su temi di portata universale: l’amore, la morte, la gratitudine, lo sbigottimento di fronte ai casi della vita. Che stia parlando di un opossum moribondo trovato nel suo giardino (The Possum), dell’ultimo film di Paolo Sorrentino in cui si è trovato a recitare (un po’ ovunque lungo il disco, con esiti a dir poco divertenti, tipo nella già citata Birds of Flims e soprattutto nella splendida conclusiva This is my first day and I’m an indian and I work at a gas station, che contiene numerose riflessioni su questa esperienza sul set, culminate nel geniale distico “This movie set’s doing weird things to my head/ I’m not Italian, I’m not Swiss, and I can’t act, and I don’t exactly fit in it”), della morte di una persona cara (la già citata With a sort of grace…) o di un incontro di boxe e tutti i ricordi che trascina con sé (Ali/Spinks 2), Kozelek riesce sempre a parlare a una parte di te, come quando leggi un libro e vorresti che il suo autore fosse amico tuo per sempre, per poterci parlare al telefono quando ti pare: ecco, questo disco è così, è un po’ un disco-confessione in cui tutto un vissuto viene frullato, rielaborato e sputato fuori, e la simbiosi tra chi canta le proprie ossessioni e chi, ascoltandole, vi riconosce un pezzo della propria solitudine è praticamente essenziale perché il gioco funzioni. Ma insomma, i grandi artisti sono tali proprio perché sanno porre le giuste domande, e Mark Kozelek è senz’altro il più grande in questo.
Faccio un mea culpa: fino allo scorso giugno, per colui che scrive, il nome XX era sinonimo di Vcr, un pezzo che peraltro ho sempre considerato molto bello, e poco più. Poi capita che incontri persone che ti fanno capire che sei assai più ignorante di quanto vorresti ammettere, e però non ti arrabbi per questo (nonostante tu sia anche grossolanamente permaloso), anzi: sei loro grato in un modo che non sapresti nemmeno spiegare a parole perché, se quel giorno non avessero stanato un po’ della tua ignoranza chiedendoti “ma l’hai mai ascoltato Jamie XX?”, probabilmente non ti sarebbe affatto venuto in mente di cercare questo disco. È così difficile saltare lo steccato delle proprie autoconvinzioni, e poi forse sarebbe accaduto comunque, ma sarebbe stato assai meno dolce e malinconico ripensarci e provare a parlarne. Però aiuta anche a settare un po’ il mood: perché In Colour è colorato e chiassoso come il titolo promette, ma è contemporaneamente retrò, tenero e malinconico come quel synth che si insinua fino a conquistarsi l’intera scena lungo i quasi 5 minuti dell’iniziale, splendida Gosh; è ovattato, lieve come i rintocchi dell’eterea Sleep Sound; irresistibile e catchy (tanto per abbondare in termini tecnici che farebbero la gioia di RockIt) come la bellissima SeeSaw; sgangherato e caleidoscopico come Obvs; romantico e nostalgico come Stranger in a Room, accompagnata dalla voce di un sylvianiano Oliver Sim, un pezzo che dura troppo poco ma potrebbe tranquillamente andare avanti per giorni senza stufare nemmeno un po’; danzereccio ma contemporaneamente rallentato, malinconico nella più piena essenza del termine, come in Loud Places, in cui si eccede col gating e si stratificano percussioni e campanellini gli uni sugli altri; pesante e martellante come in The Rest is Noise e Girl. Jamie Smith recupera due-tre decenni di club culture inglese e li trasforma in un prodotto sfaccettato, pieno di sfumature, un caleidoscopio di colori e sensazioni nel quale è così piacevole restare intrappolati da desiderare di non doverne più uscire: capita solo coi lavori migliori. La mia storia con questo album potrebbe continuare ma in realtà è strettamente legata a altre cose che, in parte, lambirò più avanti in questo resoconto del 2015 musicale e quindi per adesso l’abbozzo qui: però un grazie a chi mi ha fatto impattare contro questi circa 40 minuti di musica ci sta tutto.
Quando, questo Maggio, sono stato a Berlino, sono tornato dalla mia classica puntata da Dussmann- Das Kultukaufhaus con (solo) tre cd: di uno dei tre parlerò nel secondo post, tra i titoli riscoperti, perché trattasi di un disco uscito nel 2014; del secondo non parlo, perché m’ha fatto abbastanza pietà (devo ammettere che la tecnica del “compro i dischi quando una copertina mi piace” ha qualche punto debole su cui lavorare); e il terzo è questo, un album per solo pianoforte, suonato da un ragazzo tedesco chiamato Nils Frahm. Si può liberamente pensare che un disco di pianoforte solo sia una palla cosmica e immensa, ma in questo caso si sbaglierebbe di brutto: perché So/o è un disco fatto di poche, pochissime cose (e poche, pochissime note) il cui incastro è però di una delicatezza e precisione tale da far gridare, in più di un passaggio, al miracolo. Frahm ripete e intreccia frasi brevi e semplici come mantra, tutti mattoncini di una costruzione circolare e seducente di autentica Bellezza, e le sparpaglia lungo otto tracce, svariando dall’appena percettibile (Some) al fortissimo (Wall), da una raffinata e romantica malinconia (Ode) al suono che fanno le onde sul mare che interferiscono costruttivamente tra loro (Circling) fino al prodigioso swing atmosferico di Immerse!, una lunghissima digressione di quasi dieci minuti, un lentone dalle imprevedibili suggestioni quasi-ballabili disseminate in una manciata di note sparpagliate con un’eleganza abbagliante lungo lo spazio e il tempo di un brano che occupa tutte le 4 (o 11, che crediate o meno alla Teoria delle Stringhe) dimensioni conosciute o solo ipotizzate, ideale preludio per la chiosa ipnotica di Four Hands. Se pensate che il pianoforte sia ‘na roba pallosa e fondamentalmente da vecchi o (ancora peggio) tendete a identificarlo con Giovanni Allevi, risciacquatevi le orecchie (e l’anima) con questi 40 minuti di Meraviglia Assoluta: e ricordate che lo fate per voi stessi! (Purtroppo, su YouTube i video relativi a questi brani non si trovano: fatevi un account Spotify e cercate Nils Frahm, sicuro ne vale la pena).
Il mio +1 in questa lista sono gli Snow in Mexico, con l’ultimo EP, Juno Beach: +1 perché, appunto, trattasi di EP e non di un long playing (ok, mi sto arrampicando sugli specchi). Questo duo romano lo conosco da ormai 6 anni, e del loro primo EP ho parlato proprio qui, e con uno di loro due devo anche aver parlato via e-mail, o almeno così mi pare: i nostri sono partiti da uno shoegaze venato di tentazioni elettroniche per sviluppare, negli anni, un sound sempre più sfaccettato e personale che ha condotto dalla bellissima You and My Winter al dream pop elettronico venato di anni ’80 di questo ultimo lavoro. Andrea Novelli (sintetizzatori e drum machine) e Massimiliano Cruciani (voce e chitarra) non suonano, tessono: intrecciano con maestria i fili vibranti di panorami musicali imprevedibili, costruendo stratificazioni di suoni elettronici e campioni vocali come in The Call o scrivendo semplicemente il pezzo pop quasi perfetto con la title track Juno Beach, un meccanismo a orologeria in cui tempeste di synth lavano via il colore dall’immagine di una spiaggia immortalata e filtrata via Instagram, in cui le luci all’orizzonte si accendono in uno scampanellio elettronico graffiato dagli svolazzi delle chitarre e attraversato da una melodia semplice semplice e che va dritta all’obiettivo; cavalcando sapientemente ondate nostalgiche di synth-pop come in Sunshine ed eleganti uragani di riverberi come nella conclusiva Gentle Rain. Devo ammettere che è un piacere poter guardare al passato e dire: ci avevo visto giusto. Con gli Snow in Mexico è stato proprio così: ultimamente sta capitando un po’ troppo spesso, forse dovrei cercare di non farci l’abitudine. Ma a questo punto si attende a gloria una prova sulla lunga distanza: che il 2016 possa essere l’anno giusto, anche se i nostri non sembrano avere fretta (e giustamente), come dimostrato dai lunghi lassi di tempi intercorsi tra le prove precedenti. Tuttavia, il materiale per andare avanti e fare (se possibile) ancora meglio, c’è tutto. Ad maiora!
E il mio + ½ non è per un album né per un EP ma, più prosaicamente, per una singola canzone (almeno la coerenza logica interna di questo delirio è salva): si intitola Steal Away ed è stata scritta, suonata e cantata da un ragazzotto australiano di stanza a Berlino, che dovreste già conoscere se avete letto il listone degli album del 2014, ovvero Jackson Dyer. Dyer è un ottimo chitarrista e, soprattutto, un grandioso cantante, abilissimo nel ripulire e mascherare le proprie maggiori ispirazioni nel sound scarno della propria musica: o almeno, così è stato fino a questa Steal Away, singolo di lancio di un EP prossimo venturo che dovrebbe essere in lavorazione. Già, perché questi 4:44 sono più che abbondanti per capire come nella musica di Dyer si nasconda una vena soul travolgente, e il sound maggiormente band-oriented rispetto ai capitoli precedenti non fa che rafforzare questa sensazione. Niente da dire sul gusto dell’arrangiamento, bisognerebbe invece spendere righe e righe sulla bellezza cristallina delle linee melodiche: però non credo che sarei in grado, mentre invece ogni espressione musicale che abbia a che fare con l’anima e la sua esposizione merita di essere ascoltata con attenzione, e non ricoperta di chiacchiere. Ergo, seguite il consiglio: ascoltatevi il buon Jackson e, come me, restate in fervente attesa del prossimo capitolo (o del prossimo incontro casuale in un concerto improvvisato al Mauerpark o da qualche altra parte per le strade di Berlino). Mentre ci pensate un po’ su, vi lascio qua sotto il player SoundCloud. Buon ascolto, e a domani con la seconda parte di questo “Best Of…”!
(Continua…)