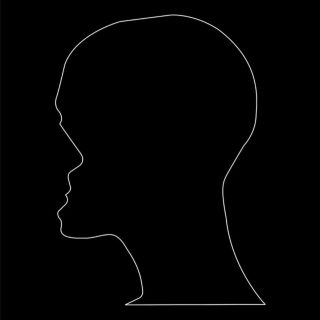Accompagnata da note profonde e sacrali, l’invocazione ambient di Vanish apre Cenizas, il nuovo album del compositore elettronico cileno Nicolas Jaar, pubblicato giovedì a quasi 4 anni dallo splendido Sirens (ne parlavamo qui): ma laddove il precedente poteva ritenersi un disco profondamente politico, Cenizas si pone come un’opera problematica, animata da una profonda spiritualità e attraversata da un senso incombente di inquietudine, quasi il resoconto di un viaggio verso la fine delle terre conosciute. Vanish stabilisce in maniera naturale l’umore che attraverserà tutte le restanti 12 tracce di questo lavoro, fatto di inserti percussivi concreti e melodie sotterranee, come nella successiva Menysid, su cui spesso si sviluppano interventi vocali evocativi e rarefatti: è questo il caso della title-track Cenizas, cantata in spagnolo come già accadeva in alcuni episodi dell’album precedente (su tutti la splendida No). Anche nei meandri su cui si dipana Cenizas pare di sentire l’eco delle ritmiche che scandivano una traccia come No, ma si tratta di un’eco distante, un ricordo sfuggente e ovattato. Agosto è accarezzata da un sassofono che si arrampica su una serie di rumorismi e interventi concreti, breve preludio al ritmo nevrotico e frastagliato di Gocce, sottofondo ideale sul quale appoggiare nel finale una splendida linea di basso dal sapore sintetico; Mud, l’episodio più lungo del lavoro, riprende il tono sacrale di Vanish fondendolo con una diafana salmodia della voce, che prende corpo piano piano scandita da roboanti percussioni per essere infine sostituita da un pianoforte che agonizza in un arpeggio e si spegne in un lamento sintetico, una sorta di universale preghiera lasciata risuonare dentro il corpo di un universo cavo e ostile. La breve Vacíar è un ribollire di archi sintetici e droni profondissimi che sfocia nel suono ambientale e scricchiolante di Sunder, primo singolo estratto dal lavoro, dalla cui marea indistinta affiorano a tratti passaggi ora melodici, ora ritmici e una specie di mantra recitato da una voce ripetitiva e distante (A win is a win but a loss is the death of a twin that we borrow/ Right behind my eye, right behind my eye). La giustapposizione di droni di basso e rintocchi di piano a parti vocali lontane e spesso indistinte prosegue su Hello, Chain: il brano è letteralmente tagliato a metà, quando entra in scena un coro accompagnato da interventi organistici che prende presto l’incedere di un salmo. Rubble è un episodio di fiati quasi free su un tappeto schizofrenico di suoni concreti, cui segue il piano preparato di Garden, cinque minuti di purissimo minimalismo nel quale il tema viene reiterato con un lieve sfasamento progressivo che va a creare un’ipnotica onda di marea, col risultato che il brano sembra respirare con l’accordo del ritmo delle onde che, una di seguito all’altra, si spengono sulla spiaggia (ed è invero un brano da fine del mondo, una fine del mondo di quelle che si potrebbero guardare su una spiaggia grigia sotto un cielo livido e alieno, con un mare scintillante di carta argentata). Xerox torna a stratificare suoni percussivi e ripetitivi tra i quali la voce scivola e si nasconde come in un gioco di specchi (ovviamente, specchi frantumati), mentre la conclusiva Faith Made of Silk recupera un andamento più netto, un ritmo che mi ricorda per qualche motivo alcuni episodi dei Radiohead (mi vengono in mente pezzi diversissimi tra loro ma non a caso posti in conclusione dei rispettivi album, come Videotape e Separator) e un cantato che va a cercare la dissonanza, perpetrando quella sottile nota di inquietudine che attraversa l’intero album.
In altri tempi, avrei semplicemente sottolineato come questo ultimo disco di Nicolas Jaar potesse costituire un ottimo esempio di ambient contemporanea, una sequenza di composizioni che sono di fatto dei soundscapes, dei paesaggi sonori dipinti con profondo gusto del particolare, con maniacale e elegante ricerca del dettaglio (la tempesta di suoni che letteralmente “fanno” questo disco va assaporata con le orecchie, con il cuore e con la mente, ma d’altra parte abbiamo a che fare con uno dei compositori più interessanti tra quelli che bazzicano i territori dell’elettronica odierna, e non lo si scopre certo oggi). In tempi come questi, invece, viene naturale pensare che si tratti di un disco adatto per la fine del mondo, come scrivevo poc’anzi: un album gonfio di sacralità, forgiato in un’atmosfera profondamente spirituale e che pure, nei suoi solchi e in ognuna delle sotterranee pulsazioni che lo abitano, porta alla luce, come una marea incessante, la solitudine dei sopravvissuti, uno sguardo rivolto abissalmente verso l’interno (come suggerito dallo splendido artwork) e quelle ceneri del suo titolo, che sono forse le ceneri di uno spazio, di un tempo, di un’idea, o in altre parole di un mondo, il nostro. E quindi sì, probabilmente c’è qualcosa di apocalittico in queste 13 tracce, ma (qui sta il bello) c’è anche qualcosa di caldo, di umano, che siano frammenti di voce che sembrano schizzare via come schegge di vetro da specchi rotti o frammenti di respiro, il lamento dei sassofoni o l’ipnosi mistica del pianoforte. Mentre ascoltavo Cenizas (rigorosamente in cuffia) non potevo fare a meno di pensare a una frase di Hölderlin che amo molto: “laddove aumenta il pericolo/ cresce anche ciò che salva”. Fa bene ricordarlo, di tanto in tanto.