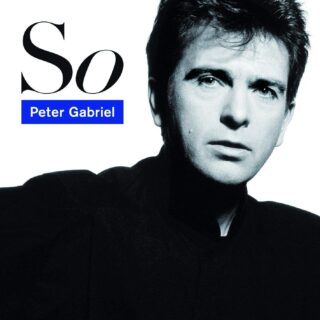There is always wisdom from hindsight. And because ‘So’ was my most successful record, I think that a lot of people, particularly in America, think that it was designed to be that. From the other end of it, you never really know which records are going to do well. You know that some things are going to be so obscure and difficult for a mainstream audience that they’re no-hopers but generally, with what I do, it’s hard to predict which albums are going to do well.
Quando So venne pubblicato, il 19 maggio del 1986, Peter Gabriel era ancora, per lo più, soltanto l’ex frontman dei Genesis. Certo, si trattava del suo quinto album solista (che seguiva quattro LP intitolati semplicemente a suo nome, sebbene noti con nomi “d’uso”, e la colonna sonora del film Birdy- Le Ali della Libertà, diretto da Alan Parker, realizzata con la collaborazione del chitarrista e produttore canadese Daniel Lanois), e certo, la personalità non aveva mai fatto difetto alle sue creazioni precedenti, ma mai prima di allora il cantante britannico era riuscito a coniugare tanto efficacemente la propria personale ricerca artistica con quell’enorme successo commerciale verso il quale So lo avrebbe proiettato, anche e soprattutto sul mercato statunitense, tradizionalmente parecchio difficile per gli artisti provenienti dal vecchio continente. Riascoltando So oggi, a distanza di 35 anni dalla sua pubblicazione, la prima cosa a saltare all’orecchio è come, dietro la maggiore accessibilità di queste tracce, si nasconda in realtà un universo musicale di riferimento non così distante da quel progressive rock che aveva accompagnato gli esordi musicali di Peter Gabriel (e che esordi!, ma questa è un’altra storia): certo, magari non si può parlare di brani di genere progressive, ma è un’attitudine senza dubbio “progressiva” quella che mescola world music (suoni del mondo che fanno capolino quasi ovunque in queste canzoni, dai flauti di bambù alle percussioni brasiliane al cantato africano di Youssou N’Dour, uno dei tanti grandi artisti che contribuiscono al lavoro), ritmiche funky, atmosfere soul (che Gabriel ha sempre amato, debitrici in particolare dei lavori di Otis Redding), canonica forma canzone rock e sperimentazioni elettroniche. Per mutuare una locuzione che, qualche anno dopo, Wim Wenders avrebbe usato per descrivere la colonna sonora del suo film più sperimentale, Fino alla fine del mondo, So fa parte di quello che potremmo definire “rock del futuro” (non è un caso che Wenders abbia incluso un brano dello stesso Gabriel in quella magnifica soundtrack, sebbene proveniente dal successivo LP Us, del 1992): musica rivolta al domani, suonata da un plotone di musicisti di classe mondiale, e allo stesso tempo un grande capolavoro di pop come non se ne incidono più, che per ricchezza di ispirazioni/aspirazioni mi ha ricordato, a tratti, un altro grande lavoro pressappoco coevo, The Dream of The Blue Turtles, primo disco solista di Sting (lavoro monumentale ma un po’ dimenticato che, a sua volta, cercava un terreno di incontro tra la forma canzone, il rock-reggae derivato dai Police e l’intensità strumentale del jazz, avvalendosi di musicisti di grande caratura provenienti proprio dagli ambienti del jazz e della fusion, come Branford Marsalis, Omar Hakim o lo stratosferico Darryl Jones).
Se la prima stesura dei brani, che ha avuto luogo nei celebri Ashcombe House Studio di Gabriel a Bath (colloquialmente noti come “Shabby Road”), si deve essenzialmente al terzetto composto dallo stesso Gabriel, da Daniel Lanois, che si siede per la prima volta dietro la console come produttore di un album dell’artista inglese (inizio di un sodalizio molto fruttuoso) e da David Rhodes, chitarrista già coinvolto, tanto per citarne solo una, nella realizzazione dello splendido The Colour Of Spring dei Talk Talk, uscito poco tempo prima (ne parlavo qui), il parterre di musicisti coinvolto nelle sessions che daranno vita a So è di quelli da far “tremare le vene e i polsi”: oltre al già citato Youssou N’Dour, che presta la voce al finale di In Your Eyes (cantando nella lingua natia wolof, che prende il nome dall’omonima popolazione senegalese), ci sono tra gli altri i batteristi Manu Katché (alla prima collaborazione importante di una luminosa carriera), Jerry Marotta, Chris Hughes e l’ex Police Stewart Copeland (coinvolto in Red Rain e in Big Time); il chitarrista Nile Rodgers, che compare su This is the picture (Excellent Birds), mentre sono gli stessi Lanois e Rhodes a occuparsi delle chitarre per i restanti brani; un’intera sezione di fiati guidata da Wayne Jackson, già collaboratore di lungo corso di Otis Redding, che stravolge i due brani più funky del lotto, Sledgehammer e Big Time; ben tre bassisti, ovvero lo straordinario Tony Levin (che tocca probabilmente qui un vertice inarrivabile come strumentista e sperimentatore del linguaggio del proprio strumento), Larry Klein (che suona uno dei primi 5 corde immessi sul grande mercato e prodotti massivamente, uno Yamaha BB5000) e Bill Laswell; i pianisti Simon Clark e Richard Tee; l’artista statunitense Laurie Anderson, che suona i sintetizzatori e presta la voce all’esperimento sonoro di This is the picture (Excellent Birds); e infine, a duettare con Gabriel, le voci di Kate Bush (su Don’t Give Up) e del frontman dei Simple Minds, Jim Kerr (su In Your Eyes insieme a Youssou N’Dour, Michael Been, Ronnie Bright e lo stesso David Rhodes), senza dimenticare il violino di L. Shankar su That Voice Again e We Do What We’re Told (Milgram’s 37).
Ad aprire So è l’oscuro magma sonoro di Red Rain, il cui testo venne ispirato a Gabriel dal sogno di un mare vermiglio e dalla figura di uno dei molti Rael che hanno sempre affollato le sue liriche, quel Mozo che era un carattere ricorrente dei brani dei primi due album eponimi del buon Peter (colloquialmente noti come Car e Scratch): le rullate di Copeland sui piatti, che incorniciano il drumming di Jerry Marotta, accompagnano una canzone letteralmente scolpita dalla linea di basso minimalista suonata da Tony Levin, squisitamente intenzionale e suggestiva, con una performance vocale ipnotica di Gabriel, che riscopre per l’occasione un tono profondo, graffiato e a tratti quasi gutturale, e un bridge che rimanda alla mente qualcosa della fortunata produzione di Brian Eno per The Unforgettable Fire (dall’omonimo capolavoro degli U2, pubblicato poco più di un anno e mezzo prima: da notare come Daniel Lanois avesse lavorato anche alla produzione di quell’album, e del successivo The Joshua Tree; proprio tra queste due lavorazioni si inserì, temporalmente, la produzione di So). A far seguito al rock onirico e minimalista di Red Rain è il singolo catchy Sledgehammer, scoperto omaggio di Gabriel al sound soul dell’artista che più di tutti ha influenzato la sua ricerca vocale, Otis Redding: un brano nato alla conclusione delle sessions, aperto da una linea di flauto emulata su un E-mu Emulator II Shakuhachi, sconquassato dalla sezione di fiati capitanata dalla tromba di Wayne Jackson, dal drumming esplosivo di Manu Katché (prima e unica take, come vuole la leggenda, roba da fantascienza) e soprattutto dalla memorabile linea di basso di Levin, che per l’occasione si affida a un MusicMan StingRay fretless sovracompresso, pizzicandolo col plettro e passandolo attraverso un po’ di riverbero e un bell’octaver per confezionare una frase granitica scolpita nel cuore di una scala misolidia di Re (tanto per dare un’idea della libertà creativa concessa ai musicisti durante queste sessioni). Non sorprende che Sledgehammer abbia rappresentato il primo, grande successo da classifica di Gabriel, che sarebbe stato parzialmente ripetuto nei lavori seguenti ma mai pienamente bissato: un unicum che contribuì fortissimamente al successo dell’intero album. Don’t Give Up costituisce un esempio di canzone politica, ispirata a Gabriel dal clima del neoliberismo thatcheriano della metà degli anni ’80: una storia di sconfitta e dolore, nella quale alla disperazione incarnata dal cantato di Gabriel nelle strofe fa da contraltare la speranza rappresentata dalla vocalità eterea della splendida Kate Bush. Musicalmente, all’accompagnamento delicatamente compassato di Katché si associa una linea di basso splendidamente melodica suonata da un Levin ancora in stato di grazia, che ottiene un sound ovattato e denso col semplice accorgimento di smorzare la vibrazione delle corde al ponte del suo MusicMan StingRay facendo uso di un pannolone del figlio neonato (che, non potendo per ovvi motivi lasciare a casa da solo, aveva portato con sé alle sessioni di registrazione): a un intermezzo del piano di Richard Tee, dall’andatura vagamente gospel, segue un ritorno del brano sulle atmosfere iniziali, per poi andare a spegnersi su un finale più smaccatamente ritmico, con ancora il bassista in grande evidenza. Il pop raffinato di That Voice Again esplode nelle orecchie come una sinfonia di suoni preziosi e ricchissimi: accanto al formidabile groove di Katché ci sono il Chapman Stick di Levin e le chitarre abrasive di Rhodes, a ricamare musica attorno alla linea vocale deliziosa cantata da Gabriel. Nella versione originale pubblicata nel 1986 segue a questo punto la meravigliosa In Your Eyes, spostata a conclusione della tracklist in tutte le edizioni più tarde dell’album: originariamente intitolata alla Sagrada Familia di Gaudì, In Your Eyes è una ballad a tema amoroso costruita come una profonda stratificazione sonora imperniata su una ritmica vagamente africana, disegnata magistralmente da Katché alla batteria e alle percussioni, con un ritornello irresistibile e che trae la sua forza in particolare dalle armonizzazioni vocali e dagli interventi in wolof del già citato Youssou N’Dour, un esperimento di quella world music ibrida che Gabriel aveva già frequentato nel suo precedente lavoro (Peter Gabriel IV, anche noto come Security). Qui la linea di basso è affidata al cinque corde di Larry Klein, e il brano, già di per sé particolarmente trascinante, è passato alla storia della cultura pop anche grazie all’uso che ne fece Cameron Crowe in una celebre, iconica sequenza della sua commedia romantica Say Anything del 1989. Il brano successivo resta dalle parti della world music: prendendo a prestito il titolo dai versi della poetessa americana Anne Sexton, morta suicida nel 1974 all’età di 45 anni e alla cui opera Gabriel si era profondamente appassionato, Mercy Street, dedicata proprio alla Sexton, è costruita a partire da una ritmica forró (un genere musicale tipico delle regioni del nordest del Brasile) che Gabriel aveva registrato a Rio de Janeiro con il supporto del percussionista brasiliano Djalma Correa. Per un errore tecnico, la registrazione venne accidentalmente rallentata al momento delle sovraincisioni, assumendo un carattere granuloso piuttosto peculiare che, però, permise di far risaltare brillantemente i cembali e le chitarre: il tono complessivo è riflessivo, e le due linee vocali incise da Gabriel contribuiscono a conferire un’aura ieratica al brano. Due sono anche le tracce di basso, suonate entrambe da Larry Klein, tra le quali risalta particolarmente la linea melodica, affidata ancora ad un fretless. Big Time torna a bazzicare dalle parti del soul-funk che informava anche Sledgehammer, con qualche strizzata d’occhio alle ritmiche di certi lavori di Prince: Stewart Copeland sale sugli scudi dietro le pelli, i fiati di Jackson sono ancora onnipresenti e Tony Levin inventa le celebri Funky Fingers (così, tanto per gradire… e col contributo fondamentale di Jerry Marotta). L’inquietante interludio di We Do What We’re Told (Milgram’s 37) prende spunto dagli esperimenti di psicologia sociale di Stanley Milgram, incentrati sulla comprensione dei meccanismi che portano gli esseri umani a seguire ciecamente un’autorità anche quando questa li spinga ad andare contro i propri principi: la batteria filtrata e processata di Jerry Marotta scava dentro una traccia abrasa dalle chitarre granulose di Rhodes e cullata dal violino di Shankar, anch’esso filtrato fino a somigliare a poco più che un singulto elettronico. Nell’edizione in CD e musicassetta dell’album, agli sperimentalismi di We Do What We’re Told (Milgram’s 37) faceva seguito This is the Picture (Excellent Birds), adattamento di una traccia che Gabriel aveva scritto con Laurie Anderson per il di lei album Mister Heartbreak (in realtà, la decisione di realizzarne due versioni nasceva dal disaccordo tra i due artisti sulla direzione ritmica da dare al brano. Come ricorda la stessa Anderson, “[me and Gabriel] could never agree on what a bassline was. (I think I probably don’t hear so well down there.) I wanted to learn from him, but it turned into a standoff and so we each put out our own version of the song”.) L’idea di base è, come di consueto, scheletrica e minimalista: alla struttura del brano, imperniata sui synth della Anderson e sulla talking drum di Katché, si aggiungono la chitarra ritmica di Nile Rodgers e il groove prepotente portato dal basso di Bill Laswell.
Come dicevo all’inizio, So appare a tutti gli effetti forgiato entro un’ottica squisitamente progressive, perché è proprio la ricerca musicale a costituirne la spinta fondamentale: il desiderio di mescolare, confondere, straniare, comporre un affresco di profondo portato emotivo attingendo a ispirazioni diversissime tra loro, e mai in maniera semplicistica o puramente strumentale, ma sostanziale. La forza di Sledgehammer non sarebbe tale senza i fiati di Jackson, che fanno letteralmente il pezzo; il forró sotteso a Mercy Street è più di un vezzo world, ma è di fatto la scansione ritmica che rende possibile la parola in quel brano; e le linee di basso di Tony Levin, minimali e esatte, sono essenziali a scavare nel corpo cavo dei brani conferendo loro quella tridimensionalità che ancora oggi, a distanza di 35 anni, li rende clamorosamente moderni (proprio come fossero stati composti ieri). Perché certo, So è un disco di metà anni ’80, in tutto e per tutto; eppure, è un disco di assoluta modernità, e oserei quasi dire contemporaneità: sono senza tempo i sentimenti cantati da Gabriel, ma lo sono anche il drumming di Manu Katché, le soluzioni sonore escogitate da Lanois, il groove del trio Levin/Klein/Laswell. Le prime due parole che mi vengono in mente se penso a questo album sono essenziale e intenso. Potrà sembrare paradossale, data la ricchezza di lavoro che risiede dietro ogni singola traccia dell’album, eppure trovo So un disco estremamente essenziale: elaborato, certamente, tornito accuratamente, ma di fatto esatto, denso, che va direttamente al punto. Per quanta stratificazione ci possa essere in brani come In Your Eyes o Big Time, al fondo dell’equazione c’è l’esattezza del groove, la cellula ritmica, gli spazi che lasciano respirare i brani (non mi voglio ripetere, ma la scansione piena di vuoti della linea di basso di Levin in Red Rain è programmatica di un intero modo di intendere lo spazio, e non solo il tempo): e non c’è mai un elemento di troppo, anche quando ci sono decine di strumenti, contributi, sovraincisioni, spunti, senz’altro anche per merito della produzione di Lanois, capace di fondere armoniosamente tutti le parti di questo lavoro lasciando che all’orecchio dell’ascoltatore arrivi un flusso elegante, disteso, compatto. Allo stesso tempo, per quanto spesso minimalista, So è un disco profondamente intenso, intenso sia nella sua componente lirica (evidente nel cantato di brani quali Red Rain, Don’t Give Up, In Your Eyes o Mercy Street) che nella dimensione più prettamente strumentale: e questo è qualcosa che ha strettamente a che vedere con lo spazio che i musicisti riescono a ritagliarsi, e con la relazione che intercorre tra i vari centri sonori del lavoro. Il fretless di Larry Klein su Mercy Street aggiunge un trasporto emotivo enorme a un brano già estremamente commovente, così come la già citata, monumentale linea di Levin su Red Rain costruisce un ondeggiamento la cui intensità pareggia in potenza quella del sentimento espresso dalla voce roca di Gabriel; allo stesso modo, le ritmiche di Djalma Correa rendono letteralmente possibile Mercy Street, l’arpeggio di Levin in Don’t Give Up dona al brano una leggerezza melodica che ne placa il portato emotivo quasi insostenibile, così come il cantato in wolof di Youssou N’Dour sposta In Your Eyes dentro una dimensione completamente altra, facendola uscire dal boombox di John Cusack per teletrasportarla direttamente nell’empireo dei brani realmente epocali… e la lista potrebbe continuare. Non c’è un solo momento di So che non sia meno che esatto, essenziale e intenso: e per questo, anche a distanza di così tanti anni, questo album non ha ancora finito di dire tutto quello che ha da dire, e aprirne lo scrigno è sempre un po’ come entrare dentro un futuro che è ancora, in qualche modo, (im)possibile.