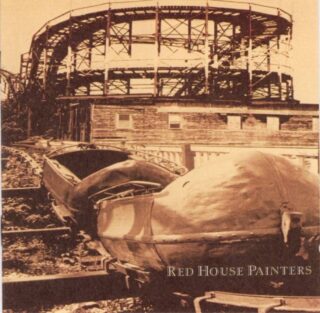i/o is now in the home stretch (it will be officially released on December 1st on all platforms and in all physical formats), and on the occasion of the new moon of last November 13th Peter Gabriel gave us the Bright Side Mix of And Still. Crafted by Mark ‘Spike’ Stent, this Bright Side Mix represents a brighter version of the song proposed on the previous month, with the percussions in clear evidence and Gabriel‘s voice delicately filling the soundscape. In this version, the cello played by New Blood Orchestra’s Ian Burdge resonates even more celestial and pensive, adding a sense of romantic melancholy to this elegant elegy Gabriel dedicated to his mother.
And, in the occasion of the twelfth full moon of 2023, Peter Gabriel released the last track from i/o, titled Live and Let Live, in both Bright Side and Dark Side mixes. I had the occasion to listen to this song for the first time during Peter Gabriel’s gig in Milan, last May (here is my report about that night), and it was one of the most impressive moments in the whole night. Live and Let Live is a wonderful piece about forgiveness, tolerance and optimism, and it closes i/o on a joyous, positive note. The song is accompanied by a mesmerizing artwork called Soundsuit, a work by the Chicago-based artist Nick Cave.
The Smile, a.k.a. Thom Yorke, Jonny Greenwood and Tom Skinner, has announced on November 13th their forthcoming second album Wall of Eyes, available worldwide from 26th January 2024. At the same time, the band has also released the second track from the album, the title-track Wall of Eyes (following the first single, Bending Hectic, that was released last June). Wall of Eyes is a quiet ballad for strummed guitars, deep basses and underground percussions digging a rhythm that runs subtly through the entire structure of the piece, featuring an ending as dissonant as it is light. The song is accompanied by a beautiful, black & white videoclip directed by the acclaimed filmmaker Paul Thomas Anderson, now a long-time collaborator of Yorke & Co. (take a look to the astonishingly beaufitul videoclip for Radiohead’s Daydreaming, if you don’t remember).
As a second anticipation to their new album Mountainhead, scheduled out on March 1st 2024, Everything Everything chose The Mad Stone. Far less rock-oriented than the previous single Cold Reactor, The Mad Stone features a beautiful orchestration by Alex Robertshaw where the vocals creates a sort of “municipal choral sound” (as Jonathan Higgs said in an interview). Following the bandleader ‘s words, This song sets out the grand narrative of the album, wherein a society is forever building an immense mountain, at the cost of living in the resulting giant hole (quarry). The Mad Stone has a slow but menacing and quite apocalyptic pace, in the typical Everything Everything style, and the piece shows an attention to composition and orchestration that is absolutely out of the ordinary.
On November 17, my great friend (and major musical inspiration) Sebastián Tozzola has announced the forthcoming album Paseo del Bajo Vol. 3 (due on December 22), following the second volume published last year (we have covered the whole series here and here). To introduce his new album, Sebastián chose the short yet beautiful glimpse of Sambdombe Lup as a first single. Sambdombe Lup magically blends the traditional candombe rhythms with the contagious joy released by samba, in a short and bright episode suspended between an highly crafted instrumental bass solo showcase and an hummed popular song. As always, Sebastián‘s music does not disappoint and makes you want to listen to everything else as soon as possible!
On November 22, London-based singer and songwriter Matilda Mann has released a new single, Make it Home, explicitly described as a Christmas song. Some of you may remember we talked a lot about Mann’s music in the last months, especially regarding her EP You Look Like You Can’t Swim, which we reviewed here and that we consider one of the heights of this 2023: Make it Home is a warm, delightful guitar ballad, caressed by the strings and blessed by the gorgeous voice by Mann, who confirms herself as a wonderful vocal interpreter as well as a delicate and inspired author. Make it Home is the best way to get into the Christmas atmosphere, slipping into the snowy whiteness of winter landscapes without forgetting the warmth and colors of declining autumn.
Trent’anni di Rollercoaster e Bridge (Red House Painters, 1993)
Se mi venisse chiesto di indicare una band che sia stata davvero decisiva nel mio rapporto con la musica, e con la scrittura per la musica, non potrei esimermi dal parlare dei Red House Painters: la prima band di Mark Kozelek, la prima incarnazione di un talento musicale formidabile che avrebbe percorso i successivi trent’anni sotto varie, affascinanti forme (progetti a nome proprio, svariate collaborazioni e soprattutto quella lunga parte di carriera, che dura tutt’oggi, svolta sotto il moniker di Sun Kil Moon), è stata una delle prime cose che ho scoperto quando mi sono affacciato verso il sommerso del rock indipendente americano, accanto a esperienze come quelle dei Low (altro riferimento assoluto, come saprà bene chi negli anni abbia seguito queste pagine), e la scrittura di 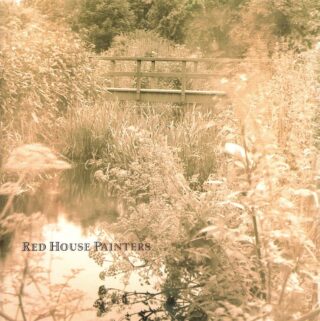 . Un intero universo sonoro e lirico, capace di accarezzare il cuore e sferzarlo, insieme schiaffo e dolcezza, che torna a pulsare anche nelle otto tracce di Bridge che sono nell’insieme più lunghe e difficili, maggiormente votate a una versione spigolosa e mostruosamente dilatata dello slow rock: qui incontriamo le dolcezze espanse della meravigliosa ninnananna Bubble, le inquietanti risate che introducono ad Evil, il baluginare sospeso di Helicopter, una nuova versione sferragliante e arrembante di New Jersey, scavata dalle distorsioni e percossa brutalmente dalla batteria, ma anche la delicatezza folk di un brano come Uncle Joe (quasi un salto nel futuro di Kozelek, la cui musica a venire sarà sempre più sovente abitata da personaggi come lo zio Joe del titolo), l’enigmatica lentezza con la quale sbocciano le mutazioni sonore di Blindfold, e la chiusura affidata a una lacerata versione dell’inno nazionale americano, ennesimo sberleffo a quella Land of Plenty che è sempre più lontano ricordo e sempre meno realtà. Nel mezzo, soprattutto una versione feroce, sovra-satura e travolgente di I Am A Rock di Simon and Garfunkel, cinque minuti e mezzo di un orgasmo ad alto voltaggio che conferisce al compassato brano originale una verve fino ad allora ignota (non me ne vogliamo Paul e Art, né i loro fan). Ci vorrebbero troppe parole per rendere giustizia a due dischi che spiccano tra le vette assolute del cantautorato americano degli anni ’90: a distanza di trent’anni, soprattutto l’esattezza con la quale Kozelek sa scegliere le parole che parlano a ciascuno di noi, e ci sanno far sentire vicino un mondo che sta a diecimila chilometri di distanza soltanto perché la sconfitta ha ovunque lo stesso sapore, e così la solitudine, il dolore, il senso di inadeguatezza, quel sentirsi fuori posto che nessun amore potrà curare mai del tutto ma soltanto, se andrà bene, lenire. Ho trascorso infiniti viaggi in treno con questi dischi nelle cuffie, ed è talmente tanto quello che mi hanno insegnato su me stesso che è inutile cercare di concentrarlo in queste poche righe, sarebbe del tutto inefficace e renderebbe il peggior servizio possibile a una musica che sa dire di se stessa tutto ciò che serve con la sola forza del cuore e delle parole. In occasione di questo trentennale, l’invito è a recuperare questi due dischi (specialmente nel caso non li aveste mai ascoltati) e lasciarvi trascinare dentro un vortice di umano calore come pochi se ne sono sprigionati nella storia della musica popolare. Posso dirvi soltanto che non ve ne pentirete, e che dopo vi sentirete meno soli: in fin dei conti, chi tra noi non si è mai sentito come Kozelek quando cantava Quiet in the corner, numb and falling through/ Without you, what does my life amount to?
. Un intero universo sonoro e lirico, capace di accarezzare il cuore e sferzarlo, insieme schiaffo e dolcezza, che torna a pulsare anche nelle otto tracce di Bridge che sono nell’insieme più lunghe e difficili, maggiormente votate a una versione spigolosa e mostruosamente dilatata dello slow rock: qui incontriamo le dolcezze espanse della meravigliosa ninnananna Bubble, le inquietanti risate che introducono ad Evil, il baluginare sospeso di Helicopter, una nuova versione sferragliante e arrembante di New Jersey, scavata dalle distorsioni e percossa brutalmente dalla batteria, ma anche la delicatezza folk di un brano come Uncle Joe (quasi un salto nel futuro di Kozelek, la cui musica a venire sarà sempre più sovente abitata da personaggi come lo zio Joe del titolo), l’enigmatica lentezza con la quale sbocciano le mutazioni sonore di Blindfold, e la chiusura affidata a una lacerata versione dell’inno nazionale americano, ennesimo sberleffo a quella Land of Plenty che è sempre più lontano ricordo e sempre meno realtà. Nel mezzo, soprattutto una versione feroce, sovra-satura e travolgente di I Am A Rock di Simon and Garfunkel, cinque minuti e mezzo di un orgasmo ad alto voltaggio che conferisce al compassato brano originale una verve fino ad allora ignota (non me ne vogliamo Paul e Art, né i loro fan). Ci vorrebbero troppe parole per rendere giustizia a due dischi che spiccano tra le vette assolute del cantautorato americano degli anni ’90: a distanza di trent’anni, soprattutto l’esattezza con la quale Kozelek sa scegliere le parole che parlano a ciascuno di noi, e ci sanno far sentire vicino un mondo che sta a diecimila chilometri di distanza soltanto perché la sconfitta ha ovunque lo stesso sapore, e così la solitudine, il dolore, il senso di inadeguatezza, quel sentirsi fuori posto che nessun amore potrà curare mai del tutto ma soltanto, se andrà bene, lenire. Ho trascorso infiniti viaggi in treno con questi dischi nelle cuffie, ed è talmente tanto quello che mi hanno insegnato su me stesso che è inutile cercare di concentrarlo in queste poche righe, sarebbe del tutto inefficace e renderebbe il peggior servizio possibile a una musica che sa dire di se stessa tutto ciò che serve con la sola forza del cuore e delle parole. In occasione di questo trentennale, l’invito è a recuperare questi due dischi (specialmente nel caso non li aveste mai ascoltati) e lasciarvi trascinare dentro un vortice di umano calore come pochi se ne sono sprigionati nella storia della musica popolare. Posso dirvi soltanto che non ve ne pentirete, e che dopo vi sentirete meno soli: in fin dei conti, chi tra noi non si è mai sentito come Kozelek quando cantava Quiet in the corner, numb and falling through/ Without you, what does my life amount to?