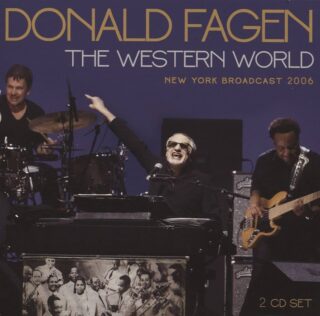Un evento live coinvolgente Donald Fagen (ma più in generale gli Steely Dan) è stato (ed è) un evento più unico che raro: ad eccezione dell’intensa attività live che la band svolse nei primi anni ’70 del secolo scorso, ai tempi dei primi album e prima che la combo si trasformasse in una studio band, e del periodo attorno alla fine degli anni ’90, quando Fagen e Walter Becker si riunirono sul palco per portare in giro per il mondo la propria musica (un prodromo alla stesura e pubblicazione degli ultimi due lavori della band, compreso il celebrato e pluripremiato Two Against Nature del 2000, apice di un periodo nel quale si registrarono anche almeno tre live album), le esibizioni dal vivo di Fagen e della sua creatura più celebre sono sempre state accuratamente centellinate. Su questo fronte, era giunta negli ultimi mesi la notizia che gli Steely Dan (ormai tristemente orfani del buon Becker) avrebbero accompagnato gli Eagles nelle tappe americane dell’ultimo tour della celebre band americana; e poi un po’ in sordina, lo scorso 17 ottobre (io stesso mi sono imbattuto nel disco per caso, in treno, mentre aprivo Spotify per ascoltare altro), l’etichetta Gossip ha dato alle stampe The Western World: New York Broadcast 2006, un meraviglioso documento audio della data live che Fagen, accompagnato da una splendida band, tenne al leggendario Beacon Theather di New York il 7 marzo del 2006, nel contesto del tour legato al suo terzo album solista, Morph The Cat, che sarebbe stato pubblicato la settimana seguente (14 marzo 2006). La data al Beacon Theather (la prima in quindici anni per Fagen, l’ultima apparizione nel celebre teatro risaliva infatti al 1991) fu un evento eccezionale, al punto che tuttora si può trovare online una dettagliata (e divertita) cronaca dell’epoca: per la fortuna delle nostre orecchie, l’intero concerto venne registrato e trasmesso in radio, e il CD appena pubblicato raccoglie questa registrazione, proponendola infine in commercio (in realtà ho scoperto che una release non ufficiale dell’audio della serata era stata pubblicata sul mercato giapponese nel CD intitolato What I Do, sul quale si trovano alcune info online). Per amor di verità, bisogna riconoscere che non si tratta di un episodio isolato. Come già accennato, tra i ’90 e i primi ‘2000 la band produsse tre album live, e giusto un paio di anni fa (correva il 2021) Fagen aveva dato alle stampe due album live registrati nel corso del 2019: uno, Northeast Corridor: Steely Dan Live!, a immortalare il tour degli Steely Dan (già privi di Becker, scomparso nel 2017) e l’altro, The Nightfly: Live (registrato peraltro anch’esso al Beacon Theater), che rappresentava invece un’esecuzione completa del capolavoro del Fagen solista, quel The Nightfly del quale abbiamo parlato giusto un annetto fa. In entrambi i casi performance di classe assoluta, realizzate con band eccezionali al supporto di musica che, pur non essendo automaticamente riconducibile ad alcun genere preciso (o forse proprio in virtù di questo), è ormai da considerare come autenticamente senza tempo. L’evento risiede nel fatto che Fagen ha totalizzato quattro album di studio in un totale di oltre quarant’anni di carriera solista, e resta uno dei grandi autori della canzone popolare americana del secondo dopoguerra. La rarità delle sue esibizioni live non fa che rendere più speciale qualsiasi occasione nella quale queste si verifichino, e qualsiasi documento da esse derivi.
Nel caso della data del Beacon Theater immortalata in questo The Western World: New York Broadcast 2006, Fagen era accompagnato sul palco da un gruppo composto da molti dei session musicians coinvolti anche negli ultimi due lavori degli Steely Dan (oltreché, ovviamente, nello stesso Morph The Cat), per un totale di nove elementi: troviamo dunque Jon Herington e Wayne Krantz alle chitarre, Walt Weiskopf al sax tenore e Micheal Leonhart alla tromba, Cindy Mizelle e Carolyn Leonhart ai cori, Jeff Young alle tastiere, il leggendario Freddie Washington al basso elettrico (se il nome non vi dice nulla, shame on you!, ma soprattutto riascoltatevi la sua linea di basso forse più celebre) e Keith Carlock alla batteria.
L’apertura è affidata alla (quasi) title-track Here at the Western World, un brano piuttosto poco noto degli Steely Dan, incluso nel Greatest Hits del 1978: la versione riproposta da Fagen sul palco del Beacon Theater è sicuramente più trascinante, soprattutto grazie alla ritmica imbastita da Carlock, che fa veleggiare il brano, originariamente una ballad piuttosto classica, verso una dimensione R’n’B-bluesy molto più marcata, con un gran lavoro dei fiati a sottolineare il crescendo verso i ritornelli. Fin dal primo brano si assiste inoltre a una tendenza che sarà un po’ la cifra di ampie parti di questo lavoro, ovvero quella a non riproporre banalmente i brani nella loro forma su disco, ma sfruttarli spesso come tavolozze dalle quali partire per comporre divagazioni, estendere il panorama, allargare il discorso. Here at the Western World si espande così dai circa 4 minuti dell’originale fino a coprire oltre 7 minuti di resa live, con un solo di chitarra strepitoso a tagliarla a metà. In generale, l’esecuzione ha un tiro tesissimo che resterà presente lungo tutta la setlist: avercene di band che tengono il palco con questo piglio… A Here at the Western World segue il super-classico The Nightfly, dall’omonimo leggendario album del 1982: Freddie Washington non fa rimpiangere il lavoro di Marcus Miller sul brano originale, e l’esecuzione subisce una deliziosa e gustosissima deriva verso il jazz dapprima con un coloratissimo solo di chitarra in odore di bebop e poi grazie a un finale rivisitato ed esploso, arricchito soprattutto dai fraseggi della tromba di Leonhart e del sax tenore di Weiskopf. On Green Flower Street, suonata a ruota, assume un piglio molto più groovy anche rispetto alla già splendida versione del disco, che però era in qualche modo più compassata: è di nuovo soprattutto il drumming precisissimo di Carlock a spostare il brano, con chitarre e basso a dare il necessario movimento replicando in questo caso abbastanza rispettosamente le linee originali, fino a un finale con una serie di finti stop, gestiti da Fagen con il piglio del consumato direttore d’orchestra. Sempre da The Nightfly proviene la successiva, splendida New Frontier (uno di quei brani che non necessitano di introduzione), riproposta ancora in maniera molto rispettosa del testo originale, ma alla quale fa seguito una rilettura rallentata di Third World Man (direttamente dal bellissimo Gaucho, del 1980), introdotta da un breve momento solista delle tastiere: la voce di Fagen scivola un po’ gigioneggiando sulla celebre linea melodica, accompagnata da un bel lavoro dei fiati (e in particolare della tromba di Leonhart, che riempie le partiture dei brani di tanti piccoli dettagli di gran gusto), e Krantz non fa rimpiangere il maestoso solo originariamente suonato da Larry Carlton (per il quale ovviamente non ci sono parole ma d’altra parte, com’è noto, Carlton ha partorito solo meraviglie), replicato con lo stesso rispetto filologico che si deve alle grandi opere d’arte e con la convinzione, peraltro fondata, che non si possano trovare linee migliori. Al termine di Third World Man, Fagen si prende del tempo per introdurre la band, scherzando sull’abbigliamento total black dei suoi musicisti ([they] want to be different) e sul loro comune status di local favorites (a New York o in California, poco importa). Giunge quindi il momento di un altro classico senza tempo, Home At Last, direttamente da Aja: Carlock si confronta con il leggendario half-time shuffle di Bernard Purdie e vince la sfida (o quanto meno la pareggia, sempre che si possa anche solo pareggiare Purdie). Home At Last funziona ancora a meraviglia a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua composizione, e questa è caratteristica propria di quei soli brani che sono ormai diventati classici senza tempo: la tromba di Leonhart riesce comunque a rubare tutta la scena nella sezione del solo, portando il brano verso regioni puramente jazz, e dandosi il cambio con un solo di chitarra di Krantz che sembra un po’ voler edificare un autentico botta-e-risposta con i fiati.
A questo punto arriva il primo estratto da Morph The Cat, Brite Nitegown: il curioso titolo si deve a W.C. Fields, che usava definire la morte “the fellow in the brite nightgown”, “il tipo con la vestaglia luminosa”, frase che Fagen aveva incontrato leggendo una biografia del celebre comico e scrittore americano. In effetti nel corso del brano si ripete più volte il verso With the fella in the brite nitegown, che introduce ai ritornelli: Brite Nitegown è un funk/R’n’B che gira alla perfezione, un incastro perfetto e ispiratissimo dotato di uno splendido bridge strumentale sul quale sono di nuovo i fiati prima e le chitarre poi a ricamare musica, con Krantz soprattutto che si produce in un altro bellissimo intervento solista. Gli interventi di Krantz e Herington continuano a scandire il brano anche nella sua pronunciata coda finale, intervallandosi alla riproposizione dei ritornelli, affidata integralmente alle voci di Mizelle e Leonhart. Quando poi Fagen invita un ospite a sorpresa a salire sul palco, il pensiero vola subito al grande assente Walter Becker: e invece l’artista in questione è la beautiful, and talented and actually pretty dangerous Martha Wainwright, che si unisce alla band per proporre una versione piuttosto inquietante della bellissima Year of the Dragon, già incisa con la madre Kate McGarrigle (la si può ascoltare qui). Fagen, che accompagna la Wainwright suonando la melodica, definirà il brano (al termine dell’esecuzione) una scary song, e qualcuno nelle prime file deve aver poco gradito questa divagazione (invero abbastanza distante dal mood dei brani del cantautore americano) se a un certo punto lo stesso bandleader deve ringhiare un divertito ma poco convinto WHAT? WHAT? rivolto presumibilmente a qualche lieve cenno di contestazione (purtroppo non udibile nella registrazione); segno, anche questo, che tutto il mondo (e ogni platea) è paese. L’armonia però torna a ristabilirsi subito, quando la band attacca un altro classico degli Steely Dan, quella FM che era stata parte della colonna sonora dell’omonimo film del 1978: poche note di piano, la cassa di Carlock, i fioretti delle chitarre e la voce di Fagen ritrasportano magicamente l’uditorio nella magia di fine anni ’70, con un R’n’B funky e groovy, addolcito dal lavoro di Leonhart alla tromba e Weiskopf al sax tenore (protagonista di un solo magnetico e affascinante). A questo punto la band propone altri due brani provenienti da Morph The Cat, ovvero H Gang e What I Do: la prima si apre su una intro R’n’B decisamente soulful per poi evolvere in un funk di gran carattere e gran tiro, con uno splendido intreccio delle voci di Fagen insieme a Cindy Mizelle e Carolyn Leonhart nei ritornelli e, soprattutto, un altro straordinario solo di Weiskopf, dai colori decisamente jazz, seguito da un brevissimo e magico fraseggio di chitarra elettrica; la seconda è invece dedicata a Ray Charles (del quale cita in parte il celebre titolo What I’d Say, e che Fagen considera una propria importantissima influenza: “I think Ray Charles was one of the most mysterious people ever. Just watching him, the way his body moves – for a kid from New Jersey to see that kind of passion, that was really revelatory for me. At that point I was living in the suburbs, and even though I was a jazz fan when I was very young, and used to hearing passionate performances on records, the general tendency of jazz in the Fifties was cool, so seeing Ray Charles, who had that much gospel in his style, you could tell he was utterly authentic. So yeah, he had a huge influence on me.”), e ha colori blues che la avvicinano a molta della produzione dell’artista americano (io, fresco di Pistoia Blues Clinics 2023, ci ho sentito qualcosa di Rainy Night in Georgia, che ho avuto il piacere di suonare sul palco di Serravalle Pistoiese sotto la direzione artistica di Walter Calloni). Al blues di What I Do fa seguito un altro brano proveniente dalla tracklist di The Nightfly, ovvero The Goodbye Look: la bossa con tinte caraibiche e vaghezze da spy-story del brano originale diventa il trapezio (senza rete) sul quale i musicisti possono volteggiare, espandendo la lectio originale e arricchendola. “We be master-jammin’!”, dichiarerà un Fagen parecchio entusiasta al termine dell’esecuzione: e in effetti gli oltre 8 minuti del brano, durata quasi raddoppiata rispetto all’incisione su disco, costituiscono un’ottima occasione per la band di rivisitare il testo originale conferendogli una gamma di colori ancora più brillanti. Intendiamoci, non è che il quasi-reggae di The Goodbye Look avesse bisogno di particolari reinvenzioni per suonare trascinante: ma la band riesce magicamente a prendere il pezzo e portarlo su un altro livello, trasformandolo quanto basta da renderne l’ascolto un’esperienza totalmente nuova, che si vorrebbe non finisse mai, soprattutto grazie a Washington e alle chitarre, che aprono la strada per una lunga coda strumentale e totalmente improvvisata. Qui è proprio la qualità dell’interplay tra i musicisti a fare la differenza, e gli ultimi minuti dell’esecuzione scorrono piacevolissimi sebbene assolutamente strumentali: la grande inventiva di Herington e Krantz sposa l’inesauribile senso ritmico di Washington e la jam si allunga oltremisura, senza annoiare nemmeno per un secondo, con tanto di svisate di Fagen all’organo. A chiudere il set giunge la riproposizione del quinto brano tratto da The Nightfly, I.G.Y. : scandita dai bassi profondissimi di Washington e dalle celebri, irresistibili chitarre reggae, I.G.Y. è un’altra di quelle canzoni che non invecchiano mai, e non hanno perso niente del loro smalto originale. Anche qui incontriamo un solo debordante e bellissimo del sax tenore di Weiskopf, e il lavoro dei cori è strabiliante nel restituire il sapore dell’originale, per non parlare della splendida coda strumentale sulla quale il brano va delicatamente a spengersi.
Il disco immortala anche il breve encore che chiuse la serata, comprendente uno dei grandi classici del repertorio degli Steely Dan, Pretzel Logic, e una cover di Chuck Berry, Viva Viva Rock’n’Roll. La prima (il brano più vecchio dei Dan presente in scaletta) scatena l’entusiasmo incontenibile del pubblico: quale canzone migliore di una che parla dell’impossibilità di replicare lo splendore dei tempi andati, mescolandola con la sensazione di sentirsi fuori sincrono col proprio tempo e con quell’ironia obliqua che da sempre è stata un marchio di fabbrica delle produzioni del duo Fagen/Becker, per chiudere una serata che era sì pensata come una serata di musica live nel presente (in fondo c’era un album, Morph The Cat, da presentare) ma che alla fine era diventata anche un gran tuffo in un passato condiviso di bellissima musica? Il divertissement di Viva Viva Rock’n’Roll, con la band impegnata a giocare con il classico di Berry, sembra invece parzialmente rispondere a quel vago senso di nostalgia che si impossessa degli ascoltatori dopo Pretzel Logic: solo se non si perde la capacità di mettere tutta la propria serietà nel gioco, proprio come si faceva da bambini, ci si può mantenere vivi.
La sensazione che si respira in queste sedici tracce (quindici se togliamo la presentazione della band, ma a vedere le setlist di altre date dello stesso tour, di durata decisamente maggiore, mi viene da pensare che, nella stesura della tracklist per questo CD, si siano fatte delle omissioni e sia stata operata una selezione del materiale) è che Donald Fagen si sia sinceramente divertito sul palco del Beacon Theater: contrariamente a quello che ci si sarebbe potuti aspettare per uno che ha più volte manifestato sintomi di “intolleranza” per il palco, e che con la band non ha fatto tour per oltre vent’anni, il buon Donald pare estremamente a suo agio nel corso dell’esecuzione di questi brani. Probabilmente il suo lo ha fatto anche la location: il Beacon Theater, con i suoi 2600 posti, è in realtà un ambiente piuttosto raccolto, quasi intimo, ideale per il piglio da crooner nostalgico di uno come Fagen. Sulle doti di songwriter del nostro benemerito Lester the Nightfly, tutto (e il contrario di tutto) si è già detto e scritto: con quel distacco sarcastico che da sempre lo ha contraddistinto, Fagen gestisce la serata e il palco come un consumato cantante da fumoso jazz club anni ’80, coadiuvato da una band stratosferica composta da musicisti in stato di grazia. Ascoltare le linee di basso di Freddie Washington è sempre un piacere, figurarsi quando queste si incastrano nel drumming geometrico e impeccabile di Keith Carlock; le chitarre di Jon Herington e Wayne Krantz giocano a rincorrersi lungo i groove e a scambiarsi gli assoli, in costante bilico tra sfumature blues e fraseggio bebop; e poi ci sono i fiati di Walt Weiskopf e Michael Leonhart, che davvero cambiano l’atmosfera ai pezzi, conferendo un calore e una quantità di nuances che rendono questa musica ancora più vitale di quanto essa già non sia; e sorvoliamo sulle voci calde e bellissime di Cindy Mizelle e Carolyn Leonhart, sia quando supportano il cantato di Fagen sia quando, soprattutto, se ne svincolano, gestendo da sole intere parti di melodia, per non parlare dello sfolgorante talento di Jeff Young, purtroppo recentemente scomparso. A guidare questa nave colma di musicisti di gran classe, quello con più classe di tutti: ineffabile, istrionico almeno quanto laconico, divertito e sarcastico che si tratti di presentare la band o di fare la ramanzina a qualche personaggio un po’ infervorato presente nel pubblico, onestamente entusiasta quanto simpaticamente guascone, lo spettacolo lo fa tutto Donald Fagen, che è ancora, a 75 anni, un talento sfolgorante e una benedizione sia come compositore che come songwriter, o forse sarebbe meglio dire “narratore” di storie. The Western World: New York Broadcast 2006 diventa così un documento imprescindibile che immortala una band in stato di grazia insieme a un compositore tra i massimi dell’universo pop degli ultimi 50 anni (e oltre), la dimostrazione che può esistere ancora musica bellissima composta con gran gusto e suonata con classe spaziale e che continua a parlare a noi tutti dei sentimenti primari che sperimentiamo come esseri umani, che siano essi la nostalgia, la malinconia, la speranza (nel futuro, ad esempio), la mortalità, la finitezza. Dietro una cortina fumogena di groove scintillante e funk irresistibile, la scrittura di Donald Fagen ha sempre saputo mantenersi in poetico e grottesco equilibrio tra sarcasmo, gusto del racconto e vertigine introspettiva: e far girare questo disco nelle cuffie ci fa sentire proprio come se il buon Donald sussurrasse tutto questo direttamente nelle nostre orecchie, dando alle sue storie la forma di alcune tra le canzoni più belle che siano state scritte nella storia della musica popolare.